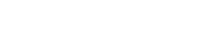Guarda e rispondi
Dove si ebbe il maggior sviluppo di Comuni e Signorie e perché?
Come si può spiegare il differente sviluppo economico che ha caratterizzato da un lato i territori centro-settentrionali soggetti all’Impero, dall’altro i territori meridionali contesi da Angioini e Aragonesi?
Legenda
Il Settentrione e parte del Centro della Penisola erano territori formalmente soggetti all’Impero.
L’affermazione degli istituti comunali fu precoce, già alla fine dell’XI secolo venne creata una magistratura consolare. In seguito, il Comune di Milano divenne egemone nell’area padana, risultando il principale avversario dell’imperatore Federico Barbarossa. Il Comune non seppe però risolvere i contrasti interni, neppure con l’istituzione del podestà nel 1186 e lasciò così spazio all’affermazione del potere signorile, prima da parte di Martino della Torre, e poi nel 1277, di Ottone Visconti, capostipite della dinastia che governò Milano fino al 1447. Milano nel corso del Duecento si affermò come principale centro metallurgico e tessile della Penisola.
Nel X secolo, le «compagnie», organizzazioni militari e commerciali, acquisirono il governo della città che si costituì come repubblica marinara. Gli scontri tra le famiglie più importanti portarono nel 1191 all’istituzione del podestà. Tra il Duecento e il Trecento Genova potenziò le sue flotte ed estese le sue rotte.
La Repubblica di Venezia raggiunse l’apice della potenza nel Duecento quando ottenne il controllo delle città e delle rotte più importanti nell’Adriatico e nel Mediterraneo. Nel Trecento la Repubblica estese il proprio dominio anche verso la terraferma. Il magistrato supremo di Venezia era il doge, ma la fonte del potere era l’assemblea popolare affiancata da un Consiglio dei Savi e poi dal Maggior Consiglio, che nel tempo divenne una vera e propria oligarchia.
Ottenne il primo riconoscimento delle libertà comunali da parte di Matilde di Canossa durante la lotta per le investiture. Tra il Duecento e il Trecento il Comune fu caratterizzato da continui scontri tra le fazioni cittadine che culminarono nel 1378 con il tumulto dei Ciompi. La repressione della rivolta popolare portò all’affermazione di un governo oligarchico e nel Quattrocento alla Signoria dei Medici (1434). Importanti per le vicende politiche ed economiche della città furono i legami finanziari tra la curia romana e i mercanti e i banchieri fiorentini.
Nel XII secolo l’autorità del vescovo venne sostituita da quella del Comune, governato dai consoli che estesero il dominio della città al territorio circostante, dando origine al conflitto con Firenze (proseguito fino al 1269).
Durante il Duecento lo Stato Pontificio si era ampliato verso nord e conobbe le lotte fra le famiglie aristocratiche romane.
Il lungo periodo di assenza del papa (1309-1377) portò a un sensibile indebolimento della sua autorità. Nel 1357 le Costituzioni egidiane gettarono le basi dello Stato Pontificio, ma nel periodo successivo il papato fu impegnato soprattutto in questioni di politica internazionale o nel difendere la propria autorità. Una concreta riforma dello Stato dello Chiesa fu anche impedita dalla pratica ormai radicata del nepotismo.
La presenza della monarchia sveva e successivamente angioina soffocò qualsiasi velleità di autonomia cittadina. Le principali città erano Napoli e Bari, in cui lavoravano artigiani e mercanti che gestivano commerci a livello europeo, ma la presenza di una nobiltà arroccata sui propri privilegi impedì lo sviluppo e la modernizzazione dello Stato, imponendo il latifondo e l’agricoltura estensiva, poco redditizia.
Dopo il conflitto contro gli Angioini, che si protrasse per vent’anni, nel 1302 la Sicilia venne affidata alla casata d’Aragona, mentre il Regno di Napoli restò in mano francese. L’isola continuò tuttavia a essere contesa fra Angioini e Aragonesi: la guerra, infatti, tornò a esplodere nel 1312 e si protrasse per altri sessant’anni, fino al 1372, quando Giovanna I d’Angiò rinunciò definitivamente ai diritti sulla Sicilia.