Prova di ITALIANO cl 5ª
Per svolgere l’intera Prova si hanno a disposizione 75 minuti
1
5
10
15
20
25
30
35
40
1La notte dopo il suo primo giorno di scuola Marcus si svegliò ogni mezz’orao quasi. Se ne accorse dalle lancette luminose del suo orologio. Non riu-sciva a credere che sarebbe dovuto ritornare la mattina dopo e la mattinadopo ancora e… be’, poi ci sarebbe stato il week-end, ma in un modo onell’altro ogni mattina per il resto della sua vita, più o meno. Ogni volta chesi svegliava il suo primo pensiero era che ci doveva essere un sistema persuperare quell’orribile sensazione, o aggirarla, o anche conviverci; ogni voltache si era agitato per qualcosa in passato, di solito era sempre saltata fuoriuna qualche risposta, che di solito prevedeva di raccontare a sua mammache cosa lo preoccupava. Ma questa volta non c’era niente che lei potessefare. Non l’avrebbe trasferito in un’altra scuola, e comunque le cose nonsarebbero cambiate granché. Lui sarebbe rimasto com’era, e questo, glisembrava, era il problema di fondo. Semplice: non era fatto per la scuola.Tutto qui. E come facevi a spiegarlo? Potevi non essere adatto per alcunecose (sapeva già di non essere adatto per le feste perché era troppo timido,o per i pantaloni larghi, perché aveva le gambe troppo corte), ma non esserefatto per la scuola era un problema grosso. Tutti andavano a scuola. Nonc’era verso di evitarla.2Per tutta la notte i suoi pensieri furono come un boomerang: un’idea sfrec-ciava via lontana dalla scuola e dalla realtà e lo rendeva felice, poi però co-minciava il viaggio di ritorno e il suo tormento si rifaceva vivo. E il mattinocontinuava implacabile ad avvicinarsi. A colazione rimase in silenzio. – Tiabituerai – disse sua mamma, probabilmente perché si accorse che aveval’aria triste mentre mangiava i cereali. Lui annuì e le sorrise. Arrivò a scuolapresto, andò in classe, si sedette al suo banco. Lì era abbastanza al sicuro.Era improbabile che i ragazzi che lo avevano infastidito il giorno prima fosserodi quelli che arrivavano a scuola presto; erano di sicuro da qualcheparte a bighellonare o infastidire la gente, pensò.3Nell’aula c’erano un paio di ragazze, che però lo ignorarono, a meno che larisata che udì mentre tirava fuori il libro di lettura non avesse qualcosa ache fare con lui. Cosa c’era da ridere? Niente, se non eri il tipo che andavasempre alla ricerca di qualcosa di cui ridere. Sfortunatamente, però, i ragazziche aveva conosciuto Marcus erano quasi tutti così. Pattugliavano su e giùi corridoi alla ricerca di pantaloni sbagliati o pettinature sbagliate o scarpeda ginnastica sbagliate. Dato che di solito Marcus indossava le scarpe sbagliateo i pantaloni sbagliati e il suo taglio di capelli era immancabilmentesbagliato, non doveva far molto per farli divertire. Marcus sapeva di esserestrambo ma sua madre non lo capiva affatto.Gli ripeteva sempre che solo le persone superficiali giudicano dai vestiti odai capelli; gli proibiva di guardare la televisione spazzatura, o di ascoltaremusica spazzatura o di giocare con videogiochi spazzatura: questo significavache se voleva fare qualsiasi cosa facevano tutti gli altri ragazzi, lui dovevadiscutere con lei per ore. Di solito perdeva, ma lei era così brava adiscutere che non gli dispiaceva perdere.
Riad. da Nick Hornby, Un ragazzo, Tea
L’ANSIA DELLA SCUOLA
5
10
15
20
25
30
35
40
1La notte dopo il suo primo giorno di scuola Marcus si svegliò ogni mezz’orao quasi. Se ne accorse dalle lancette luminose del suo orologio. Non riu-sciva a credere che sarebbe dovuto ritornare la mattina dopo e la mattinadopo ancora e… be’, poi ci sarebbe stato il week-end, ma in un modo onell’altro ogni mattina per il resto della sua vita, più o meno. Ogni volta chesi svegliava il suo primo pensiero era che ci doveva essere un sistema persuperare quell’orribile sensazione, o aggirarla, o anche conviverci; ogni voltache si era agitato per qualcosa in passato, di solito era sempre saltata fuoriuna qualche risposta, che di solito prevedeva di raccontare a sua mammache cosa lo preoccupava. Ma questa volta non c’era niente che lei potessefare. Non l’avrebbe trasferito in un’altra scuola, e comunque le cose nonsarebbero cambiate granché. Lui sarebbe rimasto com’era, e questo, glisembrava, era il problema di fondo. Semplice: non era fatto per la scuola.Tutto qui. E come facevi a spiegarlo? Potevi non essere adatto per alcunecose (sapeva già di non essere adatto per le feste perché era troppo timido,o per i pantaloni larghi, perché aveva le gambe troppo corte), ma non esserefatto per la scuola era un problema grosso. Tutti andavano a scuola. Nonc’era verso di evitarla.2Per tutta la notte i suoi pensieri furono come un boomerang: un’idea sfrec-ciava via lontana dalla scuola e dalla realtà e lo rendeva felice, poi però co-minciava il viaggio di ritorno e il suo tormento si rifaceva vivo. E il mattinocontinuava implacabile ad avvicinarsi. A colazione rimase in silenzio. – Tiabituerai – disse sua mamma, probabilmente perché si accorse che aveval’aria triste mentre mangiava i cereali. Lui annuì e le sorrise. Arrivò a scuolapresto, andò in classe, si sedette al suo banco. Lì era abbastanza al sicuro.Era improbabile che i ragazzi che lo avevano infastidito il giorno prima fosserodi quelli che arrivavano a scuola presto; erano di sicuro da qualcheparte a bighellonare o infastidire la gente, pensò.3Nell’aula c’erano un paio di ragazze, che però lo ignorarono, a meno che larisata che udì mentre tirava fuori il libro di lettura non avesse qualcosa ache fare con lui. Cosa c’era da ridere? Niente, se non eri il tipo che andavasempre alla ricerca di qualcosa di cui ridere. Sfortunatamente, però, i ragazziche aveva conosciuto Marcus erano quasi tutti così. Pattugliavano su e giùi corridoi alla ricerca di pantaloni sbagliati o pettinature sbagliate o scarpeda ginnastica sbagliate. Dato che di solito Marcus indossava le scarpe sbagliateo i pantaloni sbagliati e il suo taglio di capelli era immancabilmentesbagliato, non doveva far molto per farli divertire. Marcus sapeva di esserestrambo ma sua madre non lo capiva affatto.Gli ripeteva sempre che solo le persone superficiali giudicano dai vestiti odai capelli; gli proibiva di guardare la televisione spazzatura, o di ascoltaremusica spazzatura o di giocare con videogiochi spazzatura: questo significavache se voleva fare qualsiasi cosa facevano tutti gli altri ragazzi, lui dovevadiscutere con lei per ore. Di solito perdeva, ma lei era così brava adiscutere che non gli dispiaceva perdere.
Riad. da Nick Hornby, Un ragazzo, Tea
A1 Il protagonista è in ansia perché:
A. la mattina dopo dovrà tornare a scuola.
B. la mattina dopo ancora dovrà tornare a scuola.
C. dovrà tornare a scuola tutte le mattine.
D. la scuola sta per finire.
1
5
10
15
20
25
30
35
40
1La notte dopo il suo primo giorno di scuola Marcus si svegliò ogni mezz’orao quasi. Se ne accorse dalle lancette luminose del suo orologio. Non riu-sciva a credere che sarebbe dovuto ritornare la mattina dopo e la mattinadopo ancora e… be’, poi ci sarebbe stato il week-end, ma in un modo onell’altro ogni mattina per il resto della sua vita, più o meno. Ogni volta chesi svegliava il suo primo pensiero era che ci doveva essere un sistema persuperare quell’orribile sensazione, o aggirarla, o anche conviverci; ogni voltache si era agitato per qualcosa in passato, di solito era sempre saltata fuoriuna qualche risposta, che di solito prevedeva di raccontare a sua mammache cosa lo preoccupava. Ma questa volta non c’era niente che lei potessefare. Non l’avrebbe trasferito in un’altra scuola, e comunque le cose nonsarebbero cambiate granché. Lui sarebbe rimasto com’era, e questo, glisembrava, era il problema di fondo. Semplice: non era fatto per la scuola.Tutto qui. E come facevi a spiegarlo? Potevi non essere adatto per alcunecose (sapeva già di non essere adatto per le feste perché era troppo timido,o per i pantaloni larghi, perché aveva le gambe troppo corte), ma non esserefatto per la scuola era un problema grosso. Tutti andavano a scuola. Nonc’era verso di evitarla.2Per tutta la notte i suoi pensieri furono come un boomerang: un’idea sfrec-ciava via lontana dalla scuola e dalla realtà e lo rendeva felice, poi però co-minciava il viaggio di ritorno e il suo tormento si rifaceva vivo. E il mattinocontinuava implacabile ad avvicinarsi. A colazione rimase in silenzio. – Tiabituerai – disse sua mamma, probabilmente perché si accorse che aveval’aria triste mentre mangiava i cereali. Lui annuì e le sorrise. Arrivò a scuolapresto, andò in classe, si sedette al suo banco. Lì era abbastanza al sicuro.Era improbabile che i ragazzi che lo avevano infastidito il giorno prima fosserodi quelli che arrivavano a scuola presto; erano di sicuro da qualcheparte a bighellonare o infastidire la gente, pensò.3Nell’aula c’erano un paio di ragazze, che però lo ignorarono, a meno che larisata che udì mentre tirava fuori il libro di lettura non avesse qualcosa ache fare con lui. Cosa c’era da ridere? Niente, se non eri il tipo che andavasempre alla ricerca di qualcosa di cui ridere. Sfortunatamente, però, i ragazziche aveva conosciuto Marcus erano quasi tutti così. Pattugliavano su e giùi corridoi alla ricerca di pantaloni sbagliati o pettinature sbagliate o scarpeda ginnastica sbagliate. Dato che di solito Marcus indossava le scarpe sbagliateo i pantaloni sbagliati e il suo taglio di capelli era immancabilmentesbagliato, non doveva far molto per farli divertire. Marcus sapeva di esserestrambo ma sua madre non lo capiva affatto.Gli ripeteva sempre che solo le persone superficiali giudicano dai vestiti odai capelli; gli proibiva di guardare la televisione spazzatura, o di ascoltaremusica spazzatura o di giocare con videogiochi spazzatura: questo significavache se voleva fare qualsiasi cosa facevano tutti gli altri ragazzi, lui dovevadiscutere con lei per ore. Di solito perdeva, ma lei era così brava adiscutere che non gli dispiaceva perdere.
Riad. da Nick Hornby, Un ragazzo, Tea
L’ANSIA DELLA SCUOLA
5
10
15
20
25
30
35
40
1La notte dopo il suo primo giorno di scuola Marcus si svegliò ogni mezz’orao quasi. Se ne accorse dalle lancette luminose del suo orologio. Non riu-sciva a credere che sarebbe dovuto ritornare la mattina dopo e la mattinadopo ancora e… be’, poi ci sarebbe stato il week-end, ma in un modo onell’altro ogni mattina per il resto della sua vita, più o meno. Ogni volta chesi svegliava il suo primo pensiero era che ci doveva essere un sistema persuperare quell’orribile sensazione, o aggirarla, o anche conviverci; ogni voltache si era agitato per qualcosa in passato, di solito era sempre saltata fuoriuna qualche risposta, che di solito prevedeva di raccontare a sua mammache cosa lo preoccupava. Ma questa volta non c’era niente che lei potessefare. Non l’avrebbe trasferito in un’altra scuola, e comunque le cose nonsarebbero cambiate granché. Lui sarebbe rimasto com’era, e questo, glisembrava, era il problema di fondo. Semplice: non era fatto per la scuola.Tutto qui. E come facevi a spiegarlo? Potevi non essere adatto per alcunecose (sapeva già di non essere adatto per le feste perché era troppo timido,o per i pantaloni larghi, perché aveva le gambe troppo corte), ma non esserefatto per la scuola era un problema grosso. Tutti andavano a scuola. Nonc’era verso di evitarla.2Per tutta la notte i suoi pensieri furono come un boomerang: un’idea sfrec-ciava via lontana dalla scuola e dalla realtà e lo rendeva felice, poi però co-minciava il viaggio di ritorno e il suo tormento si rifaceva vivo. E il mattinocontinuava implacabile ad avvicinarsi. A colazione rimase in silenzio. – Tiabituerai – disse sua mamma, probabilmente perché si accorse che aveval’aria triste mentre mangiava i cereali. Lui annuì e le sorrise. Arrivò a scuolapresto, andò in classe, si sedette al suo banco. Lì era abbastanza al sicuro.Era improbabile che i ragazzi che lo avevano infastidito il giorno prima fosserodi quelli che arrivavano a scuola presto; erano di sicuro da qualcheparte a bighellonare o infastidire la gente, pensò.3Nell’aula c’erano un paio di ragazze, che però lo ignorarono, a meno che larisata che udì mentre tirava fuori il libro di lettura non avesse qualcosa ache fare con lui. Cosa c’era da ridere? Niente, se non eri il tipo che andavasempre alla ricerca di qualcosa di cui ridere. Sfortunatamente, però, i ragazziche aveva conosciuto Marcus erano quasi tutti così. Pattugliavano su e giùi corridoi alla ricerca di pantaloni sbagliati o pettinature sbagliate o scarpeda ginnastica sbagliate. Dato che di solito Marcus indossava le scarpe sbagliateo i pantaloni sbagliati e il suo taglio di capelli era immancabilmentesbagliato, non doveva far molto per farli divertire. Marcus sapeva di esserestrambo ma sua madre non lo capiva affatto.Gli ripeteva sempre che solo le persone superficiali giudicano dai vestiti odai capelli; gli proibiva di guardare la televisione spazzatura, o di ascoltaremusica spazzatura o di giocare con videogiochi spazzatura: questo significavache se voleva fare qualsiasi cosa facevano tutti gli altri ragazzi, lui dovevadiscutere con lei per ore. Di solito perdeva, ma lei era così brava adiscutere che non gli dispiaceva perdere.
Riad. da Nick Hornby, Un ragazzo, Tea
A2 Rileggi con attenzione il testo:
«superare quell’orribile sensazione, o aggirarla, o anche conviverci»
La sensazione è vissuta come:
«superare quell’orribile sensazione, o aggirarla, o anche conviverci»
La sensazione è vissuta come:
A. una macchina.
B. un ostacolo.
C. una famiglia.
D. un mostro.
1
5
10
15
20
25
30
35
40
1La notte dopo il suo primo giorno di scuola Marcus si svegliò ogni mezz’orao quasi. Se ne accorse dalle lancette luminose del suo orologio. Non riu-sciva a credere che sarebbe dovuto ritornare la mattina dopo e la mattinadopo ancora e… be’, poi ci sarebbe stato il week-end, ma in un modo onell’altro ogni mattina per il resto della sua vita, più o meno. Ogni volta chesi svegliava il suo primo pensiero era che ci doveva essere un sistema persuperare quell’orribile sensazione, o aggirarla, o anche conviverci; ogni voltache si era agitato per qualcosa in passato, di solito era sempre saltata fuoriuna qualche risposta, che di solito prevedeva di raccontare a sua mammache cosa lo preoccupava. Ma questa volta non c’era niente che lei potessefare. Non l’avrebbe trasferito in un’altra scuola, e comunque le cose nonsarebbero cambiate granché. Lui sarebbe rimasto com’era, e questo, glisembrava, era il problema di fondo. Semplice: non era fatto per la scuola.Tutto qui. E come facevi a spiegarlo? Potevi non essere adatto per alcunecose (sapeva già di non essere adatto per le feste perché era troppo timido,o per i pantaloni larghi, perché aveva le gambe troppo corte), ma non esserefatto per la scuola era un problema grosso. Tutti andavano a scuola. Nonc’era verso di evitarla.2Per tutta la notte i suoi pensieri furono come un boomerang: un’idea sfrec-ciava via lontana dalla scuola e dalla realtà e lo rendeva felice, poi però co-minciava il viaggio di ritorno e il suo tormento si rifaceva vivo. E il mattinocontinuava implacabile ad avvicinarsi. A colazione rimase in silenzio. – Tiabituerai – disse sua mamma, probabilmente perché si accorse che aveval’aria triste mentre mangiava i cereali. Lui annuì e le sorrise. Arrivò a scuolapresto, andò in classe, si sedette al suo banco. Lì era abbastanza al sicuro.Era improbabile che i ragazzi che lo avevano infastidito il giorno prima fosserodi quelli che arrivavano a scuola presto; erano di sicuro da qualcheparte a bighellonare o infastidire la gente, pensò.3Nell’aula c’erano un paio di ragazze, che però lo ignorarono, a meno che larisata che udì mentre tirava fuori il libro di lettura non avesse qualcosa ache fare con lui. Cosa c’era da ridere? Niente, se non eri il tipo che andavasempre alla ricerca di qualcosa di cui ridere. Sfortunatamente, però, i ragazziche aveva conosciuto Marcus erano quasi tutti così. Pattugliavano su e giùi corridoi alla ricerca di pantaloni sbagliati o pettinature sbagliate o scarpeda ginnastica sbagliate. Dato che di solito Marcus indossava le scarpe sbagliateo i pantaloni sbagliati e il suo taglio di capelli era immancabilmentesbagliato, non doveva far molto per farli divertire. Marcus sapeva di esserestrambo ma sua madre non lo capiva affatto.Gli ripeteva sempre che solo le persone superficiali giudicano dai vestiti odai capelli; gli proibiva di guardare la televisione spazzatura, o di ascoltaremusica spazzatura o di giocare con videogiochi spazzatura: questo significavache se voleva fare qualsiasi cosa facevano tutti gli altri ragazzi, lui dovevadiscutere con lei per ore. Di solito perdeva, ma lei era così brava adiscutere che non gli dispiaceva perdere.
Riad. da Nick Hornby, Un ragazzo, Tea
L’ANSIA DELLA SCUOLA
5
10
15
20
25
30
35
40
1La notte dopo il suo primo giorno di scuola Marcus si svegliò ogni mezz’orao quasi. Se ne accorse dalle lancette luminose del suo orologio. Non riu-sciva a credere che sarebbe dovuto ritornare la mattina dopo e la mattinadopo ancora e… be’, poi ci sarebbe stato il week-end, ma in un modo onell’altro ogni mattina per il resto della sua vita, più o meno. Ogni volta chesi svegliava il suo primo pensiero era che ci doveva essere un sistema persuperare quell’orribile sensazione, o aggirarla, o anche conviverci; ogni voltache si era agitato per qualcosa in passato, di solito era sempre saltata fuoriuna qualche risposta, che di solito prevedeva di raccontare a sua mammache cosa lo preoccupava. Ma questa volta non c’era niente che lei potessefare. Non l’avrebbe trasferito in un’altra scuola, e comunque le cose nonsarebbero cambiate granché. Lui sarebbe rimasto com’era, e questo, glisembrava, era il problema di fondo. Semplice: non era fatto per la scuola.Tutto qui. E come facevi a spiegarlo? Potevi non essere adatto per alcunecose (sapeva già di non essere adatto per le feste perché era troppo timido,o per i pantaloni larghi, perché aveva le gambe troppo corte), ma non esserefatto per la scuola era un problema grosso. Tutti andavano a scuola. Nonc’era verso di evitarla.2Per tutta la notte i suoi pensieri furono come un boomerang: un’idea sfrec-ciava via lontana dalla scuola e dalla realtà e lo rendeva felice, poi però co-minciava il viaggio di ritorno e il suo tormento si rifaceva vivo. E il mattinocontinuava implacabile ad avvicinarsi. A colazione rimase in silenzio. – Tiabituerai – disse sua mamma, probabilmente perché si accorse che aveval’aria triste mentre mangiava i cereali. Lui annuì e le sorrise. Arrivò a scuolapresto, andò in classe, si sedette al suo banco. Lì era abbastanza al sicuro.Era improbabile che i ragazzi che lo avevano infastidito il giorno prima fosserodi quelli che arrivavano a scuola presto; erano di sicuro da qualcheparte a bighellonare o infastidire la gente, pensò.3Nell’aula c’erano un paio di ragazze, che però lo ignorarono, a meno che larisata che udì mentre tirava fuori il libro di lettura non avesse qualcosa ache fare con lui. Cosa c’era da ridere? Niente, se non eri il tipo che andavasempre alla ricerca di qualcosa di cui ridere. Sfortunatamente, però, i ragazziche aveva conosciuto Marcus erano quasi tutti così. Pattugliavano su e giùi corridoi alla ricerca di pantaloni sbagliati o pettinature sbagliate o scarpeda ginnastica sbagliate. Dato che di solito Marcus indossava le scarpe sbagliateo i pantaloni sbagliati e il suo taglio di capelli era immancabilmentesbagliato, non doveva far molto per farli divertire. Marcus sapeva di esserestrambo ma sua madre non lo capiva affatto.Gli ripeteva sempre che solo le persone superficiali giudicano dai vestiti odai capelli; gli proibiva di guardare la televisione spazzatura, o di ascoltaremusica spazzatura o di giocare con videogiochi spazzatura: questo significavache se voleva fare qualsiasi cosa facevano tutti gli altri ragazzi, lui dovevadiscutere con lei per ore. Di solito perdeva, ma lei era così brava adiscutere che non gli dispiaceva perdere.
Riad. da Nick Hornby, Un ragazzo, Tea
A3 PARTE A Rileggi il testo e scrivi il termine utilizzato nel testo al posto dei termini sottolineati.
1.
L’arrivo del mattino era impossibile da fermare. __
2.
Era poco verosimile che i ragazzi sarebbero stati a scuola. __
3.
Il taglio di capelli di Marcus era sempre quello sbagliato. __
A3.1 PARTE B Con quale prefisso si può indicare una negazione?
A. de
B. pre
C. in
1
5
10
15
20
25
30
35
40
1La notte dopo il suo primo giorno di scuola Marcus si svegliò ogni mezz’orao quasi. Se ne accorse dalle lancette luminose del suo orologio. Non riu-sciva a credere che sarebbe dovuto ritornare la mattina dopo e la mattinadopo ancora e… be’, poi ci sarebbe stato il week-end, ma in un modo onell’altro ogni mattina per il resto della sua vita, più o meno. Ogni volta chesi svegliava il suo primo pensiero era che ci doveva essere un sistema persuperare quell’orribile sensazione, o aggirarla, o anche conviverci; ogni voltache si era agitato per qualcosa in passato, di solito era sempre saltata fuoriuna qualche risposta, che di solito prevedeva di raccontare a sua mammache cosa lo preoccupava. Ma questa volta non c’era niente che lei potessefare. Non l’avrebbe trasferito in un’altra scuola, e comunque le cose nonsarebbero cambiate granché. Lui sarebbe rimasto com’era, e questo, glisembrava, era il problema di fondo. Semplice: non era fatto per la scuola.Tutto qui. E come facevi a spiegarlo? Potevi non essere adatto per alcunecose (sapeva già di non essere adatto per le feste perché era troppo timido,o per i pantaloni larghi, perché aveva le gambe troppo corte), ma non esserefatto per la scuola era un problema grosso. Tutti andavano a scuola. Nonc’era verso di evitarla.2Per tutta la notte i suoi pensieri furono come un boomerang: un’idea sfrec-ciava via lontana dalla scuola e dalla realtà e lo rendeva felice, poi però co-minciava il viaggio di ritorno e il suo tormento si rifaceva vivo. E il mattinocontinuava implacabile ad avvicinarsi. A colazione rimase in silenzio. – Tiabituerai – disse sua mamma, probabilmente perché si accorse che aveval’aria triste mentre mangiava i cereali. Lui annuì e le sorrise. Arrivò a scuolapresto, andò in classe, si sedette al suo banco. Lì era abbastanza al sicuro.Era improbabile che i ragazzi che lo avevano infastidito il giorno prima fosserodi quelli che arrivavano a scuola presto; erano di sicuro da qualcheparte a bighellonare o infastidire la gente, pensò.3Nell’aula c’erano un paio di ragazze, che però lo ignorarono, a meno che larisata che udì mentre tirava fuori il libro di lettura non avesse qualcosa ache fare con lui. Cosa c’era da ridere? Niente, se non eri il tipo che andavasempre alla ricerca di qualcosa di cui ridere. Sfortunatamente, però, i ragazziche aveva conosciuto Marcus erano quasi tutti così. Pattugliavano su e giùi corridoi alla ricerca di pantaloni sbagliati o pettinature sbagliate o scarpeda ginnastica sbagliate. Dato che di solito Marcus indossava le scarpe sbagliateo i pantaloni sbagliati e il suo taglio di capelli era immancabilmentesbagliato, non doveva far molto per farli divertire. Marcus sapeva di esserestrambo ma sua madre non lo capiva affatto.Gli ripeteva sempre che solo le persone superficiali giudicano dai vestiti odai capelli; gli proibiva di guardare la televisione spazzatura, o di ascoltaremusica spazzatura o di giocare con videogiochi spazzatura: questo significavache se voleva fare qualsiasi cosa facevano tutti gli altri ragazzi, lui dovevadiscutere con lei per ore. Di solito perdeva, ma lei era così brava adiscutere che non gli dispiaceva perdere.
Riad. da Nick Hornby, Un ragazzo, Tea
L’ANSIA DELLA SCUOLA
5
10
15
20
25
30
35
40
1La notte dopo il suo primo giorno di scuola Marcus si svegliò ogni mezz’orao quasi. Se ne accorse dalle lancette luminose del suo orologio. Non riu-sciva a credere che sarebbe dovuto ritornare la mattina dopo e la mattinadopo ancora e… be’, poi ci sarebbe stato il week-end, ma in un modo onell’altro ogni mattina per il resto della sua vita, più o meno. Ogni volta chesi svegliava il suo primo pensiero era che ci doveva essere un sistema persuperare quell’orribile sensazione, o aggirarla, o anche conviverci; ogni voltache si era agitato per qualcosa in passato, di solito era sempre saltata fuoriuna qualche risposta, che di solito prevedeva di raccontare a sua mammache cosa lo preoccupava. Ma questa volta non c’era niente che lei potessefare. Non l’avrebbe trasferito in un’altra scuola, e comunque le cose nonsarebbero cambiate granché. Lui sarebbe rimasto com’era, e questo, glisembrava, era il problema di fondo. Semplice: non era fatto per la scuola.Tutto qui. E come facevi a spiegarlo? Potevi non essere adatto per alcunecose (sapeva già di non essere adatto per le feste perché era troppo timido,o per i pantaloni larghi, perché aveva le gambe troppo corte), ma non esserefatto per la scuola era un problema grosso. Tutti andavano a scuola. Nonc’era verso di evitarla.2Per tutta la notte i suoi pensieri furono come un boomerang: un’idea sfrec-ciava via lontana dalla scuola e dalla realtà e lo rendeva felice, poi però co-minciava il viaggio di ritorno e il suo tormento si rifaceva vivo. E il mattinocontinuava implacabile ad avvicinarsi. A colazione rimase in silenzio. – Tiabituerai – disse sua mamma, probabilmente perché si accorse che aveval’aria triste mentre mangiava i cereali. Lui annuì e le sorrise. Arrivò a scuolapresto, andò in classe, si sedette al suo banco. Lì era abbastanza al sicuro.Era improbabile che i ragazzi che lo avevano infastidito il giorno prima fosserodi quelli che arrivavano a scuola presto; erano di sicuro da qualcheparte a bighellonare o infastidire la gente, pensò.3Nell’aula c’erano un paio di ragazze, che però lo ignorarono, a meno che larisata che udì mentre tirava fuori il libro di lettura non avesse qualcosa ache fare con lui. Cosa c’era da ridere? Niente, se non eri il tipo che andavasempre alla ricerca di qualcosa di cui ridere. Sfortunatamente, però, i ragazziche aveva conosciuto Marcus erano quasi tutti così. Pattugliavano su e giùi corridoi alla ricerca di pantaloni sbagliati o pettinature sbagliate o scarpeda ginnastica sbagliate. Dato che di solito Marcus indossava le scarpe sbagliateo i pantaloni sbagliati e il suo taglio di capelli era immancabilmentesbagliato, non doveva far molto per farli divertire. Marcus sapeva di esserestrambo ma sua madre non lo capiva affatto.Gli ripeteva sempre che solo le persone superficiali giudicano dai vestiti odai capelli; gli proibiva di guardare la televisione spazzatura, o di ascoltaremusica spazzatura o di giocare con videogiochi spazzatura: questo significavache se voleva fare qualsiasi cosa facevano tutti gli altri ragazzi, lui dovevadiscutere con lei per ore. Di solito perdeva, ma lei era così brava adiscutere che non gli dispiaceva perdere.
Riad. da Nick Hornby, Un ragazzo, Tea
A4 PARTE A Che cosa significa l’espressione «non essere fatto per qualcosa»?
A. Non essere pronto.
B. Non amare qualcosa.
C. Non essere adatto.
D. Non avere voglia.
A4.1 PARTE B Osserva le immagini e abbina ciascuna con ciò per cui proprio «non è fatto» il soggetto raffigurato, scegliendo tra le alternative elencate.
1. 

2. 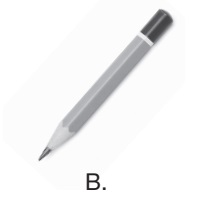
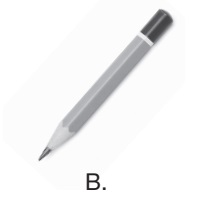
3. 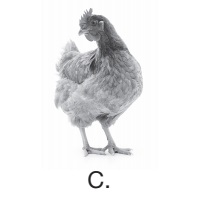
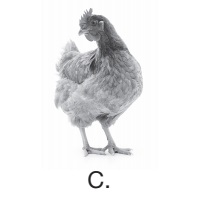
4. 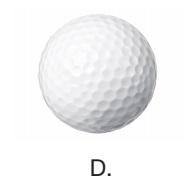
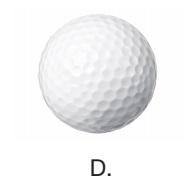
1
5
10
15
20
25
30
35
40
1La notte dopo il suo primo giorno di scuola Marcus si svegliò ogni mezz’orao quasi. Se ne accorse dalle lancette luminose del suo orologio. Non riu-sciva a credere che sarebbe dovuto ritornare la mattina dopo e la mattinadopo ancora e… be’, poi ci sarebbe stato il week-end, ma in un modo onell’altro ogni mattina per il resto della sua vita, più o meno. Ogni volta chesi svegliava il suo primo pensiero era che ci doveva essere un sistema persuperare quell’orribile sensazione, o aggirarla, o anche conviverci; ogni voltache si era agitato per qualcosa in passato, di solito era sempre saltata fuoriuna qualche risposta, che di solito prevedeva di raccontare a sua mammache cosa lo preoccupava. Ma questa volta non c’era niente che lei potessefare. Non l’avrebbe trasferito in un’altra scuola, e comunque le cose nonsarebbero cambiate granché. Lui sarebbe rimasto com’era, e questo, glisembrava, era il problema di fondo. Semplice: non era fatto per la scuola.Tutto qui. E come facevi a spiegarlo? Potevi non essere adatto per alcunecose (sapeva già di non essere adatto per le feste perché era troppo timido,o per i pantaloni larghi, perché aveva le gambe troppo corte), ma non esserefatto per la scuola era un problema grosso. Tutti andavano a scuola. Nonc’era verso di evitarla.2Per tutta la notte i suoi pensieri furono come un boomerang: un’idea sfrec-ciava via lontana dalla scuola e dalla realtà e lo rendeva felice, poi però co-minciava il viaggio di ritorno e il suo tormento si rifaceva vivo. E il mattinocontinuava implacabile ad avvicinarsi. A colazione rimase in silenzio. – Tiabituerai – disse sua mamma, probabilmente perché si accorse che aveval’aria triste mentre mangiava i cereali. Lui annuì e le sorrise. Arrivò a scuolapresto, andò in classe, si sedette al suo banco. Lì era abbastanza al sicuro.Era improbabile che i ragazzi che lo avevano infastidito il giorno prima fosserodi quelli che arrivavano a scuola presto; erano di sicuro da qualcheparte a bighellonare o infastidire la gente, pensò.3Nell’aula c’erano un paio di ragazze, che però lo ignorarono, a meno che larisata che udì mentre tirava fuori il libro di lettura non avesse qualcosa ache fare con lui. Cosa c’era da ridere? Niente, se non eri il tipo che andavasempre alla ricerca di qualcosa di cui ridere. Sfortunatamente, però, i ragazziche aveva conosciuto Marcus erano quasi tutti così. Pattugliavano su e giùi corridoi alla ricerca di pantaloni sbagliati o pettinature sbagliate o scarpeda ginnastica sbagliate. Dato che di solito Marcus indossava le scarpe sbagliateo i pantaloni sbagliati e il suo taglio di capelli era immancabilmentesbagliato, non doveva far molto per farli divertire. Marcus sapeva di esserestrambo ma sua madre non lo capiva affatto.Gli ripeteva sempre che solo le persone superficiali giudicano dai vestiti odai capelli; gli proibiva di guardare la televisione spazzatura, o di ascoltaremusica spazzatura o di giocare con videogiochi spazzatura: questo significavache se voleva fare qualsiasi cosa facevano tutti gli altri ragazzi, lui dovevadiscutere con lei per ore. Di solito perdeva, ma lei era così brava adiscutere che non gli dispiaceva perdere.
Riad. da Nick Hornby, Un ragazzo, Tea
L’ANSIA DELLA SCUOLA
5
10
15
20
25
30
35
40
1La notte dopo il suo primo giorno di scuola Marcus si svegliò ogni mezz’orao quasi. Se ne accorse dalle lancette luminose del suo orologio. Non riu-sciva a credere che sarebbe dovuto ritornare la mattina dopo e la mattinadopo ancora e… be’, poi ci sarebbe stato il week-end, ma in un modo onell’altro ogni mattina per il resto della sua vita, più o meno. Ogni volta chesi svegliava il suo primo pensiero era che ci doveva essere un sistema persuperare quell’orribile sensazione, o aggirarla, o anche conviverci; ogni voltache si era agitato per qualcosa in passato, di solito era sempre saltata fuoriuna qualche risposta, che di solito prevedeva di raccontare a sua mammache cosa lo preoccupava. Ma questa volta non c’era niente che lei potessefare. Non l’avrebbe trasferito in un’altra scuola, e comunque le cose nonsarebbero cambiate granché. Lui sarebbe rimasto com’era, e questo, glisembrava, era il problema di fondo. Semplice: non era fatto per la scuola.Tutto qui. E come facevi a spiegarlo? Potevi non essere adatto per alcunecose (sapeva già di non essere adatto per le feste perché era troppo timido,o per i pantaloni larghi, perché aveva le gambe troppo corte), ma non esserefatto per la scuola era un problema grosso. Tutti andavano a scuola. Nonc’era verso di evitarla.2Per tutta la notte i suoi pensieri furono come un boomerang: un’idea sfrec-ciava via lontana dalla scuola e dalla realtà e lo rendeva felice, poi però co-minciava il viaggio di ritorno e il suo tormento si rifaceva vivo. E il mattinocontinuava implacabile ad avvicinarsi. A colazione rimase in silenzio. – Tiabituerai – disse sua mamma, probabilmente perché si accorse che aveval’aria triste mentre mangiava i cereali. Lui annuì e le sorrise. Arrivò a scuolapresto, andò in classe, si sedette al suo banco. Lì era abbastanza al sicuro.Era improbabile che i ragazzi che lo avevano infastidito il giorno prima fosserodi quelli che arrivavano a scuola presto; erano di sicuro da qualcheparte a bighellonare o infastidire la gente, pensò.3Nell’aula c’erano un paio di ragazze, che però lo ignorarono, a meno che larisata che udì mentre tirava fuori il libro di lettura non avesse qualcosa ache fare con lui. Cosa c’era da ridere? Niente, se non eri il tipo che andavasempre alla ricerca di qualcosa di cui ridere. Sfortunatamente, però, i ragazziche aveva conosciuto Marcus erano quasi tutti così. Pattugliavano su e giùi corridoi alla ricerca di pantaloni sbagliati o pettinature sbagliate o scarpeda ginnastica sbagliate. Dato che di solito Marcus indossava le scarpe sbagliateo i pantaloni sbagliati e il suo taglio di capelli era immancabilmentesbagliato, non doveva far molto per farli divertire. Marcus sapeva di esserestrambo ma sua madre non lo capiva affatto.Gli ripeteva sempre che solo le persone superficiali giudicano dai vestiti odai capelli; gli proibiva di guardare la televisione spazzatura, o di ascoltaremusica spazzatura o di giocare con videogiochi spazzatura: questo significavache se voleva fare qualsiasi cosa facevano tutti gli altri ragazzi, lui dovevadiscutere con lei per ore. Di solito perdeva, ma lei era così brava adiscutere che non gli dispiaceva perdere.
Riad. da Nick Hornby, Un ragazzo, Tea
A5 Rileggi la frase:
«Non l’avrebbe trasferito in un’altra scuola, e comunque le cose non sarebbero cambiate granché».
Con quale espressione potresti sostituire «comunque»?
«Non l’avrebbe trasferito in un’altra scuola, e comunque le cose non sarebbero cambiate granché».
Con quale espressione potresti sostituire «comunque»?
A. Quindi.
B. Alla fine.
C. In ogni caso.
D. Poi.
1
5
10
15
20
25
30
35
40
1La notte dopo il suo primo giorno di scuola Marcus si svegliò ogni mezz’orao quasi. Se ne accorse dalle lancette luminose del suo orologio. Non riu-sciva a credere che sarebbe dovuto ritornare la mattina dopo e la mattinadopo ancora e… be’, poi ci sarebbe stato il week-end, ma in un modo onell’altro ogni mattina per il resto della sua vita, più o meno. Ogni volta chesi svegliava il suo primo pensiero era che ci doveva essere un sistema persuperare quell’orribile sensazione, o aggirarla, o anche conviverci; ogni voltache si era agitato per qualcosa in passato, di solito era sempre saltata fuoriuna qualche risposta, che di solito prevedeva di raccontare a sua mammache cosa lo preoccupava. Ma questa volta non c’era niente che lei potessefare. Non l’avrebbe trasferito in un’altra scuola, e comunque le cose nonsarebbero cambiate granché. Lui sarebbe rimasto com’era, e questo, glisembrava, era il problema di fondo. Semplice: non era fatto per la scuola.Tutto qui. E come facevi a spiegarlo? Potevi non essere adatto per alcunecose (sapeva già di non essere adatto per le feste perché era troppo timido,o per i pantaloni larghi, perché aveva le gambe troppo corte), ma non esserefatto per la scuola era un problema grosso. Tutti andavano a scuola. Nonc’era verso di evitarla.2Per tutta la notte i suoi pensieri furono come un boomerang: un’idea sfrec-ciava via lontana dalla scuola e dalla realtà e lo rendeva felice, poi però co-minciava il viaggio di ritorno e il suo tormento si rifaceva vivo. E il mattinocontinuava implacabile ad avvicinarsi. A colazione rimase in silenzio. – Tiabituerai – disse sua mamma, probabilmente perché si accorse che aveval’aria triste mentre mangiava i cereali. Lui annuì e le sorrise. Arrivò a scuolapresto, andò in classe, si sedette al suo banco. Lì era abbastanza al sicuro.Era improbabile che i ragazzi che lo avevano infastidito il giorno prima fosserodi quelli che arrivavano a scuola presto; erano di sicuro da qualcheparte a bighellonare o infastidire la gente, pensò.3Nell’aula c’erano un paio di ragazze, che però lo ignorarono, a meno che larisata che udì mentre tirava fuori il libro di lettura non avesse qualcosa ache fare con lui. Cosa c’era da ridere? Niente, se non eri il tipo che andavasempre alla ricerca di qualcosa di cui ridere. Sfortunatamente, però, i ragazziche aveva conosciuto Marcus erano quasi tutti così. Pattugliavano su e giùi corridoi alla ricerca di pantaloni sbagliati o pettinature sbagliate o scarpeda ginnastica sbagliate. Dato che di solito Marcus indossava le scarpe sbagliateo i pantaloni sbagliati e il suo taglio di capelli era immancabilmentesbagliato, non doveva far molto per farli divertire. Marcus sapeva di esserestrambo ma sua madre non lo capiva affatto.Gli ripeteva sempre che solo le persone superficiali giudicano dai vestiti odai capelli; gli proibiva di guardare la televisione spazzatura, o di ascoltaremusica spazzatura o di giocare con videogiochi spazzatura: questo significavache se voleva fare qualsiasi cosa facevano tutti gli altri ragazzi, lui dovevadiscutere con lei per ore. Di solito perdeva, ma lei era così brava adiscutere che non gli dispiaceva perdere.
Riad. da Nick Hornby, Un ragazzo, Tea
L’ANSIA DELLA SCUOLA
5
10
15
20
25
30
35
40
1La notte dopo il suo primo giorno di scuola Marcus si svegliò ogni mezz’orao quasi. Se ne accorse dalle lancette luminose del suo orologio. Non riu-sciva a credere che sarebbe dovuto ritornare la mattina dopo e la mattinadopo ancora e… be’, poi ci sarebbe stato il week-end, ma in un modo onell’altro ogni mattina per il resto della sua vita, più o meno. Ogni volta chesi svegliava il suo primo pensiero era che ci doveva essere un sistema persuperare quell’orribile sensazione, o aggirarla, o anche conviverci; ogni voltache si era agitato per qualcosa in passato, di solito era sempre saltata fuoriuna qualche risposta, che di solito prevedeva di raccontare a sua mammache cosa lo preoccupava. Ma questa volta non c’era niente che lei potessefare. Non l’avrebbe trasferito in un’altra scuola, e comunque le cose nonsarebbero cambiate granché. Lui sarebbe rimasto com’era, e questo, glisembrava, era il problema di fondo. Semplice: non era fatto per la scuola.Tutto qui. E come facevi a spiegarlo? Potevi non essere adatto per alcunecose (sapeva già di non essere adatto per le feste perché era troppo timido,o per i pantaloni larghi, perché aveva le gambe troppo corte), ma non esserefatto per la scuola era un problema grosso. Tutti andavano a scuola. Nonc’era verso di evitarla.2Per tutta la notte i suoi pensieri furono come un boomerang: un’idea sfrec-ciava via lontana dalla scuola e dalla realtà e lo rendeva felice, poi però co-minciava il viaggio di ritorno e il suo tormento si rifaceva vivo. E il mattinocontinuava implacabile ad avvicinarsi. A colazione rimase in silenzio. – Tiabituerai – disse sua mamma, probabilmente perché si accorse che aveval’aria triste mentre mangiava i cereali. Lui annuì e le sorrise. Arrivò a scuolapresto, andò in classe, si sedette al suo banco. Lì era abbastanza al sicuro.Era improbabile che i ragazzi che lo avevano infastidito il giorno prima fosserodi quelli che arrivavano a scuola presto; erano di sicuro da qualcheparte a bighellonare o infastidire la gente, pensò.3Nell’aula c’erano un paio di ragazze, che però lo ignorarono, a meno che larisata che udì mentre tirava fuori il libro di lettura non avesse qualcosa ache fare con lui. Cosa c’era da ridere? Niente, se non eri il tipo che andavasempre alla ricerca di qualcosa di cui ridere. Sfortunatamente, però, i ragazziche aveva conosciuto Marcus erano quasi tutti così. Pattugliavano su e giùi corridoi alla ricerca di pantaloni sbagliati o pettinature sbagliate o scarpeda ginnastica sbagliate. Dato che di solito Marcus indossava le scarpe sbagliateo i pantaloni sbagliati e il suo taglio di capelli era immancabilmentesbagliato, non doveva far molto per farli divertire. Marcus sapeva di esserestrambo ma sua madre non lo capiva affatto.Gli ripeteva sempre che solo le persone superficiali giudicano dai vestiti odai capelli; gli proibiva di guardare la televisione spazzatura, o di ascoltaremusica spazzatura o di giocare con videogiochi spazzatura: questo significavache se voleva fare qualsiasi cosa facevano tutti gli altri ragazzi, lui dovevadiscutere con lei per ore. Di solito perdeva, ma lei era così brava adiscutere che non gli dispiaceva perdere.
Riad. da Nick Hornby, Un ragazzo, Tea
A6 Rileggi con attenzione il testo:
«Di solito era sempre saltata fuori una qualche risposta, che di solito prevedeva di raccontare a sua mamma che cosa lo preoccupava. Ma questa volta non c’era niente che lei potesse fare».
PARTE A Con quale parola potresti sostituire «prevedeva»?
«Di solito era sempre saltata fuori una qualche risposta, che di solito prevedeva di raccontare a sua mamma che cosa lo preoccupava. Ma questa volta non c’era niente che lei potesse fare».
PARTE A Con quale parola potresti sostituire «prevedeva»?
A. Programmava.
B. Implicava.
C. Considerava.
D. Anticipava.
A6.1 PARTE B Completa la frase che ricostruisce il senso del testo scegliendo tra le parole elencate.
Di solito spiegando alla mamma le sue il protagonista riusciva a delle soluzioni, ma stavolta non c’era di il .
1
5
10
15
20
25
30
35
40
1La notte dopo il suo primo giorno di scuola Marcus si svegliò ogni mezz’orao quasi. Se ne accorse dalle lancette luminose del suo orologio. Non riu-sciva a credere che sarebbe dovuto ritornare la mattina dopo e la mattinadopo ancora e… be’, poi ci sarebbe stato il week-end, ma in un modo onell’altro ogni mattina per il resto della sua vita, più o meno. Ogni volta chesi svegliava il suo primo pensiero era che ci doveva essere un sistema persuperare quell’orribile sensazione, o aggirarla, o anche conviverci; ogni voltache si era agitato per qualcosa in passato, di solito era sempre saltata fuoriuna qualche risposta, che di solito prevedeva di raccontare a sua mammache cosa lo preoccupava. Ma questa volta non c’era niente che lei potessefare. Non l’avrebbe trasferito in un’altra scuola, e comunque le cose nonsarebbero cambiate granché. Lui sarebbe rimasto com’era, e questo, glisembrava, era il problema di fondo. Semplice: non era fatto per la scuola.Tutto qui. E come facevi a spiegarlo? Potevi non essere adatto per alcunecose (sapeva già di non essere adatto per le feste perché era troppo timido,o per i pantaloni larghi, perché aveva le gambe troppo corte), ma non esserefatto per la scuola era un problema grosso. Tutti andavano a scuola. Nonc’era verso di evitarla.2Per tutta la notte i suoi pensieri furono come un boomerang: un’idea sfrec-ciava via lontana dalla scuola e dalla realtà e lo rendeva felice, poi però co-minciava il viaggio di ritorno e il suo tormento si rifaceva vivo. E il mattinocontinuava implacabile ad avvicinarsi. A colazione rimase in silenzio. – Tiabituerai – disse sua mamma, probabilmente perché si accorse che aveval’aria triste mentre mangiava i cereali. Lui annuì e le sorrise. Arrivò a scuolapresto, andò in classe, si sedette al suo banco. Lì era abbastanza al sicuro.Era improbabile che i ragazzi che lo avevano infastidito il giorno prima fosserodi quelli che arrivavano a scuola presto; erano di sicuro da qualcheparte a bighellonare o infastidire la gente, pensò.3Nell’aula c’erano un paio di ragazze, che però lo ignorarono, a meno che larisata che udì mentre tirava fuori il libro di lettura non avesse qualcosa ache fare con lui. Cosa c’era da ridere? Niente, se non eri il tipo che andavasempre alla ricerca di qualcosa di cui ridere. Sfortunatamente, però, i ragazziche aveva conosciuto Marcus erano quasi tutti così. Pattugliavano su e giùi corridoi alla ricerca di pantaloni sbagliati o pettinature sbagliate o scarpeda ginnastica sbagliate. Dato che di solito Marcus indossava le scarpe sbagliateo i pantaloni sbagliati e il suo taglio di capelli era immancabilmentesbagliato, non doveva far molto per farli divertire. Marcus sapeva di esserestrambo ma sua madre non lo capiva affatto.Gli ripeteva sempre che solo le persone superficiali giudicano dai vestiti odai capelli; gli proibiva di guardare la televisione spazzatura, o di ascoltaremusica spazzatura o di giocare con videogiochi spazzatura: questo significavache se voleva fare qualsiasi cosa facevano tutti gli altri ragazzi, lui dovevadiscutere con lei per ore. Di solito perdeva, ma lei era così brava adiscutere che non gli dispiaceva perdere.
Riad. da Nick Hornby, Un ragazzo, Tea
L’ANSIA DELLA SCUOLA
5
10
15
20
25
30
35
40
1La notte dopo il suo primo giorno di scuola Marcus si svegliò ogni mezz’orao quasi. Se ne accorse dalle lancette luminose del suo orologio. Non riu-sciva a credere che sarebbe dovuto ritornare la mattina dopo e la mattinadopo ancora e… be’, poi ci sarebbe stato il week-end, ma in un modo onell’altro ogni mattina per il resto della sua vita, più o meno. Ogni volta chesi svegliava il suo primo pensiero era che ci doveva essere un sistema persuperare quell’orribile sensazione, o aggirarla, o anche conviverci; ogni voltache si era agitato per qualcosa in passato, di solito era sempre saltata fuoriuna qualche risposta, che di solito prevedeva di raccontare a sua mammache cosa lo preoccupava. Ma questa volta non c’era niente che lei potessefare. Non l’avrebbe trasferito in un’altra scuola, e comunque le cose nonsarebbero cambiate granché. Lui sarebbe rimasto com’era, e questo, glisembrava, era il problema di fondo. Semplice: non era fatto per la scuola.Tutto qui. E come facevi a spiegarlo? Potevi non essere adatto per alcunecose (sapeva già di non essere adatto per le feste perché era troppo timido,o per i pantaloni larghi, perché aveva le gambe troppo corte), ma non esserefatto per la scuola era un problema grosso. Tutti andavano a scuola. Nonc’era verso di evitarla.2Per tutta la notte i suoi pensieri furono come un boomerang: un’idea sfrec-ciava via lontana dalla scuola e dalla realtà e lo rendeva felice, poi però co-minciava il viaggio di ritorno e il suo tormento si rifaceva vivo. E il mattinocontinuava implacabile ad avvicinarsi. A colazione rimase in silenzio. – Tiabituerai – disse sua mamma, probabilmente perché si accorse che aveval’aria triste mentre mangiava i cereali. Lui annuì e le sorrise. Arrivò a scuolapresto, andò in classe, si sedette al suo banco. Lì era abbastanza al sicuro.Era improbabile che i ragazzi che lo avevano infastidito il giorno prima fosserodi quelli che arrivavano a scuola presto; erano di sicuro da qualcheparte a bighellonare o infastidire la gente, pensò.3Nell’aula c’erano un paio di ragazze, che però lo ignorarono, a meno che larisata che udì mentre tirava fuori il libro di lettura non avesse qualcosa ache fare con lui. Cosa c’era da ridere? Niente, se non eri il tipo che andavasempre alla ricerca di qualcosa di cui ridere. Sfortunatamente, però, i ragazziche aveva conosciuto Marcus erano quasi tutti così. Pattugliavano su e giùi corridoi alla ricerca di pantaloni sbagliati o pettinature sbagliate o scarpeda ginnastica sbagliate. Dato che di solito Marcus indossava le scarpe sbagliateo i pantaloni sbagliati e il suo taglio di capelli era immancabilmentesbagliato, non doveva far molto per farli divertire. Marcus sapeva di esserestrambo ma sua madre non lo capiva affatto.Gli ripeteva sempre che solo le persone superficiali giudicano dai vestiti odai capelli; gli proibiva di guardare la televisione spazzatura, o di ascoltaremusica spazzatura o di giocare con videogiochi spazzatura: questo significavache se voleva fare qualsiasi cosa facevano tutti gli altri ragazzi, lui dovevadiscutere con lei per ore. Di solito perdeva, ma lei era così brava adiscutere che non gli dispiaceva perdere.
Riad. da Nick Hornby, Un ragazzo, Tea
A7 Marcus immagina i ragazzi intenti a «bighellonare» (riga 28), e cioè:
A. Rubare nei negozi.
B. Ciondolare in giro.
C. Giocare a biglie.
D. Fare i dispetti alla gente.
1
5
10
15
20
25
30
35
40
1La notte dopo il suo primo giorno di scuola Marcus si svegliò ogni mezz’orao quasi. Se ne accorse dalle lancette luminose del suo orologio. Non riu-sciva a credere che sarebbe dovuto ritornare la mattina dopo e la mattinadopo ancora e… be’, poi ci sarebbe stato il week-end, ma in un modo onell’altro ogni mattina per il resto della sua vita, più o meno. Ogni volta chesi svegliava il suo primo pensiero era che ci doveva essere un sistema persuperare quell’orribile sensazione, o aggirarla, o anche conviverci; ogni voltache si era agitato per qualcosa in passato, di solito era sempre saltata fuoriuna qualche risposta, che di solito prevedeva di raccontare a sua mammache cosa lo preoccupava. Ma questa volta non c’era niente che lei potessefare. Non l’avrebbe trasferito in un’altra scuola, e comunque le cose nonsarebbero cambiate granché. Lui sarebbe rimasto com’era, e questo, glisembrava, era il problema di fondo. Semplice: non era fatto per la scuola.Tutto qui. E come facevi a spiegarlo? Potevi non essere adatto per alcunecose (sapeva già di non essere adatto per le feste perché era troppo timido,o per i pantaloni larghi, perché aveva le gambe troppo corte), ma non esserefatto per la scuola era un problema grosso. Tutti andavano a scuola. Nonc’era verso di evitarla.2Per tutta la notte i suoi pensieri furono come un boomerang: un’idea sfrec-ciava via lontana dalla scuola e dalla realtà e lo rendeva felice, poi però co-minciava il viaggio di ritorno e il suo tormento si rifaceva vivo. E il mattinocontinuava implacabile ad avvicinarsi. A colazione rimase in silenzio. – Tiabituerai – disse sua mamma, probabilmente perché si accorse che aveval’aria triste mentre mangiava i cereali. Lui annuì e le sorrise. Arrivò a scuolapresto, andò in classe, si sedette al suo banco. Lì era abbastanza al sicuro.Era improbabile che i ragazzi che lo avevano infastidito il giorno prima fosserodi quelli che arrivavano a scuola presto; erano di sicuro da qualcheparte a bighellonare o infastidire la gente, pensò.3Nell’aula c’erano un paio di ragazze, che però lo ignorarono, a meno che larisata che udì mentre tirava fuori il libro di lettura non avesse qualcosa ache fare con lui. Cosa c’era da ridere? Niente, se non eri il tipo che andavasempre alla ricerca di qualcosa di cui ridere. Sfortunatamente, però, i ragazziche aveva conosciuto Marcus erano quasi tutti così. Pattugliavano su e giùi corridoi alla ricerca di pantaloni sbagliati o pettinature sbagliate o scarpeda ginnastica sbagliate. Dato che di solito Marcus indossava le scarpe sbagliateo i pantaloni sbagliati e il suo taglio di capelli era immancabilmentesbagliato, non doveva far molto per farli divertire. Marcus sapeva di esserestrambo ma sua madre non lo capiva affatto.Gli ripeteva sempre che solo le persone superficiali giudicano dai vestiti odai capelli; gli proibiva di guardare la televisione spazzatura, o di ascoltaremusica spazzatura o di giocare con videogiochi spazzatura: questo significavache se voleva fare qualsiasi cosa facevano tutti gli altri ragazzi, lui dovevadiscutere con lei per ore. Di solito perdeva, ma lei era così brava adiscutere che non gli dispiaceva perdere.
Riad. da Nick Hornby, Un ragazzo, Tea
L’ANSIA DELLA SCUOLA
5
10
15
20
25
30
35
40
1La notte dopo il suo primo giorno di scuola Marcus si svegliò ogni mezz’orao quasi. Se ne accorse dalle lancette luminose del suo orologio. Non riu-sciva a credere che sarebbe dovuto ritornare la mattina dopo e la mattinadopo ancora e… be’, poi ci sarebbe stato il week-end, ma in un modo onell’altro ogni mattina per il resto della sua vita, più o meno. Ogni volta chesi svegliava il suo primo pensiero era che ci doveva essere un sistema persuperare quell’orribile sensazione, o aggirarla, o anche conviverci; ogni voltache si era agitato per qualcosa in passato, di solito era sempre saltata fuoriuna qualche risposta, che di solito prevedeva di raccontare a sua mammache cosa lo preoccupava. Ma questa volta non c’era niente che lei potessefare. Non l’avrebbe trasferito in un’altra scuola, e comunque le cose nonsarebbero cambiate granché. Lui sarebbe rimasto com’era, e questo, glisembrava, era il problema di fondo. Semplice: non era fatto per la scuola.Tutto qui. E come facevi a spiegarlo? Potevi non essere adatto per alcunecose (sapeva già di non essere adatto per le feste perché era troppo timido,o per i pantaloni larghi, perché aveva le gambe troppo corte), ma non esserefatto per la scuola era un problema grosso. Tutti andavano a scuola. Nonc’era verso di evitarla.2Per tutta la notte i suoi pensieri furono come un boomerang: un’idea sfrec-ciava via lontana dalla scuola e dalla realtà e lo rendeva felice, poi però co-minciava il viaggio di ritorno e il suo tormento si rifaceva vivo. E il mattinocontinuava implacabile ad avvicinarsi. A colazione rimase in silenzio. – Tiabituerai – disse sua mamma, probabilmente perché si accorse che aveval’aria triste mentre mangiava i cereali. Lui annuì e le sorrise. Arrivò a scuolapresto, andò in classe, si sedette al suo banco. Lì era abbastanza al sicuro.Era improbabile che i ragazzi che lo avevano infastidito il giorno prima fosserodi quelli che arrivavano a scuola presto; erano di sicuro da qualcheparte a bighellonare o infastidire la gente, pensò.3Nell’aula c’erano un paio di ragazze, che però lo ignorarono, a meno che larisata che udì mentre tirava fuori il libro di lettura non avesse qualcosa ache fare con lui. Cosa c’era da ridere? Niente, se non eri il tipo che andavasempre alla ricerca di qualcosa di cui ridere. Sfortunatamente, però, i ragazziche aveva conosciuto Marcus erano quasi tutti così. Pattugliavano su e giùi corridoi alla ricerca di pantaloni sbagliati o pettinature sbagliate o scarpeda ginnastica sbagliate. Dato che di solito Marcus indossava le scarpe sbagliateo i pantaloni sbagliati e il suo taglio di capelli era immancabilmentesbagliato, non doveva far molto per farli divertire. Marcus sapeva di esserestrambo ma sua madre non lo capiva affatto.Gli ripeteva sempre che solo le persone superficiali giudicano dai vestiti odai capelli; gli proibiva di guardare la televisione spazzatura, o di ascoltaremusica spazzatura o di giocare con videogiochi spazzatura: questo significavache se voleva fare qualsiasi cosa facevano tutti gli altri ragazzi, lui dovevadiscutere con lei per ore. Di solito perdeva, ma lei era così brava adiscutere che non gli dispiaceva perdere.
Riad. da Nick Hornby, Un ragazzo, Tea
A8 La mamma di Marcus parla di «televisione spazzatura» «musica spazzatura» e «videogiochi spazzatura» perché:
A. sono di poco valore.
B. sono da buttare via.
C. sono riciclati.
D. sono rovinati.
1
5
10
15
20
25
30
35
40
1La notte dopo il suo primo giorno di scuola Marcus si svegliò ogni mezz’orao quasi. Se ne accorse dalle lancette luminose del suo orologio. Non riu-sciva a credere che sarebbe dovuto ritornare la mattina dopo e la mattinadopo ancora e… be’, poi ci sarebbe stato il week-end, ma in un modo onell’altro ogni mattina per il resto della sua vita, più o meno. Ogni volta chesi svegliava il suo primo pensiero era che ci doveva essere un sistema persuperare quell’orribile sensazione, o aggirarla, o anche conviverci; ogni voltache si era agitato per qualcosa in passato, di solito era sempre saltata fuoriuna qualche risposta, che di solito prevedeva di raccontare a sua mammache cosa lo preoccupava. Ma questa volta non c’era niente che lei potessefare. Non l’avrebbe trasferito in un’altra scuola, e comunque le cose nonsarebbero cambiate granché. Lui sarebbe rimasto com’era, e questo, glisembrava, era il problema di fondo. Semplice: non era fatto per la scuola.Tutto qui. E come facevi a spiegarlo? Potevi non essere adatto per alcunecose (sapeva già di non essere adatto per le feste perché era troppo timido,o per i pantaloni larghi, perché aveva le gambe troppo corte), ma non esserefatto per la scuola era un problema grosso. Tutti andavano a scuola. Nonc’era verso di evitarla.2Per tutta la notte i suoi pensieri furono come un boomerang: un’idea sfrec-ciava via lontana dalla scuola e dalla realtà e lo rendeva felice, poi però co-minciava il viaggio di ritorno e il suo tormento si rifaceva vivo. E il mattinocontinuava implacabile ad avvicinarsi. A colazione rimase in silenzio. – Tiabituerai – disse sua mamma, probabilmente perché si accorse che aveval’aria triste mentre mangiava i cereali. Lui annuì e le sorrise. Arrivò a scuolapresto, andò in classe, si sedette al suo banco. Lì era abbastanza al sicuro.Era improbabile che i ragazzi che lo avevano infastidito il giorno prima fosserodi quelli che arrivavano a scuola presto; erano di sicuro da qualcheparte a bighellonare o infastidire la gente, pensò.3Nell’aula c’erano un paio di ragazze, che però lo ignorarono, a meno che larisata che udì mentre tirava fuori il libro di lettura non avesse qualcosa ache fare con lui. Cosa c’era da ridere? Niente, se non eri il tipo che andavasempre alla ricerca di qualcosa di cui ridere. Sfortunatamente, però, i ragazziche aveva conosciuto Marcus erano quasi tutti così. Pattugliavano su e giùi corridoi alla ricerca di pantaloni sbagliati o pettinature sbagliate o scarpeda ginnastica sbagliate. Dato che di solito Marcus indossava le scarpe sbagliateo i pantaloni sbagliati e il suo taglio di capelli era immancabilmentesbagliato, non doveva far molto per farli divertire. Marcus sapeva di esserestrambo ma sua madre non lo capiva affatto.Gli ripeteva sempre che solo le persone superficiali giudicano dai vestiti odai capelli; gli proibiva di guardare la televisione spazzatura, o di ascoltaremusica spazzatura o di giocare con videogiochi spazzatura: questo significavache se voleva fare qualsiasi cosa facevano tutti gli altri ragazzi, lui dovevadiscutere con lei per ore. Di solito perdeva, ma lei era così brava adiscutere che non gli dispiaceva perdere.
Riad. da Nick Hornby, Un ragazzo, Tea
L’ANSIA DELLA SCUOLA
5
10
15
20
25
30
35
40
1La notte dopo il suo primo giorno di scuola Marcus si svegliò ogni mezz’orao quasi. Se ne accorse dalle lancette luminose del suo orologio. Non riu-sciva a credere che sarebbe dovuto ritornare la mattina dopo e la mattinadopo ancora e… be’, poi ci sarebbe stato il week-end, ma in un modo onell’altro ogni mattina per il resto della sua vita, più o meno. Ogni volta chesi svegliava il suo primo pensiero era che ci doveva essere un sistema persuperare quell’orribile sensazione, o aggirarla, o anche conviverci; ogni voltache si era agitato per qualcosa in passato, di solito era sempre saltata fuoriuna qualche risposta, che di solito prevedeva di raccontare a sua mammache cosa lo preoccupava. Ma questa volta non c’era niente che lei potessefare. Non l’avrebbe trasferito in un’altra scuola, e comunque le cose nonsarebbero cambiate granché. Lui sarebbe rimasto com’era, e questo, glisembrava, era il problema di fondo. Semplice: non era fatto per la scuola.Tutto qui. E come facevi a spiegarlo? Potevi non essere adatto per alcunecose (sapeva già di non essere adatto per le feste perché era troppo timido,o per i pantaloni larghi, perché aveva le gambe troppo corte), ma non esserefatto per la scuola era un problema grosso. Tutti andavano a scuola. Nonc’era verso di evitarla.2Per tutta la notte i suoi pensieri furono come un boomerang: un’idea sfrec-ciava via lontana dalla scuola e dalla realtà e lo rendeva felice, poi però co-minciava il viaggio di ritorno e il suo tormento si rifaceva vivo. E il mattinocontinuava implacabile ad avvicinarsi. A colazione rimase in silenzio. – Tiabituerai – disse sua mamma, probabilmente perché si accorse che aveval’aria triste mentre mangiava i cereali. Lui annuì e le sorrise. Arrivò a scuolapresto, andò in classe, si sedette al suo banco. Lì era abbastanza al sicuro.Era improbabile che i ragazzi che lo avevano infastidito il giorno prima fosserodi quelli che arrivavano a scuola presto; erano di sicuro da qualcheparte a bighellonare o infastidire la gente, pensò.3Nell’aula c’erano un paio di ragazze, che però lo ignorarono, a meno che larisata che udì mentre tirava fuori il libro di lettura non avesse qualcosa ache fare con lui. Cosa c’era da ridere? Niente, se non eri il tipo che andavasempre alla ricerca di qualcosa di cui ridere. Sfortunatamente, però, i ragazziche aveva conosciuto Marcus erano quasi tutti così. Pattugliavano su e giùi corridoi alla ricerca di pantaloni sbagliati o pettinature sbagliate o scarpeda ginnastica sbagliate. Dato che di solito Marcus indossava le scarpe sbagliateo i pantaloni sbagliati e il suo taglio di capelli era immancabilmentesbagliato, non doveva far molto per farli divertire. Marcus sapeva di esserestrambo ma sua madre non lo capiva affatto.Gli ripeteva sempre che solo le persone superficiali giudicano dai vestiti odai capelli; gli proibiva di guardare la televisione spazzatura, o di ascoltaremusica spazzatura o di giocare con videogiochi spazzatura: questo significavache se voleva fare qualsiasi cosa facevano tutti gli altri ragazzi, lui dovevadiscutere con lei per ore. Di solito perdeva, ma lei era così brava adiscutere che non gli dispiaceva perdere.
Riad. da Nick Hornby, Un ragazzo, Tea
A9 Rispondi:
1. PARTE A La storia è narrata da:
A. la mamma.
B. Marcus.
C. un compagno di classe.
D. un narratore esterno.
2. PARTE B Il punto di vista è quello di:
A. la mamma.
B. Marcus.
C. un compagno di classe.
D. un narratore esterno.
1
5
10
15
20
25
30
35
40
1La notte dopo il suo primo giorno di scuola Marcus si svegliò ogni mezz’orao quasi. Se ne accorse dalle lancette luminose del suo orologio. Non riu-sciva a credere che sarebbe dovuto ritornare la mattina dopo e la mattinadopo ancora e… be’, poi ci sarebbe stato il week-end, ma in un modo onell’altro ogni mattina per il resto della sua vita, più o meno. Ogni volta chesi svegliava il suo primo pensiero era che ci doveva essere un sistema persuperare quell’orribile sensazione, o aggirarla, o anche conviverci; ogni voltache si era agitato per qualcosa in passato, di solito era sempre saltata fuoriuna qualche risposta, che di solito prevedeva di raccontare a sua mammache cosa lo preoccupava. Ma questa volta non c’era niente che lei potessefare. Non l’avrebbe trasferito in un’altra scuola, e comunque le cose nonsarebbero cambiate granché. Lui sarebbe rimasto com’era, e questo, glisembrava, era il problema di fondo. Semplice: non era fatto per la scuola.Tutto qui. E come facevi a spiegarlo? Potevi non essere adatto per alcunecose (sapeva già di non essere adatto per le feste perché era troppo timido,o per i pantaloni larghi, perché aveva le gambe troppo corte), ma non esserefatto per la scuola era un problema grosso. Tutti andavano a scuola. Nonc’era verso di evitarla.2Per tutta la notte i suoi pensieri furono come un boomerang: un’idea sfrec-ciava via lontana dalla scuola e dalla realtà e lo rendeva felice, poi però co-minciava il viaggio di ritorno e il suo tormento si rifaceva vivo. E il mattinocontinuava implacabile ad avvicinarsi. A colazione rimase in silenzio. – Tiabituerai – disse sua mamma, probabilmente perché si accorse che aveval’aria triste mentre mangiava i cereali. Lui annuì e le sorrise. Arrivò a scuolapresto, andò in classe, si sedette al suo banco. Lì era abbastanza al sicuro.Era improbabile che i ragazzi che lo avevano infastidito il giorno prima fosserodi quelli che arrivavano a scuola presto; erano di sicuro da qualcheparte a bighellonare o infastidire la gente, pensò.3Nell’aula c’erano un paio di ragazze, che però lo ignorarono, a meno che larisata che udì mentre tirava fuori il libro di lettura non avesse qualcosa ache fare con lui. Cosa c’era da ridere? Niente, se non eri il tipo che andavasempre alla ricerca di qualcosa di cui ridere. Sfortunatamente, però, i ragazziche aveva conosciuto Marcus erano quasi tutti così. Pattugliavano su e giùi corridoi alla ricerca di pantaloni sbagliati o pettinature sbagliate o scarpeda ginnastica sbagliate. Dato che di solito Marcus indossava le scarpe sbagliateo i pantaloni sbagliati e il suo taglio di capelli era immancabilmentesbagliato, non doveva far molto per farli divertire. Marcus sapeva di esserestrambo ma sua madre non lo capiva affatto.Gli ripeteva sempre che solo le persone superficiali giudicano dai vestiti odai capelli; gli proibiva di guardare la televisione spazzatura, o di ascoltaremusica spazzatura o di giocare con videogiochi spazzatura: questo significavache se voleva fare qualsiasi cosa facevano tutti gli altri ragazzi, lui dovevadiscutere con lei per ore. Di solito perdeva, ma lei era così brava adiscutere che non gli dispiaceva perdere.
Riad. da Nick Hornby, Un ragazzo, Tea
L’ANSIA DELLA SCUOLA
5
10
15
20
25
30
35
40
1La notte dopo il suo primo giorno di scuola Marcus si svegliò ogni mezz’orao quasi. Se ne accorse dalle lancette luminose del suo orologio. Non riu-sciva a credere che sarebbe dovuto ritornare la mattina dopo e la mattinadopo ancora e… be’, poi ci sarebbe stato il week-end, ma in un modo onell’altro ogni mattina per il resto della sua vita, più o meno. Ogni volta chesi svegliava il suo primo pensiero era che ci doveva essere un sistema persuperare quell’orribile sensazione, o aggirarla, o anche conviverci; ogni voltache si era agitato per qualcosa in passato, di solito era sempre saltata fuoriuna qualche risposta, che di solito prevedeva di raccontare a sua mammache cosa lo preoccupava. Ma questa volta non c’era niente che lei potessefare. Non l’avrebbe trasferito in un’altra scuola, e comunque le cose nonsarebbero cambiate granché. Lui sarebbe rimasto com’era, e questo, glisembrava, era il problema di fondo. Semplice: non era fatto per la scuola.Tutto qui. E come facevi a spiegarlo? Potevi non essere adatto per alcunecose (sapeva già di non essere adatto per le feste perché era troppo timido,o per i pantaloni larghi, perché aveva le gambe troppo corte), ma non esserefatto per la scuola era un problema grosso. Tutti andavano a scuola. Nonc’era verso di evitarla.2Per tutta la notte i suoi pensieri furono come un boomerang: un’idea sfrec-ciava via lontana dalla scuola e dalla realtà e lo rendeva felice, poi però co-minciava il viaggio di ritorno e il suo tormento si rifaceva vivo. E il mattinocontinuava implacabile ad avvicinarsi. A colazione rimase in silenzio. – Tiabituerai – disse sua mamma, probabilmente perché si accorse che aveval’aria triste mentre mangiava i cereali. Lui annuì e le sorrise. Arrivò a scuolapresto, andò in classe, si sedette al suo banco. Lì era abbastanza al sicuro.Era improbabile che i ragazzi che lo avevano infastidito il giorno prima fosserodi quelli che arrivavano a scuola presto; erano di sicuro da qualcheparte a bighellonare o infastidire la gente, pensò.3Nell’aula c’erano un paio di ragazze, che però lo ignorarono, a meno che larisata che udì mentre tirava fuori il libro di lettura non avesse qualcosa ache fare con lui. Cosa c’era da ridere? Niente, se non eri il tipo che andavasempre alla ricerca di qualcosa di cui ridere. Sfortunatamente, però, i ragazziche aveva conosciuto Marcus erano quasi tutti così. Pattugliavano su e giùi corridoi alla ricerca di pantaloni sbagliati o pettinature sbagliate o scarpeda ginnastica sbagliate. Dato che di solito Marcus indossava le scarpe sbagliateo i pantaloni sbagliati e il suo taglio di capelli era immancabilmentesbagliato, non doveva far molto per farli divertire. Marcus sapeva di esserestrambo ma sua madre non lo capiva affatto.Gli ripeteva sempre che solo le persone superficiali giudicano dai vestiti odai capelli; gli proibiva di guardare la televisione spazzatura, o di ascoltaremusica spazzatura o di giocare con videogiochi spazzatura: questo significavache se voleva fare qualsiasi cosa facevano tutti gli altri ragazzi, lui dovevadiscutere con lei per ore. Di solito perdeva, ma lei era così brava adiscutere che non gli dispiaceva perdere.
Riad. da Nick Hornby, Un ragazzo, Tea
A10 Abbina ciascun titolo alla parte di testo corrispondente.
1.
Un bambino sbagliato.
2.
Non son fatto per la scuola.
3.
Pensieri tormentati.
1
5
10
15
20
25
30
35
40
1La notte dopo il suo primo giorno di scuola Marcus si svegliò ogni mezz’orao quasi. Se ne accorse dalle lancette luminose del suo orologio. Non riu-sciva a credere che sarebbe dovuto ritornare la mattina dopo e la mattinadopo ancora e… be’, poi ci sarebbe stato il week-end, ma in un modo onell’altro ogni mattina per il resto della sua vita, più o meno. Ogni volta chesi svegliava il suo primo pensiero era che ci doveva essere un sistema persuperare quell’orribile sensazione, o aggirarla, o anche conviverci; ogni voltache si era agitato per qualcosa in passato, di solito era sempre saltata fuoriuna qualche risposta, che di solito prevedeva di raccontare a sua mammache cosa lo preoccupava. Ma questa volta non c’era niente che lei potessefare. Non l’avrebbe trasferito in un’altra scuola, e comunque le cose nonsarebbero cambiate granché. Lui sarebbe rimasto com’era, e questo, glisembrava, era il problema di fondo. Semplice: non era fatto per la scuola.Tutto qui. E come facevi a spiegarlo? Potevi non essere adatto per alcunecose (sapeva già di non essere adatto per le feste perché era troppo timido,o per i pantaloni larghi, perché aveva le gambe troppo corte), ma non esserefatto per la scuola era un problema grosso. Tutti andavano a scuola. Nonc’era verso di evitarla.2Per tutta la notte i suoi pensieri furono come un boomerang: un’idea sfrec-ciava via lontana dalla scuola e dalla realtà e lo rendeva felice, poi però co-minciava il viaggio di ritorno e il suo tormento si rifaceva vivo. E il mattinocontinuava implacabile ad avvicinarsi. A colazione rimase in silenzio. – Tiabituerai – disse sua mamma, probabilmente perché si accorse che aveval’aria triste mentre mangiava i cereali. Lui annuì e le sorrise. Arrivò a scuolapresto, andò in classe, si sedette al suo banco. Lì era abbastanza al sicuro.Era improbabile che i ragazzi che lo avevano infastidito il giorno prima fosserodi quelli che arrivavano a scuola presto; erano di sicuro da qualcheparte a bighellonare o infastidire la gente, pensò.3Nell’aula c’erano un paio di ragazze, che però lo ignorarono, a meno che larisata che udì mentre tirava fuori il libro di lettura non avesse qualcosa ache fare con lui. Cosa c’era da ridere? Niente, se non eri il tipo che andavasempre alla ricerca di qualcosa di cui ridere. Sfortunatamente, però, i ragazziche aveva conosciuto Marcus erano quasi tutti così. Pattugliavano su e giùi corridoi alla ricerca di pantaloni sbagliati o pettinature sbagliate o scarpeda ginnastica sbagliate. Dato che di solito Marcus indossava le scarpe sbagliateo i pantaloni sbagliati e il suo taglio di capelli era immancabilmentesbagliato, non doveva far molto per farli divertire. Marcus sapeva di esserestrambo ma sua madre non lo capiva affatto.Gli ripeteva sempre che solo le persone superficiali giudicano dai vestiti odai capelli; gli proibiva di guardare la televisione spazzatura, o di ascoltaremusica spazzatura o di giocare con videogiochi spazzatura: questo significavache se voleva fare qualsiasi cosa facevano tutti gli altri ragazzi, lui dovevadiscutere con lei per ore. Di solito perdeva, ma lei era così brava adiscutere che non gli dispiaceva perdere.
Riad. da Nick Hornby, Un ragazzo, Tea
L’ANSIA DELLA SCUOLA
5
10
15
20
25
30
35
40
1La notte dopo il suo primo giorno di scuola Marcus si svegliò ogni mezz’orao quasi. Se ne accorse dalle lancette luminose del suo orologio. Non riu-sciva a credere che sarebbe dovuto ritornare la mattina dopo e la mattinadopo ancora e… be’, poi ci sarebbe stato il week-end, ma in un modo onell’altro ogni mattina per il resto della sua vita, più o meno. Ogni volta chesi svegliava il suo primo pensiero era che ci doveva essere un sistema persuperare quell’orribile sensazione, o aggirarla, o anche conviverci; ogni voltache si era agitato per qualcosa in passato, di solito era sempre saltata fuoriuna qualche risposta, che di solito prevedeva di raccontare a sua mammache cosa lo preoccupava. Ma questa volta non c’era niente che lei potessefare. Non l’avrebbe trasferito in un’altra scuola, e comunque le cose nonsarebbero cambiate granché. Lui sarebbe rimasto com’era, e questo, glisembrava, era il problema di fondo. Semplice: non era fatto per la scuola.Tutto qui. E come facevi a spiegarlo? Potevi non essere adatto per alcunecose (sapeva già di non essere adatto per le feste perché era troppo timido,o per i pantaloni larghi, perché aveva le gambe troppo corte), ma non esserefatto per la scuola era un problema grosso. Tutti andavano a scuola. Nonc’era verso di evitarla.2Per tutta la notte i suoi pensieri furono come un boomerang: un’idea sfrec-ciava via lontana dalla scuola e dalla realtà e lo rendeva felice, poi però co-minciava il viaggio di ritorno e il suo tormento si rifaceva vivo. E il mattinocontinuava implacabile ad avvicinarsi. A colazione rimase in silenzio. – Tiabituerai – disse sua mamma, probabilmente perché si accorse che aveval’aria triste mentre mangiava i cereali. Lui annuì e le sorrise. Arrivò a scuolapresto, andò in classe, si sedette al suo banco. Lì era abbastanza al sicuro.Era improbabile che i ragazzi che lo avevano infastidito il giorno prima fosserodi quelli che arrivavano a scuola presto; erano di sicuro da qualcheparte a bighellonare o infastidire la gente, pensò.3Nell’aula c’erano un paio di ragazze, che però lo ignorarono, a meno che larisata che udì mentre tirava fuori il libro di lettura non avesse qualcosa ache fare con lui. Cosa c’era da ridere? Niente, se non eri il tipo che andavasempre alla ricerca di qualcosa di cui ridere. Sfortunatamente, però, i ragazziche aveva conosciuto Marcus erano quasi tutti così. Pattugliavano su e giùi corridoi alla ricerca di pantaloni sbagliati o pettinature sbagliate o scarpeda ginnastica sbagliate. Dato che di solito Marcus indossava le scarpe sbagliateo i pantaloni sbagliati e il suo taglio di capelli era immancabilmentesbagliato, non doveva far molto per farli divertire. Marcus sapeva di esserestrambo ma sua madre non lo capiva affatto.Gli ripeteva sempre che solo le persone superficiali giudicano dai vestiti odai capelli; gli proibiva di guardare la televisione spazzatura, o di ascoltaremusica spazzatura o di giocare con videogiochi spazzatura: questo significavache se voleva fare qualsiasi cosa facevano tutti gli altri ragazzi, lui dovevadiscutere con lei per ore. Di solito perdeva, ma lei era così brava adiscutere che non gli dispiaceva perdere.
Riad. da Nick Hornby, Un ragazzo, Tea
A11 Che cosa fa sì che i ragazzi a scuola deridano Marcus?
A. I programmi tv che guarda.
B. Il suo aspetto poco alla moda.
C. Il fatto di non avere amici.
D. I comportamenti della mamma.
1
5
10
15
20
25
30
35
40
1La notte dopo il suo primo giorno di scuola Marcus si svegliò ogni mezz’orao quasi. Se ne accorse dalle lancette luminose del suo orologio. Non riu-sciva a credere che sarebbe dovuto ritornare la mattina dopo e la mattinadopo ancora e… be’, poi ci sarebbe stato il week-end, ma in un modo onell’altro ogni mattina per il resto della sua vita, più o meno. Ogni volta chesi svegliava il suo primo pensiero era che ci doveva essere un sistema persuperare quell’orribile sensazione, o aggirarla, o anche conviverci; ogni voltache si era agitato per qualcosa in passato, di solito era sempre saltata fuoriuna qualche risposta, che di solito prevedeva di raccontare a sua mammache cosa lo preoccupava. Ma questa volta non c’era niente che lei potessefare. Non l’avrebbe trasferito in un’altra scuola, e comunque le cose nonsarebbero cambiate granché. Lui sarebbe rimasto com’era, e questo, glisembrava, era il problema di fondo. Semplice: non era fatto per la scuola.Tutto qui. E come facevi a spiegarlo? Potevi non essere adatto per alcunecose (sapeva già di non essere adatto per le feste perché era troppo timido,o per i pantaloni larghi, perché aveva le gambe troppo corte), ma non esserefatto per la scuola era un problema grosso. Tutti andavano a scuola. Nonc’era verso di evitarla.2Per tutta la notte i suoi pensieri furono come un boomerang: un’idea sfrec-ciava via lontana dalla scuola e dalla realtà e lo rendeva felice, poi però co-minciava il viaggio di ritorno e il suo tormento si rifaceva vivo. E il mattinocontinuava implacabile ad avvicinarsi. A colazione rimase in silenzio. – Tiabituerai – disse sua mamma, probabilmente perché si accorse che aveval’aria triste mentre mangiava i cereali. Lui annuì e le sorrise. Arrivò a scuolapresto, andò in classe, si sedette al suo banco. Lì era abbastanza al sicuro.Era improbabile che i ragazzi che lo avevano infastidito il giorno prima fosserodi quelli che arrivavano a scuola presto; erano di sicuro da qualcheparte a bighellonare o infastidire la gente, pensò.3Nell’aula c’erano un paio di ragazze, che però lo ignorarono, a meno che larisata che udì mentre tirava fuori il libro di lettura non avesse qualcosa ache fare con lui. Cosa c’era da ridere? Niente, se non eri il tipo che andavasempre alla ricerca di qualcosa di cui ridere. Sfortunatamente, però, i ragazziche aveva conosciuto Marcus erano quasi tutti così. Pattugliavano su e giùi corridoi alla ricerca di pantaloni sbagliati o pettinature sbagliate o scarpeda ginnastica sbagliate. Dato che di solito Marcus indossava le scarpe sbagliateo i pantaloni sbagliati e il suo taglio di capelli era immancabilmentesbagliato, non doveva far molto per farli divertire. Marcus sapeva di esserestrambo ma sua madre non lo capiva affatto.Gli ripeteva sempre che solo le persone superficiali giudicano dai vestiti odai capelli; gli proibiva di guardare la televisione spazzatura, o di ascoltaremusica spazzatura o di giocare con videogiochi spazzatura: questo significavache se voleva fare qualsiasi cosa facevano tutti gli altri ragazzi, lui dovevadiscutere con lei per ore. Di solito perdeva, ma lei era così brava adiscutere che non gli dispiaceva perdere.
Riad. da Nick Hornby, Un ragazzo, Tea
L’ANSIA DELLA SCUOLA
5
10
15
20
25
30
35
40
1La notte dopo il suo primo giorno di scuola Marcus si svegliò ogni mezz’orao quasi. Se ne accorse dalle lancette luminose del suo orologio. Non riu-sciva a credere che sarebbe dovuto ritornare la mattina dopo e la mattinadopo ancora e… be’, poi ci sarebbe stato il week-end, ma in un modo onell’altro ogni mattina per il resto della sua vita, più o meno. Ogni volta chesi svegliava il suo primo pensiero era che ci doveva essere un sistema persuperare quell’orribile sensazione, o aggirarla, o anche conviverci; ogni voltache si era agitato per qualcosa in passato, di solito era sempre saltata fuoriuna qualche risposta, che di solito prevedeva di raccontare a sua mammache cosa lo preoccupava. Ma questa volta non c’era niente che lei potessefare. Non l’avrebbe trasferito in un’altra scuola, e comunque le cose nonsarebbero cambiate granché. Lui sarebbe rimasto com’era, e questo, glisembrava, era il problema di fondo. Semplice: non era fatto per la scuola.Tutto qui. E come facevi a spiegarlo? Potevi non essere adatto per alcunecose (sapeva già di non essere adatto per le feste perché era troppo timido,o per i pantaloni larghi, perché aveva le gambe troppo corte), ma non esserefatto per la scuola era un problema grosso. Tutti andavano a scuola. Nonc’era verso di evitarla.2Per tutta la notte i suoi pensieri furono come un boomerang: un’idea sfrec-ciava via lontana dalla scuola e dalla realtà e lo rendeva felice, poi però co-minciava il viaggio di ritorno e il suo tormento si rifaceva vivo. E il mattinocontinuava implacabile ad avvicinarsi. A colazione rimase in silenzio. – Tiabituerai – disse sua mamma, probabilmente perché si accorse che aveval’aria triste mentre mangiava i cereali. Lui annuì e le sorrise. Arrivò a scuolapresto, andò in classe, si sedette al suo banco. Lì era abbastanza al sicuro.Era improbabile che i ragazzi che lo avevano infastidito il giorno prima fosserodi quelli che arrivavano a scuola presto; erano di sicuro da qualcheparte a bighellonare o infastidire la gente, pensò.3Nell’aula c’erano un paio di ragazze, che però lo ignorarono, a meno che larisata che udì mentre tirava fuori il libro di lettura non avesse qualcosa ache fare con lui. Cosa c’era da ridere? Niente, se non eri il tipo che andavasempre alla ricerca di qualcosa di cui ridere. Sfortunatamente, però, i ragazziche aveva conosciuto Marcus erano quasi tutti così. Pattugliavano su e giùi corridoi alla ricerca di pantaloni sbagliati o pettinature sbagliate o scarpeda ginnastica sbagliate. Dato che di solito Marcus indossava le scarpe sbagliateo i pantaloni sbagliati e il suo taglio di capelli era immancabilmentesbagliato, non doveva far molto per farli divertire. Marcus sapeva di esserestrambo ma sua madre non lo capiva affatto.Gli ripeteva sempre che solo le persone superficiali giudicano dai vestiti odai capelli; gli proibiva di guardare la televisione spazzatura, o di ascoltaremusica spazzatura o di giocare con videogiochi spazzatura: questo significavache se voleva fare qualsiasi cosa facevano tutti gli altri ragazzi, lui dovevadiscutere con lei per ore. Di solito perdeva, ma lei era così brava adiscutere che non gli dispiaceva perdere.
Riad. da Nick Hornby, Un ragazzo, Tea
A12 Rileggi con attenzione il testo e indica se ciascuna affermazione che descrive il rapporto tra Marcus e la mamma è VERA o FALSA.
| VERO | FALSO | |
|---|---|---|
| 1. Marcus è obbligato a raccontare tutto alla mamma. | | |
| 2. La mamma non vuole aiutare Marcus a risolvere i suoi problemi. | | |
| 3. Di solito, raccontare alla mamma i suoi problemi aiutava Marcus a risolverli. | | |
| 4. A colazione la mamma cerca di tranquillizzare Marcus. | | |
| 5. Marcus supera i suoi problemi dopo l’incoraggiamento della mamma. | | |
| 6. A Marcus piace avere delle discussioni con la mamma, anche se vince lei. | | |
1
5
10
15
20
25
PARTE 1I cognomi sono nati per la necessità di distinguere le persone tra loro e dicensire la popolazione. E ovviamente i cognomi italiani non fanno eccezione.--------------------------- 1 ---------------------------Un primo registro di nomi esisteva già in età romana: i cittadini venivano se-gnati con un praenomen (cioè il nome personale, per esempio «Caio»), e conl’indicazione della gens (cioè della famiglia di provenienza, «Giulia» per esemp-io). Quando questi due nomi non furono più sufficienti a distinguere le per-sone, perché gli omonimi (ossia le persone con lo stesso praenomen e lastessa gens) erano diventati troppi, si aggiunse un cognomen, cioè un so-prannome.Per esempio «Cesare», che significa «colui che ha gli occhi chiari».--------------------------- 2 ---------------------------Ma perché, allora, i cognomi romani non sono giunti fino a noi? Semplice:perché dopo la caduta dell'impero i registri ufficiali creati dai governi degliimperatori romani andarono distrutti o perduti. E per molti anni, in seguitoall'imbarbarimento e al cambiamento della società, non si sentì più il bisognoné di cognomi né, ovviamente, dei registri.Successivamente, in Europa, precisamente tra il X e l’XI secolo, gli abitantiaumentarono di numero e, per distinguere le persone e per facilitare e re-ndere sicuri gli atti pubblici, per esempio le compravendite, diventò semprepiù comune l’uso di un cognome.Tale cognome poteva, ad esempio, derivare da una certa caratteristica fisicao da un soprannome (Rossi per le persone rosse di capelli, per esempio),oppure dalla zona di provenienza (come Leonardo: dal paese di Vinci, in To-scana), dal lavoro svolto (Tintori, Bovari ...) o dalla patronimia (cioè il nomedel padre: per esempio Iohannes filius Arnaldi diventerà Giovanni Arnaldi).L'uso del cognome fu reso obbligatorio in Italia nel 1564.
L’USO DEL COGNOME
5
10
15
20
25
PARTE 1I cognomi sono nati per la necessità di distinguere le persone tra loro e dicensire la popolazione. E ovviamente i cognomi italiani non fanno eccezione.--------------------------- 1 ---------------------------Un primo registro di nomi esisteva già in età romana: i cittadini venivano se-gnati con un praenomen (cioè il nome personale, per esempio «Caio»), e conl’indicazione della gens (cioè della famiglia di provenienza, «Giulia» per esemp-io). Quando questi due nomi non furono più sufficienti a distinguere le per-sone, perché gli omonimi (ossia le persone con lo stesso praenomen e lastessa gens) erano diventati troppi, si aggiunse un cognomen, cioè un so-prannome.Per esempio «Cesare», che significa «colui che ha gli occhi chiari».--------------------------- 2 ---------------------------Ma perché, allora, i cognomi romani non sono giunti fino a noi? Semplice:perché dopo la caduta dell'impero i registri ufficiali creati dai governi degliimperatori romani andarono distrutti o perduti. E per molti anni, in seguitoall'imbarbarimento e al cambiamento della società, non si sentì più il bisognoné di cognomi né, ovviamente, dei registri.Successivamente, in Europa, precisamente tra il X e l’XI secolo, gli abitantiaumentarono di numero e, per distinguere le persone e per facilitare e re-ndere sicuri gli atti pubblici, per esempio le compravendite, diventò semprepiù comune l’uso di un cognome.Tale cognome poteva, ad esempio, derivare da una certa caratteristica fisicao da un soprannome (Rossi per le persone rosse di capelli, per esempio),oppure dalla zona di provenienza (come Leonardo: dal paese di Vinci, in To-scana), dal lavoro svolto (Tintori, Bovari ...) o dalla patronimia (cioè il nomedel padre: per esempio Iohannes filius Arnaldi diventerà Giovanni Arnaldi).L'uso del cognome fu reso obbligatorio in Italia nel 1564.
B1 Quale attività veniva svolta per censire la popolazione?
A. Veniva dato un praenomen alle persone.
B. Veniva dato un cognome ai cittadini.
C. Si compilava un registro di nomi.
D. Si distruggevano i registri romani.
1
5
10
15
20
25
PARTE 1I cognomi sono nati per la necessità di distinguere le persone tra loro e dicensire la popolazione. E ovviamente i cognomi italiani non fanno eccezione.--------------------------- 1 ---------------------------Un primo registro di nomi esisteva già in età romana: i cittadini venivano se-gnati con un praenomen (cioè il nome personale, per esempio «Caio»), e conl’indicazione della gens (cioè della famiglia di provenienza, «Giulia» per esemp-io). Quando questi due nomi non furono più sufficienti a distinguere le per-sone, perché gli omonimi (ossia le persone con lo stesso praenomen e lastessa gens) erano diventati troppi, si aggiunse un cognomen, cioè un so-prannome.Per esempio «Cesare», che significa «colui che ha gli occhi chiari».--------------------------- 2 ---------------------------Ma perché, allora, i cognomi romani non sono giunti fino a noi? Semplice:perché dopo la caduta dell'impero i registri ufficiali creati dai governi degliimperatori romani andarono distrutti o perduti. E per molti anni, in seguitoall'imbarbarimento e al cambiamento della società, non si sentì più il bisognoné di cognomi né, ovviamente, dei registri.Successivamente, in Europa, precisamente tra il X e l’XI secolo, gli abitantiaumentarono di numero e, per distinguere le persone e per facilitare e re-ndere sicuri gli atti pubblici, per esempio le compravendite, diventò semprepiù comune l’uso di un cognome.Tale cognome poteva, ad esempio, derivare da una certa caratteristica fisicao da un soprannome (Rossi per le persone rosse di capelli, per esempio),oppure dalla zona di provenienza (come Leonardo: dal paese di Vinci, in To-scana), dal lavoro svolto (Tintori, Bovari ...) o dalla patronimia (cioè il nomedel padre: per esempio Iohannes filius Arnaldi diventerà Giovanni Arnaldi).L'uso del cognome fu reso obbligatorio in Italia nel 1564.
L’USO DEL COGNOME
5
10
15
20
25
PARTE 1I cognomi sono nati per la necessità di distinguere le persone tra loro e dicensire la popolazione. E ovviamente i cognomi italiani non fanno eccezione.--------------------------- 1 ---------------------------Un primo registro di nomi esisteva già in età romana: i cittadini venivano se-gnati con un praenomen (cioè il nome personale, per esempio «Caio»), e conl’indicazione della gens (cioè della famiglia di provenienza, «Giulia» per esemp-io). Quando questi due nomi non furono più sufficienti a distinguere le per-sone, perché gli omonimi (ossia le persone con lo stesso praenomen e lastessa gens) erano diventati troppi, si aggiunse un cognomen, cioè un so-prannome.Per esempio «Cesare», che significa «colui che ha gli occhi chiari».--------------------------- 2 ---------------------------Ma perché, allora, i cognomi romani non sono giunti fino a noi? Semplice:perché dopo la caduta dell'impero i registri ufficiali creati dai governi degliimperatori romani andarono distrutti o perduti. E per molti anni, in seguitoall'imbarbarimento e al cambiamento della società, non si sentì più il bisognoné di cognomi né, ovviamente, dei registri.Successivamente, in Europa, precisamente tra il X e l’XI secolo, gli abitantiaumentarono di numero e, per distinguere le persone e per facilitare e re-ndere sicuri gli atti pubblici, per esempio le compravendite, diventò semprepiù comune l’uso di un cognome.Tale cognome poteva, ad esempio, derivare da una certa caratteristica fisicao da un soprannome (Rossi per le persone rosse di capelli, per esempio),oppure dalla zona di provenienza (come Leonardo: dal paese di Vinci, in To-scana), dal lavoro svolto (Tintori, Bovari ...) o dalla patronimia (cioè il nomedel padre: per esempio Iohannes filius Arnaldi diventerà Giovanni Arnaldi).L'uso del cognome fu reso obbligatorio in Italia nel 1564.
B2 Completa e ricostruisci le catene di cause ed effetti.
| CAUSA | EFFETTO |
| bisogno di censire la popolazione | |
| perdita dei cognomi romani | |
| rendere sicuri gli atti pubblici |
1
5
10
15
20
25
PARTE 1I cognomi sono nati per la necessità di distinguere le persone tra loro e dicensire la popolazione. E ovviamente i cognomi italiani non fanno eccezione.--------------------------- 1 ---------------------------Un primo registro di nomi esisteva già in età romana: i cittadini venivano se-gnati con un praenomen (cioè il nome personale, per esempio «Caio»), e conl’indicazione della gens (cioè della famiglia di provenienza, «Giulia» per esemp-io). Quando questi due nomi non furono più sufficienti a distinguere le per-sone, perché gli omonimi (ossia le persone con lo stesso praenomen e lastessa gens) erano diventati troppi, si aggiunse un cognomen, cioè un so-prannome.Per esempio «Cesare», che significa «colui che ha gli occhi chiari».--------------------------- 2 ---------------------------Ma perché, allora, i cognomi romani non sono giunti fino a noi? Semplice:perché dopo la caduta dell'impero i registri ufficiali creati dai governi degliimperatori romani andarono distrutti o perduti. E per molti anni, in seguitoall'imbarbarimento e al cambiamento della società, non si sentì più il bisognoné di cognomi né, ovviamente, dei registri.Successivamente, in Europa, precisamente tra il X e l’XI secolo, gli abitantiaumentarono di numero e, per distinguere le persone e per facilitare e re-ndere sicuri gli atti pubblici, per esempio le compravendite, diventò semprepiù comune l’uso di un cognome.Tale cognome poteva, ad esempio, derivare da una certa caratteristica fisicao da un soprannome (Rossi per le persone rosse di capelli, per esempio),oppure dalla zona di provenienza (come Leonardo: dal paese di Vinci, in To-scana), dal lavoro svolto (Tintori, Bovari ...) o dalla patronimia (cioè il nomedel padre: per esempio Iohannes filius Arnaldi diventerà Giovanni Arnaldi).L'uso del cognome fu reso obbligatorio in Italia nel 1564.
L’USO DEL COGNOME
5
10
15
20
25
PARTE 1I cognomi sono nati per la necessità di distinguere le persone tra loro e dicensire la popolazione. E ovviamente i cognomi italiani non fanno eccezione.--------------------------- 1 ---------------------------Un primo registro di nomi esisteva già in età romana: i cittadini venivano se-gnati con un praenomen (cioè il nome personale, per esempio «Caio»), e conl’indicazione della gens (cioè della famiglia di provenienza, «Giulia» per esemp-io). Quando questi due nomi non furono più sufficienti a distinguere le per-sone, perché gli omonimi (ossia le persone con lo stesso praenomen e lastessa gens) erano diventati troppi, si aggiunse un cognomen, cioè un so-prannome.Per esempio «Cesare», che significa «colui che ha gli occhi chiari».--------------------------- 2 ---------------------------Ma perché, allora, i cognomi romani non sono giunti fino a noi? Semplice:perché dopo la caduta dell'impero i registri ufficiali creati dai governi degliimperatori romani andarono distrutti o perduti. E per molti anni, in seguitoall'imbarbarimento e al cambiamento della società, non si sentì più il bisognoné di cognomi né, ovviamente, dei registri.Successivamente, in Europa, precisamente tra il X e l’XI secolo, gli abitantiaumentarono di numero e, per distinguere le persone e per facilitare e re-ndere sicuri gli atti pubblici, per esempio le compravendite, diventò semprepiù comune l’uso di un cognome.Tale cognome poteva, ad esempio, derivare da una certa caratteristica fisicao da un soprannome (Rossi per le persone rosse di capelli, per esempio),oppure dalla zona di provenienza (come Leonardo: dal paese di Vinci, in To-scana), dal lavoro svolto (Tintori, Bovari ...) o dalla patronimia (cioè il nomedel padre: per esempio Iohannes filius Arnaldi diventerà Giovanni Arnaldi).L'uso del cognome fu reso obbligatorio in Italia nel 1564.
B3 Completa la frase.
Ai cittadini romani fu dato per la necessità di distinguere .
1
5
10
15
20
25
PARTE 1I cognomi sono nati per la necessità di distinguere le persone tra loro e dicensire la popolazione. E ovviamente i cognomi italiani non fanno eccezione.--------------------------- 1 ---------------------------Un primo registro di nomi esisteva già in età romana: i cittadini venivano se-gnati con un praenomen (cioè il nome personale, per esempio «Caio»), e conl’indicazione della gens (cioè della famiglia di provenienza, «Giulia» per esemp-io). Quando questi due nomi non furono più sufficienti a distinguere le per-sone, perché gli omonimi (ossia le persone con lo stesso praenomen e lastessa gens) erano diventati troppi, si aggiunse un cognomen, cioè un so-prannome.Per esempio «Cesare», che significa «colui che ha gli occhi chiari».--------------------------- 2 ---------------------------Ma perché, allora, i cognomi romani non sono giunti fino a noi? Semplice:perché dopo la caduta dell'impero i registri ufficiali creati dai governi degliimperatori romani andarono distrutti o perduti. E per molti anni, in seguitoall'imbarbarimento e al cambiamento della società, non si sentì più il bisognoné di cognomi né, ovviamente, dei registri.Successivamente, in Europa, precisamente tra il X e l’XI secolo, gli abitantiaumentarono di numero e, per distinguere le persone e per facilitare e re-ndere sicuri gli atti pubblici, per esempio le compravendite, diventò semprepiù comune l’uso di un cognome.Tale cognome poteva, ad esempio, derivare da una certa caratteristica fisicao da un soprannome (Rossi per le persone rosse di capelli, per esempio),oppure dalla zona di provenienza (come Leonardo: dal paese di Vinci, in To-scana), dal lavoro svolto (Tintori, Bovari ...) o dalla patronimia (cioè il nomedel padre: per esempio Iohannes filius Arnaldi diventerà Giovanni Arnaldi).L'uso del cognome fu reso obbligatorio in Italia nel 1564.
L’USO DEL COGNOME
5
10
15
20
25
PARTE 1I cognomi sono nati per la necessità di distinguere le persone tra loro e dicensire la popolazione. E ovviamente i cognomi italiani non fanno eccezione.--------------------------- 1 ---------------------------Un primo registro di nomi esisteva già in età romana: i cittadini venivano se-gnati con un praenomen (cioè il nome personale, per esempio «Caio»), e conl’indicazione della gens (cioè della famiglia di provenienza, «Giulia» per esemp-io). Quando questi due nomi non furono più sufficienti a distinguere le per-sone, perché gli omonimi (ossia le persone con lo stesso praenomen e lastessa gens) erano diventati troppi, si aggiunse un cognomen, cioè un so-prannome.Per esempio «Cesare», che significa «colui che ha gli occhi chiari».--------------------------- 2 ---------------------------Ma perché, allora, i cognomi romani non sono giunti fino a noi? Semplice:perché dopo la caduta dell'impero i registri ufficiali creati dai governi degliimperatori romani andarono distrutti o perduti. E per molti anni, in seguitoall'imbarbarimento e al cambiamento della società, non si sentì più il bisognoné di cognomi né, ovviamente, dei registri.Successivamente, in Europa, precisamente tra il X e l’XI secolo, gli abitantiaumentarono di numero e, per distinguere le persone e per facilitare e re-ndere sicuri gli atti pubblici, per esempio le compravendite, diventò semprepiù comune l’uso di un cognome.Tale cognome poteva, ad esempio, derivare da una certa caratteristica fisicao da un soprannome (Rossi per le persone rosse di capelli, per esempio),oppure dalla zona di provenienza (come Leonardo: dal paese di Vinci, in To-scana), dal lavoro svolto (Tintori, Bovari ...) o dalla patronimia (cioè il nomedel padre: per esempio Iohannes filius Arnaldi diventerà Giovanni Arnaldi).L'uso del cognome fu reso obbligatorio in Italia nel 1564.
B4 PARTE A Rispondi.
1.
Da quale parola latina deriva l’italiano «cognome»? __
2.
Cosa significa la parola «cognome»? __
B4.1 PARTE B La parola «cognome»:
A. ha mantenuto il suo significato originario.
B. ha una funzione completamente diversa al giorno d’oggi.
C. ha assunto un significato completamente diverso.
D. ha assunto il valore che aveva l’indicazione della gens.
1
5
10
15
20
25
PARTE 1I cognomi sono nati per la necessità di distinguere le persone tra loro e dicensire la popolazione. E ovviamente i cognomi italiani non fanno eccezione.--------------------------- 1 ---------------------------Un primo registro di nomi esisteva già in età romana: i cittadini venivano se-gnati con un praenomen (cioè il nome personale, per esempio «Caio»), e conl’indicazione della gens (cioè della famiglia di provenienza, «Giulia» per esemp-io). Quando questi due nomi non furono più sufficienti a distinguere le per-sone, perché gli omonimi (ossia le persone con lo stesso praenomen e lastessa gens) erano diventati troppi, si aggiunse un cognomen, cioè un so-prannome.Per esempio «Cesare», che significa «colui che ha gli occhi chiari».--------------------------- 2 ---------------------------Ma perché, allora, i cognomi romani non sono giunti fino a noi? Semplice:perché dopo la caduta dell'impero i registri ufficiali creati dai governi degliimperatori romani andarono distrutti o perduti. E per molti anni, in seguitoall'imbarbarimento e al cambiamento della società, non si sentì più il bisognoné di cognomi né, ovviamente, dei registri.Successivamente, in Europa, precisamente tra il X e l’XI secolo, gli abitantiaumentarono di numero e, per distinguere le persone e per facilitare e re-ndere sicuri gli atti pubblici, per esempio le compravendite, diventò semprepiù comune l’uso di un cognome.Tale cognome poteva, ad esempio, derivare da una certa caratteristica fisicao da un soprannome (Rossi per le persone rosse di capelli, per esempio),oppure dalla zona di provenienza (come Leonardo: dal paese di Vinci, in To-scana), dal lavoro svolto (Tintori, Bovari ...) o dalla patronimia (cioè il nomedel padre: per esempio Iohannes filius Arnaldi diventerà Giovanni Arnaldi).L'uso del cognome fu reso obbligatorio in Italia nel 1564.
L’USO DEL COGNOME
5
10
15
20
25
PARTE 1I cognomi sono nati per la necessità di distinguere le persone tra loro e dicensire la popolazione. E ovviamente i cognomi italiani non fanno eccezione.--------------------------- 1 ---------------------------Un primo registro di nomi esisteva già in età romana: i cittadini venivano se-gnati con un praenomen (cioè il nome personale, per esempio «Caio»), e conl’indicazione della gens (cioè della famiglia di provenienza, «Giulia» per esemp-io). Quando questi due nomi non furono più sufficienti a distinguere le per-sone, perché gli omonimi (ossia le persone con lo stesso praenomen e lastessa gens) erano diventati troppi, si aggiunse un cognomen, cioè un so-prannome.Per esempio «Cesare», che significa «colui che ha gli occhi chiari».--------------------------- 2 ---------------------------Ma perché, allora, i cognomi romani non sono giunti fino a noi? Semplice:perché dopo la caduta dell'impero i registri ufficiali creati dai governi degliimperatori romani andarono distrutti o perduti. E per molti anni, in seguitoall'imbarbarimento e al cambiamento della società, non si sentì più il bisognoné di cognomi né, ovviamente, dei registri.Successivamente, in Europa, precisamente tra il X e l’XI secolo, gli abitantiaumentarono di numero e, per distinguere le persone e per facilitare e re-ndere sicuri gli atti pubblici, per esempio le compravendite, diventò semprepiù comune l’uso di un cognome.Tale cognome poteva, ad esempio, derivare da una certa caratteristica fisicao da un soprannome (Rossi per le persone rosse di capelli, per esempio),oppure dalla zona di provenienza (come Leonardo: dal paese di Vinci, in To-scana), dal lavoro svolto (Tintori, Bovari ...) o dalla patronimia (cioè il nomedel padre: per esempio Iohannes filius Arnaldi diventerà Giovanni Arnaldi).L'uso del cognome fu reso obbligatorio in Italia nel 1564.
B5 La parola «imbarbarimento» (riga 14) è derivata da:
A. barba.
B. barbaro.
C. mento.
D. baro.
1
30
35
40
45
PARTE 2--------------------------- 3 ---------------------------Tutti i cognomi, quindi, hanno un significato, visto che traggono origine danomi propri (la maggior parte al Nord) o da soprannomi (soprattutto al Sud),o da professioni o luoghi (in assoluto le categorie più diffuse).Almeno il 75 per cento dei cognomi esistenti sono ancora comprensibili nelloro significato originario. Gli altri hanno probabilmente subìto qualche va-riazione fonetica o grafica che ne ha stravolto il senso, oppure derivano dainfluenze straniere.Ma c'è di più: dallo studio linguistico del cognome è possibile capire il luogod’origine della famiglia che lo porta.Uno stesso mestiere, per esempio quello di fabbro, ha prodotto cognomi di-versi da regione a regione. Così, in Lombardia, Piemonte ed Emilia «fabbro»è diventato Ferrari, Ferrario, Ferreri. Mentre in Toscana e in Veneto è diven-tato Fabbri e Favero e in Campania e nel Lazio si è trasformato in Forgione.--------------------------- 4 ---------------------------Molti cognomi «vegetali» per esempio (Cipolla, Finocchio, Meloni) hanno ori-gine celtica o germanica, perché presso i popoli nordici i riti legati alla naturae alle piante erano numerosi. Quindi sappi che, se ti chiami Zucca o Zucconi,non è perché il tuo trisavolo aveva la testa dura.Infine, un'altra categoria di cognomi molto diffusa deriva dal fatto che in Italiaabbondavano gli orfanotrofi: Esposito, Trovato, Innocenti, ad esempio, sonocognomi che venivano dati ai bambini di origine ignota, ossia ai «trovatelli».Di cognomi strani, poi, noi italiani abbondiamo anche grazie a improbabiliaccoppiate con nomi propri assurdi o inadatti... ma questa è un'altra storia.
Riad. da www.focusjunior.it
TANTI COGNOMI DIVERSI
30
35
40
45
PARTE 2--------------------------- 3 ---------------------------Tutti i cognomi, quindi, hanno un significato, visto che traggono origine danomi propri (la maggior parte al Nord) o da soprannomi (soprattutto al Sud),o da professioni o luoghi (in assoluto le categorie più diffuse).Almeno il 75 per cento dei cognomi esistenti sono ancora comprensibili nelloro significato originario. Gli altri hanno probabilmente subìto qualche va-riazione fonetica o grafica che ne ha stravolto il senso, oppure derivano dainfluenze straniere.Ma c'è di più: dallo studio linguistico del cognome è possibile capire il luogod’origine della famiglia che lo porta.Uno stesso mestiere, per esempio quello di fabbro, ha prodotto cognomi di-versi da regione a regione. Così, in Lombardia, Piemonte ed Emilia «fabbro»è diventato Ferrari, Ferrario, Ferreri. Mentre in Toscana e in Veneto è diven-tato Fabbri e Favero e in Campania e nel Lazio si è trasformato in Forgione.--------------------------- 4 ---------------------------Molti cognomi «vegetali» per esempio (Cipolla, Finocchio, Meloni) hanno ori-gine celtica o germanica, perché presso i popoli nordici i riti legati alla naturae alle piante erano numerosi. Quindi sappi che, se ti chiami Zucca o Zucconi,non è perché il tuo trisavolo aveva la testa dura.Infine, un'altra categoria di cognomi molto diffusa deriva dal fatto che in Italiaabbondavano gli orfanotrofi: Esposito, Trovato, Innocenti, ad esempio, sonocognomi che venivano dati ai bambini di origine ignota, ossia ai «trovatelli».Di cognomi strani, poi, noi italiani abbondiamo anche grazie a improbabiliaccoppiate con nomi propri assurdi o inadatti... ma questa è un'altra storia.
Riad. da www.focusjunior.it
B6 Completa le frasi.
1.
Il cognome Bianchi deriva da una della persona.
2.
Il cognome Pecoraro deriva dal di chi indica.
3.
Il cognome Reali fa riferimento al sociale delle famiglie.
4.
Il cognome Da Napoli è legato al d’origine delle persone.
1
30
35
40
45
PARTE 2--------------------------- 3 ---------------------------Tutti i cognomi, quindi, hanno un significato, visto che traggono origine danomi propri (la maggior parte al Nord) o da soprannomi (soprattutto al Sud),o da professioni o luoghi (in assoluto le categorie più diffuse).Almeno il 75 per cento dei cognomi esistenti sono ancora comprensibili nelloro significato originario. Gli altri hanno probabilmente subìto qualche va-riazione fonetica o grafica che ne ha stravolto il senso, oppure derivano dainfluenze straniere.Ma c'è di più: dallo studio linguistico del cognome è possibile capire il luogod’origine della famiglia che lo porta.Uno stesso mestiere, per esempio quello di fabbro, ha prodotto cognomi di-versi da regione a regione. Così, in Lombardia, Piemonte ed Emilia «fabbro»è diventato Ferrari, Ferrario, Ferreri. Mentre in Toscana e in Veneto è diven-tato Fabbri e Favero e in Campania e nel Lazio si è trasformato in Forgione.--------------------------- 4 ---------------------------Molti cognomi «vegetali» per esempio (Cipolla, Finocchio, Meloni) hanno ori-gine celtica o germanica, perché presso i popoli nordici i riti legati alla naturae alle piante erano numerosi. Quindi sappi che, se ti chiami Zucca o Zucconi,non è perché il tuo trisavolo aveva la testa dura.Infine, un'altra categoria di cognomi molto diffusa deriva dal fatto che in Italiaabbondavano gli orfanotrofi: Esposito, Trovato, Innocenti, ad esempio, sonocognomi che venivano dati ai bambini di origine ignota, ossia ai «trovatelli».Di cognomi strani, poi, noi italiani abbondiamo anche grazie a improbabiliaccoppiate con nomi propri assurdi o inadatti... ma questa è un'altra storia.
Riad. da www.focusjunior.it
TANTI COGNOMI DIVERSI
30
35
40
45
PARTE 2--------------------------- 3 ---------------------------Tutti i cognomi, quindi, hanno un significato, visto che traggono origine danomi propri (la maggior parte al Nord) o da soprannomi (soprattutto al Sud),o da professioni o luoghi (in assoluto le categorie più diffuse).Almeno il 75 per cento dei cognomi esistenti sono ancora comprensibili nelloro significato originario. Gli altri hanno probabilmente subìto qualche va-riazione fonetica o grafica che ne ha stravolto il senso, oppure derivano dainfluenze straniere.Ma c'è di più: dallo studio linguistico del cognome è possibile capire il luogod’origine della famiglia che lo porta.Uno stesso mestiere, per esempio quello di fabbro, ha prodotto cognomi di-versi da regione a regione. Così, in Lombardia, Piemonte ed Emilia «fabbro»è diventato Ferrari, Ferrario, Ferreri. Mentre in Toscana e in Veneto è diven-tato Fabbri e Favero e in Campania e nel Lazio si è trasformato in Forgione.--------------------------- 4 ---------------------------Molti cognomi «vegetali» per esempio (Cipolla, Finocchio, Meloni) hanno ori-gine celtica o germanica, perché presso i popoli nordici i riti legati alla naturae alle piante erano numerosi. Quindi sappi che, se ti chiami Zucca o Zucconi,non è perché il tuo trisavolo aveva la testa dura.Infine, un'altra categoria di cognomi molto diffusa deriva dal fatto che in Italiaabbondavano gli orfanotrofi: Esposito, Trovato, Innocenti, ad esempio, sonocognomi che venivano dati ai bambini di origine ignota, ossia ai «trovatelli».Di cognomi strani, poi, noi italiani abbondiamo anche grazie a improbabiliaccoppiate con nomi propri assurdi o inadatti... ma questa è un'altra storia.
Riad. da www.focusjunior.it
B7 Per ciascun cognome elencato indica se la sua origine è dovuta a un nome proprio, a un soprannome, al mestiere o al luogo d’origine.
1.
Fabbretti.
2.
Romano.
3.
Antoni.
4.
Gatti.
5.
Camilletti.
6.
Garbato.
7.
Panaro.
8.
Padovani.
1
30
35
40
45
PARTE 2--------------------------- 3 ---------------------------Tutti i cognomi, quindi, hanno un significato, visto che traggono origine danomi propri (la maggior parte al Nord) o da soprannomi (soprattutto al Sud),o da professioni o luoghi (in assoluto le categorie più diffuse).Almeno il 75 per cento dei cognomi esistenti sono ancora comprensibili nelloro significato originario. Gli altri hanno probabilmente subìto qualche va-riazione fonetica o grafica che ne ha stravolto il senso, oppure derivano dainfluenze straniere.Ma c'è di più: dallo studio linguistico del cognome è possibile capire il luogod’origine della famiglia che lo porta.Uno stesso mestiere, per esempio quello di fabbro, ha prodotto cognomi di-versi da regione a regione. Così, in Lombardia, Piemonte ed Emilia «fabbro»è diventato Ferrari, Ferrario, Ferreri. Mentre in Toscana e in Veneto è diven-tato Fabbri e Favero e in Campania e nel Lazio si è trasformato in Forgione.--------------------------- 4 ---------------------------Molti cognomi «vegetali» per esempio (Cipolla, Finocchio, Meloni) hanno ori-gine celtica o germanica, perché presso i popoli nordici i riti legati alla naturae alle piante erano numerosi. Quindi sappi che, se ti chiami Zucca o Zucconi,non è perché il tuo trisavolo aveva la testa dura.Infine, un'altra categoria di cognomi molto diffusa deriva dal fatto che in Italiaabbondavano gli orfanotrofi: Esposito, Trovato, Innocenti, ad esempio, sonocognomi che venivano dati ai bambini di origine ignota, ossia ai «trovatelli».Di cognomi strani, poi, noi italiani abbondiamo anche grazie a improbabiliaccoppiate con nomi propri assurdi o inadatti... ma questa è un'altra storia.
Riad. da www.focusjunior.it
TANTI COGNOMI DIVERSI
30
35
40
45
PARTE 2--------------------------- 3 ---------------------------Tutti i cognomi, quindi, hanno un significato, visto che traggono origine danomi propri (la maggior parte al Nord) o da soprannomi (soprattutto al Sud),o da professioni o luoghi (in assoluto le categorie più diffuse).Almeno il 75 per cento dei cognomi esistenti sono ancora comprensibili nelloro significato originario. Gli altri hanno probabilmente subìto qualche va-riazione fonetica o grafica che ne ha stravolto il senso, oppure derivano dainfluenze straniere.Ma c'è di più: dallo studio linguistico del cognome è possibile capire il luogod’origine della famiglia che lo porta.Uno stesso mestiere, per esempio quello di fabbro, ha prodotto cognomi di-versi da regione a regione. Così, in Lombardia, Piemonte ed Emilia «fabbro»è diventato Ferrari, Ferrario, Ferreri. Mentre in Toscana e in Veneto è diven-tato Fabbri e Favero e in Campania e nel Lazio si è trasformato in Forgione.--------------------------- 4 ---------------------------Molti cognomi «vegetali» per esempio (Cipolla, Finocchio, Meloni) hanno ori-gine celtica o germanica, perché presso i popoli nordici i riti legati alla naturae alle piante erano numerosi. Quindi sappi che, se ti chiami Zucca o Zucconi,non è perché il tuo trisavolo aveva la testa dura.Infine, un'altra categoria di cognomi molto diffusa deriva dal fatto che in Italiaabbondavano gli orfanotrofi: Esposito, Trovato, Innocenti, ad esempio, sonocognomi che venivano dati ai bambini di origine ignota, ossia ai «trovatelli».Di cognomi strani, poi, noi italiani abbondiamo anche grazie a improbabiliaccoppiate con nomi propri assurdi o inadatti... ma questa è un'altra storia.
Riad. da www.focusjunior.it
B8 Quale caratteristica accomuna tutti i cognomi?
A. Traggono tutti origine dallo stesso aspetto.
B. Sono tutti risalenti all’epoca romana.
C. Tutti hanno un significato originario.
D. Tutti hanno un significato comprensibile.
1
30
35
40
45
PARTE 2--------------------------- 3 ---------------------------Tutti i cognomi, quindi, hanno un significato, visto che traggono origine danomi propri (la maggior parte al Nord) o da soprannomi (soprattutto al Sud),o da professioni o luoghi (in assoluto le categorie più diffuse).Almeno il 75 per cento dei cognomi esistenti sono ancora comprensibili nelloro significato originario. Gli altri hanno probabilmente subìto qualche va-riazione fonetica o grafica che ne ha stravolto il senso, oppure derivano dainfluenze straniere.Ma c'è di più: dallo studio linguistico del cognome è possibile capire il luogod’origine della famiglia che lo porta.Uno stesso mestiere, per esempio quello di fabbro, ha prodotto cognomi di-versi da regione a regione. Così, in Lombardia, Piemonte ed Emilia «fabbro»è diventato Ferrari, Ferrario, Ferreri. Mentre in Toscana e in Veneto è diven-tato Fabbri e Favero e in Campania e nel Lazio si è trasformato in Forgione.--------------------------- 4 ---------------------------Molti cognomi «vegetali» per esempio (Cipolla, Finocchio, Meloni) hanno ori-gine celtica o germanica, perché presso i popoli nordici i riti legati alla naturae alle piante erano numerosi. Quindi sappi che, se ti chiami Zucca o Zucconi,non è perché il tuo trisavolo aveva la testa dura.Infine, un'altra categoria di cognomi molto diffusa deriva dal fatto che in Italiaabbondavano gli orfanotrofi: Esposito, Trovato, Innocenti, ad esempio, sonocognomi che venivano dati ai bambini di origine ignota, ossia ai «trovatelli».Di cognomi strani, poi, noi italiani abbondiamo anche grazie a improbabiliaccoppiate con nomi propri assurdi o inadatti... ma questa è un'altra storia.
Riad. da www.focusjunior.it
TANTI COGNOMI DIVERSI
30
35
40
45
PARTE 2--------------------------- 3 ---------------------------Tutti i cognomi, quindi, hanno un significato, visto che traggono origine danomi propri (la maggior parte al Nord) o da soprannomi (soprattutto al Sud),o da professioni o luoghi (in assoluto le categorie più diffuse).Almeno il 75 per cento dei cognomi esistenti sono ancora comprensibili nelloro significato originario. Gli altri hanno probabilmente subìto qualche va-riazione fonetica o grafica che ne ha stravolto il senso, oppure derivano dainfluenze straniere.Ma c'è di più: dallo studio linguistico del cognome è possibile capire il luogod’origine della famiglia che lo porta.Uno stesso mestiere, per esempio quello di fabbro, ha prodotto cognomi di-versi da regione a regione. Così, in Lombardia, Piemonte ed Emilia «fabbro»è diventato Ferrari, Ferrario, Ferreri. Mentre in Toscana e in Veneto è diven-tato Fabbri e Favero e in Campania e nel Lazio si è trasformato in Forgione.--------------------------- 4 ---------------------------Molti cognomi «vegetali» per esempio (Cipolla, Finocchio, Meloni) hanno ori-gine celtica o germanica, perché presso i popoli nordici i riti legati alla naturae alle piante erano numerosi. Quindi sappi che, se ti chiami Zucca o Zucconi,non è perché il tuo trisavolo aveva la testa dura.Infine, un'altra categoria di cognomi molto diffusa deriva dal fatto che in Italiaabbondavano gli orfanotrofi: Esposito, Trovato, Innocenti, ad esempio, sonocognomi che venivano dati ai bambini di origine ignota, ossia ai «trovatelli».Di cognomi strani, poi, noi italiani abbondiamo anche grazie a improbabiliaccoppiate con nomi propri assurdi o inadatti... ma questa è un'altra storia.
Riad. da www.focusjunior.it
B9 Un «trisavolo» è:
A. un antenato.
B. un contadino.
C. un cognome nordico.
D. un discendente.
1
5
10
15
20
25
PARTE 1I cognomi sono nati per la necessità di distinguere le persone tra loro e dicensire la popolazione. E ovviamente i cognomi italiani non fanno eccezione.--------------------------- 1 ---------------------------Un primo registro di nomi esisteva già in età romana: i cittadini venivano se-gnati con un praenomen (cioè il nome personale, per esempio «Caio»), e conl’indicazione della gens (cioè della famiglia di provenienza, «Giulia» per esemp-io). Quando questi due nomi non furono più sufficienti a distinguere le per-sone, perché gli omonimi (ossia le persone con lo stesso praenomen e lastessa gens) erano diventati troppi, si aggiunse un cognomen, cioè un so-prannome.Per esempio «Cesare», che significa «colui che ha gli occhi chiari».--------------------------- 2 ---------------------------Ma perché, allora, i cognomi romani non sono giunti fino a noi? Semplice:perché dopo la caduta dell'impero i registri ufficiali creati dai governi degliimperatori romani andarono distrutti o perduti. E per molti anni, in seguitoall'imbarbarimento e al cambiamento della società, non si sentì più il bisognoné di cognomi né, ovviamente, dei registri.Successivamente, in Europa, precisamente tra il X e l’XI secolo, gli abitantiaumentarono di numero e, per distinguere le persone e per facilitare e re-ndere sicuri gli atti pubblici, per esempio le compravendite, diventò semprepiù comune l’uso di un cognome.Tale cognome poteva, ad esempio, derivare da una certa caratteristica fisicao da un soprannome (Rossi per le persone rosse di capelli, per esempio),oppure dalla zona di provenienza (come Leonardo: dal paese di Vinci, in To-scana), dal lavoro svolto (Tintori, Bovari ...) o dalla patronimia (cioè il nomedel padre: per esempio Iohannes filius Arnaldi diventerà Giovanni Arnaldi).L'uso del cognome fu reso obbligatorio in Italia nel 1564.
L’USO DEL COGNOME
5
10
15
20
25
PARTE 1I cognomi sono nati per la necessità di distinguere le persone tra loro e dicensire la popolazione. E ovviamente i cognomi italiani non fanno eccezione.--------------------------- 1 ---------------------------Un primo registro di nomi esisteva già in età romana: i cittadini venivano se-gnati con un praenomen (cioè il nome personale, per esempio «Caio»), e conl’indicazione della gens (cioè della famiglia di provenienza, «Giulia» per esemp-io). Quando questi due nomi non furono più sufficienti a distinguere le per-sone, perché gli omonimi (ossia le persone con lo stesso praenomen e lastessa gens) erano diventati troppi, si aggiunse un cognomen, cioè un so-prannome.Per esempio «Cesare», che significa «colui che ha gli occhi chiari».--------------------------- 2 ---------------------------Ma perché, allora, i cognomi romani non sono giunti fino a noi? Semplice:perché dopo la caduta dell'impero i registri ufficiali creati dai governi degliimperatori romani andarono distrutti o perduti. E per molti anni, in seguitoall'imbarbarimento e al cambiamento della società, non si sentì più il bisognoné di cognomi né, ovviamente, dei registri.Successivamente, in Europa, precisamente tra il X e l’XI secolo, gli abitantiaumentarono di numero e, per distinguere le persone e per facilitare e re-ndere sicuri gli atti pubblici, per esempio le compravendite, diventò semprepiù comune l’uso di un cognome.Tale cognome poteva, ad esempio, derivare da una certa caratteristica fisicao da un soprannome (Rossi per le persone rosse di capelli, per esempio),oppure dalla zona di provenienza (come Leonardo: dal paese di Vinci, in To-scana), dal lavoro svolto (Tintori, Bovari ...) o dalla patronimia (cioè il nomedel padre: per esempio Iohannes filius Arnaldi diventerà Giovanni Arnaldi).L'uso del cognome fu reso obbligatorio in Italia nel 1564.
2
30
35
40
45
PARTE 2--------------------------- 3 ---------------------------Tutti i cognomi, quindi, hanno un significato, visto che traggono origine danomi propri (la maggior parte al Nord) o da soprannomi (soprattutto al Sud),o da professioni o luoghi (in assoluto le categorie più diffuse).Almeno il 75 per cento dei cognomi esistenti sono ancora comprensibili nelloro significato originario. Gli altri hanno probabilmente subìto qualche va-riazione fonetica o grafica che ne ha stravolto il senso, oppure derivano dainfluenze straniere.Ma c'è di più: dallo studio linguistico del cognome è possibile capire il luogod’origine della famiglia che lo porta.Uno stesso mestiere, per esempio quello di fabbro, ha prodotto cognomi di-versi da regione a regione. Così, in Lombardia, Piemonte ed Emilia «fabbro»è diventato Ferrari, Ferrario, Ferreri. Mentre in Toscana e in Veneto è diven-tato Fabbri e Favero e in Campania e nel Lazio si è trasformato in Forgione.--------------------------- 4 ---------------------------Molti cognomi «vegetali» per esempio (Cipolla, Finocchio, Meloni) hanno ori-gine celtica o germanica, perché presso i popoli nordici i riti legati alla naturae alle piante erano numerosi. Quindi sappi che, se ti chiami Zucca o Zucconi,non è perché il tuo trisavolo aveva la testa dura.Infine, un'altra categoria di cognomi molto diffusa deriva dal fatto che in Italiaabbondavano gli orfanotrofi: Esposito, Trovato, Innocenti, ad esempio, sonocognomi che venivano dati ai bambini di origine ignota, ossia ai «trovatelli».Di cognomi strani, poi, noi italiani abbondiamo anche grazie a improbabiliaccoppiate con nomi propri assurdi o inadatti... ma questa è un'altra storia.
Riad. da www.focusjunior.it
TANTI COGNOMI DIVERSI
30
35
40
45
PARTE 2--------------------------- 3 ---------------------------Tutti i cognomi, quindi, hanno un significato, visto che traggono origine danomi propri (la maggior parte al Nord) o da soprannomi (soprattutto al Sud),o da professioni o luoghi (in assoluto le categorie più diffuse).Almeno il 75 per cento dei cognomi esistenti sono ancora comprensibili nelloro significato originario. Gli altri hanno probabilmente subìto qualche va-riazione fonetica o grafica che ne ha stravolto il senso, oppure derivano dainfluenze straniere.Ma c'è di più: dallo studio linguistico del cognome è possibile capire il luogod’origine della famiglia che lo porta.Uno stesso mestiere, per esempio quello di fabbro, ha prodotto cognomi di-versi da regione a regione. Così, in Lombardia, Piemonte ed Emilia «fabbro»è diventato Ferrari, Ferrario, Ferreri. Mentre in Toscana e in Veneto è diven-tato Fabbri e Favero e in Campania e nel Lazio si è trasformato in Forgione.--------------------------- 4 ---------------------------Molti cognomi «vegetali» per esempio (Cipolla, Finocchio, Meloni) hanno ori-gine celtica o germanica, perché presso i popoli nordici i riti legati alla naturae alle piante erano numerosi. Quindi sappi che, se ti chiami Zucca o Zucconi,non è perché il tuo trisavolo aveva la testa dura.Infine, un'altra categoria di cognomi molto diffusa deriva dal fatto che in Italiaabbondavano gli orfanotrofi: Esposito, Trovato, Innocenti, ad esempio, sonocognomi che venivano dati ai bambini di origine ignota, ossia ai «trovatelli».Di cognomi strani, poi, noi italiani abbondiamo anche grazie a improbabiliaccoppiate con nomi propri assurdi o inadatti... ma questa è un'altra storia.
Riad. da www.focusjunior.it
B10 Riordina le parti con i numeri da 1 a 6 per ricostruire il contenuto del testo.
1.
Cognomi strani e curiosi.
2.
I cognomi non sono più necessari.
3.
I motivi della nascita dell’uso del cognome.
4.
Vari modi di formare un cognome.
5.
Al tempo dei Romani.
6.
Tanti cognomi, una stessa origine.
1
5
10
15
20
25
PARTE 1I cognomi sono nati per la necessità di distinguere le persone tra loro e dicensire la popolazione. E ovviamente i cognomi italiani non fanno eccezione.--------------------------- 1 ---------------------------Un primo registro di nomi esisteva già in età romana: i cittadini venivano se-gnati con un praenomen (cioè il nome personale, per esempio «Caio»), e conl’indicazione della gens (cioè della famiglia di provenienza, «Giulia» per esemp-io). Quando questi due nomi non furono più sufficienti a distinguere le per-sone, perché gli omonimi (ossia le persone con lo stesso praenomen e lastessa gens) erano diventati troppi, si aggiunse un cognomen, cioè un so-prannome.Per esempio «Cesare», che significa «colui che ha gli occhi chiari».--------------------------- 2 ---------------------------Ma perché, allora, i cognomi romani non sono giunti fino a noi? Semplice:perché dopo la caduta dell'impero i registri ufficiali creati dai governi degliimperatori romani andarono distrutti o perduti. E per molti anni, in seguitoall'imbarbarimento e al cambiamento della società, non si sentì più il bisognoné di cognomi né, ovviamente, dei registri.Successivamente, in Europa, precisamente tra il X e l’XI secolo, gli abitantiaumentarono di numero e, per distinguere le persone e per facilitare e re-ndere sicuri gli atti pubblici, per esempio le compravendite, diventò semprepiù comune l’uso di un cognome.Tale cognome poteva, ad esempio, derivare da una certa caratteristica fisicao da un soprannome (Rossi per le persone rosse di capelli, per esempio),oppure dalla zona di provenienza (come Leonardo: dal paese di Vinci, in To-scana), dal lavoro svolto (Tintori, Bovari ...) o dalla patronimia (cioè il nomedel padre: per esempio Iohannes filius Arnaldi diventerà Giovanni Arnaldi).L'uso del cognome fu reso obbligatorio in Italia nel 1564.
L’USO DEL COGNOME
5
10
15
20
25
PARTE 1I cognomi sono nati per la necessità di distinguere le persone tra loro e dicensire la popolazione. E ovviamente i cognomi italiani non fanno eccezione.--------------------------- 1 ---------------------------Un primo registro di nomi esisteva già in età romana: i cittadini venivano se-gnati con un praenomen (cioè il nome personale, per esempio «Caio»), e conl’indicazione della gens (cioè della famiglia di provenienza, «Giulia» per esemp-io). Quando questi due nomi non furono più sufficienti a distinguere le per-sone, perché gli omonimi (ossia le persone con lo stesso praenomen e lastessa gens) erano diventati troppi, si aggiunse un cognomen, cioè un so-prannome.Per esempio «Cesare», che significa «colui che ha gli occhi chiari».--------------------------- 2 ---------------------------Ma perché, allora, i cognomi romani non sono giunti fino a noi? Semplice:perché dopo la caduta dell'impero i registri ufficiali creati dai governi degliimperatori romani andarono distrutti o perduti. E per molti anni, in seguitoall'imbarbarimento e al cambiamento della società, non si sentì più il bisognoné di cognomi né, ovviamente, dei registri.Successivamente, in Europa, precisamente tra il X e l’XI secolo, gli abitantiaumentarono di numero e, per distinguere le persone e per facilitare e re-ndere sicuri gli atti pubblici, per esempio le compravendite, diventò semprepiù comune l’uso di un cognome.Tale cognome poteva, ad esempio, derivare da una certa caratteristica fisicao da un soprannome (Rossi per le persone rosse di capelli, per esempio),oppure dalla zona di provenienza (come Leonardo: dal paese di Vinci, in To-scana), dal lavoro svolto (Tintori, Bovari ...) o dalla patronimia (cioè il nomedel padre: per esempio Iohannes filius Arnaldi diventerà Giovanni Arnaldi).L'uso del cognome fu reso obbligatorio in Italia nel 1564.
2
30
35
40
45
PARTE 2--------------------------- 3 ---------------------------Tutti i cognomi, quindi, hanno un significato, visto che traggono origine danomi propri (la maggior parte al Nord) o da soprannomi (soprattutto al Sud),o da professioni o luoghi (in assoluto le categorie più diffuse).Almeno il 75 per cento dei cognomi esistenti sono ancora comprensibili nelloro significato originario. Gli altri hanno probabilmente subìto qualche va-riazione fonetica o grafica che ne ha stravolto il senso, oppure derivano dainfluenze straniere.Ma c'è di più: dallo studio linguistico del cognome è possibile capire il luogod’origine della famiglia che lo porta.Uno stesso mestiere, per esempio quello di fabbro, ha prodotto cognomi di-versi da regione a regione. Così, in Lombardia, Piemonte ed Emilia «fabbro»è diventato Ferrari, Ferrario, Ferreri. Mentre in Toscana e in Veneto è diven-tato Fabbri e Favero e in Campania e nel Lazio si è trasformato in Forgione.--------------------------- 4 ---------------------------Molti cognomi «vegetali» per esempio (Cipolla, Finocchio, Meloni) hanno ori-gine celtica o germanica, perché presso i popoli nordici i riti legati alla naturae alle piante erano numerosi. Quindi sappi che, se ti chiami Zucca o Zucconi,non è perché il tuo trisavolo aveva la testa dura.Infine, un'altra categoria di cognomi molto diffusa deriva dal fatto che in Italiaabbondavano gli orfanotrofi: Esposito, Trovato, Innocenti, ad esempio, sonocognomi che venivano dati ai bambini di origine ignota, ossia ai «trovatelli».Di cognomi strani, poi, noi italiani abbondiamo anche grazie a improbabiliaccoppiate con nomi propri assurdi o inadatti... ma questa è un'altra storia.
Riad. da www.focusjunior.it
TANTI COGNOMI DIVERSI
30
35
40
45
PARTE 2--------------------------- 3 ---------------------------Tutti i cognomi, quindi, hanno un significato, visto che traggono origine danomi propri (la maggior parte al Nord) o da soprannomi (soprattutto al Sud),o da professioni o luoghi (in assoluto le categorie più diffuse).Almeno il 75 per cento dei cognomi esistenti sono ancora comprensibili nelloro significato originario. Gli altri hanno probabilmente subìto qualche va-riazione fonetica o grafica che ne ha stravolto il senso, oppure derivano dainfluenze straniere.Ma c'è di più: dallo studio linguistico del cognome è possibile capire il luogod’origine della famiglia che lo porta.Uno stesso mestiere, per esempio quello di fabbro, ha prodotto cognomi di-versi da regione a regione. Così, in Lombardia, Piemonte ed Emilia «fabbro»è diventato Ferrari, Ferrario, Ferreri. Mentre in Toscana e in Veneto è diven-tato Fabbri e Favero e in Campania e nel Lazio si è trasformato in Forgione.--------------------------- 4 ---------------------------Molti cognomi «vegetali» per esempio (Cipolla, Finocchio, Meloni) hanno ori-gine celtica o germanica, perché presso i popoli nordici i riti legati alla naturae alle piante erano numerosi. Quindi sappi che, se ti chiami Zucca o Zucconi,non è perché il tuo trisavolo aveva la testa dura.Infine, un'altra categoria di cognomi molto diffusa deriva dal fatto che in Italiaabbondavano gli orfanotrofi: Esposito, Trovato, Innocenti, ad esempio, sonocognomi che venivano dati ai bambini di origine ignota, ossia ai «trovatelli».Di cognomi strani, poi, noi italiani abbondiamo anche grazie a improbabiliaccoppiate con nomi propri assurdi o inadatti... ma questa è un'altra storia.
Riad. da www.focusjunior.it
B11 Abbiamo a ciascun paragrafo il titolo corretto.
1.
Morte e rinascita dei cognomi.
2.
Vegetali e trovatelli.
3.
Una pratica antica.
4.
Significato, l’esempio del fabbro.
1
5
10
15
20
25
PARTE 1I cognomi sono nati per la necessità di distinguere le persone tra loro e dicensire la popolazione. E ovviamente i cognomi italiani non fanno eccezione.--------------------------- 1 ---------------------------Un primo registro di nomi esisteva già in età romana: i cittadini venivano se-gnati con un praenomen (cioè il nome personale, per esempio «Caio»), e conl’indicazione della gens (cioè della famiglia di provenienza, «Giulia» per esemp-io). Quando questi due nomi non furono più sufficienti a distinguere le per-sone, perché gli omonimi (ossia le persone con lo stesso praenomen e lastessa gens) erano diventati troppi, si aggiunse un cognomen, cioè un so-prannome.Per esempio «Cesare», che significa «colui che ha gli occhi chiari».--------------------------- 2 ---------------------------Ma perché, allora, i cognomi romani non sono giunti fino a noi? Semplice:perché dopo la caduta dell'impero i registri ufficiali creati dai governi degliimperatori romani andarono distrutti o perduti. E per molti anni, in seguitoall'imbarbarimento e al cambiamento della società, non si sentì più il bisognoné di cognomi né, ovviamente, dei registri.Successivamente, in Europa, precisamente tra il X e l’XI secolo, gli abitantiaumentarono di numero e, per distinguere le persone e per facilitare e re-ndere sicuri gli atti pubblici, per esempio le compravendite, diventò semprepiù comune l’uso di un cognome.Tale cognome poteva, ad esempio, derivare da una certa caratteristica fisicao da un soprannome (Rossi per le persone rosse di capelli, per esempio),oppure dalla zona di provenienza (come Leonardo: dal paese di Vinci, in To-scana), dal lavoro svolto (Tintori, Bovari ...) o dalla patronimia (cioè il nomedel padre: per esempio Iohannes filius Arnaldi diventerà Giovanni Arnaldi).L'uso del cognome fu reso obbligatorio in Italia nel 1564.
L’USO DEL COGNOME
5
10
15
20
25
PARTE 1I cognomi sono nati per la necessità di distinguere le persone tra loro e dicensire la popolazione. E ovviamente i cognomi italiani non fanno eccezione.--------------------------- 1 ---------------------------Un primo registro di nomi esisteva già in età romana: i cittadini venivano se-gnati con un praenomen (cioè il nome personale, per esempio «Caio»), e conl’indicazione della gens (cioè della famiglia di provenienza, «Giulia» per esemp-io). Quando questi due nomi non furono più sufficienti a distinguere le per-sone, perché gli omonimi (ossia le persone con lo stesso praenomen e lastessa gens) erano diventati troppi, si aggiunse un cognomen, cioè un so-prannome.Per esempio «Cesare», che significa «colui che ha gli occhi chiari».--------------------------- 2 ---------------------------Ma perché, allora, i cognomi romani non sono giunti fino a noi? Semplice:perché dopo la caduta dell'impero i registri ufficiali creati dai governi degliimperatori romani andarono distrutti o perduti. E per molti anni, in seguitoall'imbarbarimento e al cambiamento della società, non si sentì più il bisognoné di cognomi né, ovviamente, dei registri.Successivamente, in Europa, precisamente tra il X e l’XI secolo, gli abitantiaumentarono di numero e, per distinguere le persone e per facilitare e re-ndere sicuri gli atti pubblici, per esempio le compravendite, diventò semprepiù comune l’uso di un cognome.Tale cognome poteva, ad esempio, derivare da una certa caratteristica fisicao da un soprannome (Rossi per le persone rosse di capelli, per esempio),oppure dalla zona di provenienza (come Leonardo: dal paese di Vinci, in To-scana), dal lavoro svolto (Tintori, Bovari ...) o dalla patronimia (cioè il nomedel padre: per esempio Iohannes filius Arnaldi diventerà Giovanni Arnaldi).L'uso del cognome fu reso obbligatorio in Italia nel 1564.
2
30
35
40
45
PARTE 2--------------------------- 3 ---------------------------Tutti i cognomi, quindi, hanno un significato, visto che traggono origine danomi propri (la maggior parte al Nord) o da soprannomi (soprattutto al Sud),o da professioni o luoghi (in assoluto le categorie più diffuse).Almeno il 75 per cento dei cognomi esistenti sono ancora comprensibili nelloro significato originario. Gli altri hanno probabilmente subìto qualche va-riazione fonetica o grafica che ne ha stravolto il senso, oppure derivano dainfluenze straniere.Ma c'è di più: dallo studio linguistico del cognome è possibile capire il luogod’origine della famiglia che lo porta.Uno stesso mestiere, per esempio quello di fabbro, ha prodotto cognomi di-versi da regione a regione. Così, in Lombardia, Piemonte ed Emilia «fabbro»è diventato Ferrari, Ferrario, Ferreri. Mentre in Toscana e in Veneto è diven-tato Fabbri e Favero e in Campania e nel Lazio si è trasformato in Forgione.--------------------------- 4 ---------------------------Molti cognomi «vegetali» per esempio (Cipolla, Finocchio, Meloni) hanno ori-gine celtica o germanica, perché presso i popoli nordici i riti legati alla naturae alle piante erano numerosi. Quindi sappi che, se ti chiami Zucca o Zucconi,non è perché il tuo trisavolo aveva la testa dura.Infine, un'altra categoria di cognomi molto diffusa deriva dal fatto che in Italiaabbondavano gli orfanotrofi: Esposito, Trovato, Innocenti, ad esempio, sonocognomi che venivano dati ai bambini di origine ignota, ossia ai «trovatelli».Di cognomi strani, poi, noi italiani abbondiamo anche grazie a improbabiliaccoppiate con nomi propri assurdi o inadatti... ma questa è un'altra storia.
Riad. da www.focusjunior.it
TANTI COGNOMI DIVERSI
30
35
40
45
PARTE 2--------------------------- 3 ---------------------------Tutti i cognomi, quindi, hanno un significato, visto che traggono origine danomi propri (la maggior parte al Nord) o da soprannomi (soprattutto al Sud),o da professioni o luoghi (in assoluto le categorie più diffuse).Almeno il 75 per cento dei cognomi esistenti sono ancora comprensibili nelloro significato originario. Gli altri hanno probabilmente subìto qualche va-riazione fonetica o grafica che ne ha stravolto il senso, oppure derivano dainfluenze straniere.Ma c'è di più: dallo studio linguistico del cognome è possibile capire il luogod’origine della famiglia che lo porta.Uno stesso mestiere, per esempio quello di fabbro, ha prodotto cognomi di-versi da regione a regione. Così, in Lombardia, Piemonte ed Emilia «fabbro»è diventato Ferrari, Ferrario, Ferreri. Mentre in Toscana e in Veneto è diven-tato Fabbri e Favero e in Campania e nel Lazio si è trasformato in Forgione.--------------------------- 4 ---------------------------Molti cognomi «vegetali» per esempio (Cipolla, Finocchio, Meloni) hanno ori-gine celtica o germanica, perché presso i popoli nordici i riti legati alla naturae alle piante erano numerosi. Quindi sappi che, se ti chiami Zucca o Zucconi,non è perché il tuo trisavolo aveva la testa dura.Infine, un'altra categoria di cognomi molto diffusa deriva dal fatto che in Italiaabbondavano gli orfanotrofi: Esposito, Trovato, Innocenti, ad esempio, sonocognomi che venivano dati ai bambini di origine ignota, ossia ai «trovatelli».Di cognomi strani, poi, noi italiani abbondiamo anche grazie a improbabiliaccoppiate con nomi propri assurdi o inadatti... ma questa è un'altra storia.
Riad. da www.focusjunior.it
B12 Completa con la probabile origine di ogni cognome.
1.
Damilano
2.
Forgione
3.
Meloni
4.
Esposto
C1 Completa le frasi con le preposizioni corrette scegliendole tra quelle date.
1.
festa del paese ho incontrato Luca dopo molto tempo.
2.
Il cantante è salito palco per iniziare il concerto.
3.
Gianni si è presentato al compleanno il suo migliore amico.
4.
Per il nostro viaggio siamo partiti Milano e arrivati a Londra.
5.
Sono combattuto una scelta e l’altra.
6.
La spiegazione maestra mi è sembrata poco chiara.
7.
La mamma mi ha chiesto aiuto preparare la cena.
8.
Ho gettato una monetina Fontana di Trevi, dicono porti fortuna.
C2 Leggi i seguenti gruppi di frasi e rispondi.
1. GRUPPO 1 In quali frasi «Alice» ha funzione di soggetto?
A. Camminava per strada, Alice, senza una destinazione.
B. Antonia ha rimproverato Alice.
C. Alice ha rimproverato Antonia.
D. Porterò Alice al compleanno di Sara.
2. GRUPPO 2 In quali frasi «un bambino» ha funzione di complemento oggetto?
A. Nel mio sogno all’improvviso è comparso un bambino.
B. Il piccolo Luca, un bambino, ha riconosciuto la signora Verdi.
C. Sul prato della chiesa giocava spensierato un bambino.
D. A scuola ha conosciuto un bambino mai incontrato prima.
C3 Segna le frasi in cui il complemento NON rispecchia l’indicazione tra parentesi.
A. Giulia si è arrabbiata con Alessio (complemento di causa).
B. Mi sono avventurata nel bosco con il gruppo scout (complemento di compagnia).
C. Sandro ha spedico un pacco al suo rientro (complemento di termine).
D. La mamma al supermercato ha incontrato la zia Lucia (complemento oggetto).
E. Durante la vacanza in Grecia (complemento di luogo) abbiamo visitato Atene.
F. Il libro conteneva nelle prime pagine una lunga descrizione (complemento di specificazione).
G. Ho visto un film ieri sera (complemento di tempo) nel cinema della mia città.
H. Giovanni mangia con i compagni (complemento di modo) e finisce sempre per primo.
C4 Metti in relazione le due parti di questa frase scegliendo i pronomi relativi.
QUESTA È LA PERSONA
QUESTA È LA PERSONA
1.
andrò in viaggio a ottobre.
2.
ho ottenuto le informazioni.
3.
ti ho parlato ieri.
4.
regalerò una sorpresa.