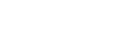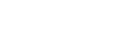Capitolo III
Giorgio Bárberi Squarotti, Renzo davanti al dottor Azzecca-garbugli
Personaggio secondario ed effimero nella trama generale del romanzo, l’avvocato Azzeccagarbugli è però protagonista in questo capitolo, come rappresentante e portavoce per eccellenza del tema della giustizia umana nel suo contrasto con i valori della giustizia assoluta: al servizio del potente, la legge si rivela sempre strumento di violenza contro i più deboli, come nel caso di Renzo che chiede giustizia nei confronti di don Rodrigo. Su questo aspetto centrale del romanzo ci guidano a riflettere le pagine del critico e poeta Giorgio Bárberi Squarotti, da decenni autore di alcuni fra i più importanti studi sull’opera di Manzoni.
Tutta la rappresentazione del dottor Azzecca-garbugli nei moti anche minimi del volto, nelle parole, dipende da questa fondamentale intenzione di illuminare ulteriormente l’ambito reale dell’azione della legge umana:
«E subito si fece serio, ma d’una serietà mista di compassione e di premura; strinse fortemente le labbra, facendone uscire un suono inarticolato che accennava un sentimento, espresso poi più chiaramente nelle sue prime parole. – Caso serio, figliuolo; caso contemplato. Avete fatto bene a venir da me. È un caso chiaro, contemplato in cento gride…»;
«Il dottore, vedendo il nuovo cliente più attento che atterrito, si meravigliava. «Che sia matricolato costui, – pensava tra sé. “Ah! ah” gli disse poi: “vi siete però fatto tagliare il ciuffo. Avete avuto prudenza: però, volendo mettervi nelle mie mani, non faceva bisogno. Il caso è serio; ma voi non sapete quel che mi basti l’animo di fare, in un’occasione.”»
Soprattutto nell’esposizione del piano di azione che l’avvocato fa a Renzo creduto colpevole per salvarlo dalla pena delle sue colpe, spicca chiaro il concetto stilizzante che è al centro di tutto l’episodio, che, cioè, «a saper bene maneggiar le grida, nessuno è reo, e nessuno è innocente». Il discorso del dottor Azzecca-garbugli riassume il panorama della giustizia umana, quale il Manzoni intende descrivere a fondamento iniziale e movente della sua rappresentazione del reale: le possibilità delle protezioni potenti, i larvati ricatti, le minacce contro le vittime, e la forza del denaro come soluzione per stornar ogni rischio dal colpevole, e istituire come uno schermo fra lui e la giustizia in modo da vincerne i rigori, rendere inutili le leggi. La sentenza del dottore, che accomuna nell’uguale possibilità di accusare o di assolvere colpevoli e innocenti, oppressi e oppressori, non rappresenta il compendio di una considerazione particolare, storica, limitata nel tempo in cui la vicenda narrata si svolge, dello stato della giustizia umana, ma rivela, proprio per il suo carattere gnomico generale, assoluto, la più vasta intenzione di sintetizzarvi la sostanza comune di ogni situazione affidata alla giustizia umana e ai suoi strumenti, siano essi trascritti nelle leggi, siano operanti entro le leggi, nell’attuazione e nel compimento di programmi che con l’equilibrio della giustizia assoluta nulla hanno a che fare, rispondendo a quel gioco tutto umano di vantaggi e astuzie, sconfitte e trionfi, abilità e inganni che già il Manzoni ha segnato di fortissima connotazione negativa inserendo un’intenzionalità impressiva d’interpretazione entro la rassegna iniziale delle grida contro i bravi e dando una prima stilizzazione alla rappresentazione del piano della storia nell’allusione all’opera politica del conte di Fuentes. «Non facciam niente», rispose il dottore, scotendo il capo, con un sorriso, tra malizioso e impaziente. “Se non avete fede in me, non facciam niente. Chi dice le bugie al dottore, vedete figliuolo, è uno sciocco che dirà la verità al giudice. All’avvocato bisogna raccontar le cose chiare: a noi tocca poi a imbrogliarle. Se volete ch’io v’aiuti, bisogna dirmi tutto dall’a fino alla zeta, col cuore in mano, come al confessore. Dovete nominarmi la persona da cui avete avuto il mandato: sarà naturalmente persona di riguardo; e, in questo caso, io anderò a lui, a fare un atto di dovere. Gli dirò che vengo ad implorar la sua protezione, per un povero giovine calunniato. E con lui prenderò i concerti opportuni, per finir l’affare lodevolmente. Capite bene che, salvando sé, salverà anche voi. Se poi la scappata fosse tutta vostra, via, non mi ritiro: ho cavato altri da peggio imbrogli… Purché non abbiate offeso persona di riguardo, intendiamoci, m’impegno a togliervi d’impiccio: con un po’ di spesa, intendiamoci. Dovete dirmi chi sia l’offeso, come si dice: e, secondo la condizione, la qualità e l’umore dell’amico, si vedrà se convenga più di tenerlo a segno con le protezioni, o trovar qualche modo d’attaccarlo noi in criminale, e mettergli una pulce nell’orecchio; perché, vedete, a saper bene maneggiare le gride, nessuno è reo e nessuno è innocente. In quanto al curato, se è persona di giudizio, se ne starà zitto; se fosse una testolina, c’è rimedio anche per quelle. D’ogni intrigo si può uscire; ma ci vuole un uomo: e il vostro caso è serio, vi dico, serio: la grida canta chiaro; e se la cosa si deve decider tra la giustizia e voi, così a quattr’occhi, state fresco. Io vi parlo da amico: le scappate bisogna pagarle: se volete passarvela liscia, danari e sincerità, fidarvi di chi vi vuol bene, ubbidire, far tutto quello che vi sarà suggerito.”»: è una stupenda mimesi ideologica dello stato di degradazione della giustizia umana quale il Manzoni intende rappresentare, attuato con una forzatura di involgarimento di tutti gli elementi di linguaggio della comunicazione e della persuasione che vengono accumulati accanto a più aperte dichiarazioni e scelte (come la sentenza che già abbiamo estratto dal discorso del dottore): a partire dall’uso costante di metafore consumate e banali al fine di rafforzare l’intenzione e di rialzare il tono fra il protettivo e il saputo, di chi conosce e manovra le leve della società («mettere una pulce nell’orecchio»; «se è una testolina; «state fresco»), ma per la volgarità degli strumenti, immediatamente demistificate; per continuare, più particolarmente, con l’insistenza su un linguaggio quasi religioso, ma ambiguo doppio, da confessore e confidente al tempo stesso, quale appare nel riferirsi del dottore all’autorità della religione per poter ottenere i suoi scopi nel colloquio, e nell’alludere proprio al confessore, in similitudine (ed è un’altra figura della demistificazione manzoniana, così come era quell’indicazione del «giudice» a cui si dovrà dire la verità che è un tipico calco di persuasiva da manuale del buon confessore); e il linguaggio della mozione degli affetti, quasi di paternità spirituale, di una sollecitudine affettuosa, concluso entro i continui vocativi (figliuolo, fidatevi, io vi parlo da amico, fidarvi di chi vi vuol bene, capite, vedete, ecc.), che viene rivelato nella sua sostanziale volgarità dall’accostamento finale dei due imperativi assoluti, «danari e sincerità», in cui è pure di colpo rivelata la decadenza del linguaggio del buon confessore che parlava di «verità»; e, ancora, il bilanciamento delle ipotesi – ma siamo, in questo caso, a un livello già più incisivo e ampio di stilizzazione delle cose – che offre le soluzioni di inganno o di offesa, di riscatto o di oppressione per qualsiasi circostanza e condizione possa presentarsi, secondo la centrale sentenza dell’utilizzazione contro tutti o a favore di tutti delle leggi umane: cioè, il grande quadro del negativo assoluto delle leggi umane una volta che si entri in esse, e si operi all’interno del loro meccanismo, ottenuto attraverso la rivelazione e l’obiettivazione totale dei più segreti e gelosi caratteri e modi di funzionamento di esse, che si avvale delle varie gradazioni, durante l’intero discorso, dell’attenuazione, del mascheramento, della dissimulazione stilistica. Ne sono esempi perfetti le varie indicazioni dei modi con cui il dottor Azzecca-garbugli pensa di poter far servire ai suoi fini le leggi e gli strumenti dell’amministrazione della giustizia, a seconda di quale ipotesi fra quelle possibili verrà a presentarsi: «non gli dirò… gli dirò che vengo ad implorar la sua protezione»; «prenderò i concerti opportuni»; «finir l’affare lodevolmente»; «peggio imbrogli»; «impiccio»; «tenerlo a segno con le protezioni»; «mettergli una pulce nell’orecchio»; «purché non abbiate offeso persona di riguardo»; «se fosse una testolina, c’è rimedio anche per quelle»: con il magnifico scambio di soggetti fra le due proposizioni del periodo ipotetico, che rendono esattamente lo scambio delle parti, dalla «ribellione» del curato (dell’offeso!) alle minacce, ai provvedimenti che si potranno prendere per opprimere la sua protesta e farla tacere. Si noti, infine, entro quel tanto di parlare in chiave e gergo, che è al fondo del discorso del dottore (e anche delle altre sue battute di dialogo: si ricordi l’accenno al ciuffo tipico dei bravi), l’acme della mimesi della volgarità che è dato dall’allusione furbesca: «la condizione, la qualità e l’umore dell’amico», con il tipico corrodimento della parola dell’affetto e della confidenza a significare l’avversario da opprimere, minacciare, ricattare, costringere a tacere e sopportare l’ingiustizia.
Tutto il discorso del dottore, infine, acquista un significato ulteriore dal fatto che la complicità dell’amministrazione della giustizia umana con l’oppressione e con l’inganno è involta entro l’equivoco grandioso dell’episodio, che si svolge entro la ferma credenza dell’avvocato che Renzo sia il colpevole da salvare a qualunque costo, non l’innocente tradito dalla «storia», che sta per essere confermato ancora nel suo stato di impossibilità di protestare, di farsi giustizia con i mezzi umani dell’organizzazione sociale, del contratto statale (solo un mezzo avrebbe, Renzo, per uscire dall’oppressione ed entrare, in qualche modo, dalla parte di chi tiene le leve del potere della giustizia, e forse esserne protetto, servirsene a suo vantaggio: accettare il sistema sociale e statale quale è, operarvi secondo le sue autentiche leggi; ed è il pensiero che gli balena per un attimo, dopo il fallimento dell’incontro col dottore, quando ha capito il sistema: «Ma, se il padre […] non ci trova un ripiego, lo troverò io, in un modo o nell’altro […] In ogni caso, saprò farmi ragione o farmela fare»: il gioco prospettico – e la sostanziale intenzione strutturalmente ideologica – è così completo e più impressivamente evidente risulta quella complicità delle leggi con l’oppressione sociale e dell’organizzazione dello stato e della giustizia umana che già era stata suggerita dall’iniziale esposizione delle grida contro i bravi. La conclusione del colloquio fra Renzo e il dottor Azzecca-garbugli non può essere interpretata soltanto come la reazione del dottore quale persona protetta proprio dal responsabile dell’oppressione e del delitto: nella struttura complessiva dell’episodio, che deve confermare, definendone con chiarezza i termini, lo stato della giustizia umana come dato dell’oppressione, significa altresì l’orrore e il timore per chi si presenta come «innocente» e «vittima» con cui il sistema sociale e legale non può avere nessun rapporto positivo, nessuna relazione che non sia di disgustata ira: «… il dottore, sempre gridando, lo spingeva con le mani verso l’uscio; e, quando ve l’ebbe cacciato, aprì, chiamò la serva, e le disse; “restituite subito a quest’uomo quello che ha portato: io non voglio niente, non voglio niente”. Quella donna non aveva mai, in tutto il tempo ch’era stata in quella casa, eseguito un ordine simile: ma era stato proferito con una tale risoluzione, che non esitò a ubbidire. Prese le quattro povere bestie, e le diede a Renzo, con un’occhiata di compassione sprezzante, che pareva volesse dire: bisogna che tu l’abbia fatta bella». Il comportamento della serva del dottore sigilla strutturalmente il significato conoscitivo dell’episodio: da un lato l’avvocato che non vuole in nessun modo aver contatti con un «segnato» come Renzo, dall’altro la serva che non concepisce altri visitatori che colpevoli, e non può che immaginare in Renzo un colpevole di delitti non risolvibili e non sanabili neppure con la complicità da lei intuita fra legge e oppressione. È un ulteriore decreto di espulsione dell’innocente da ogni consorzio sociale, ma, anche, dalla possibilità di immaginazione, di comprensione della realtà di chi, in qualche modo, sia pure indiretto, partecipa del mondo della giustizia umana.
Giorgio Barberi Squarotti, Teoria e prove dello stile del Manzoni, Silva Milano, 1965; pp. 107-112