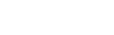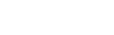Capitolo XII
Enzo Noè Girardi, Manzoni e l’economia
Seguendo l’arrivo di Renzo a Milano, il Narratore espone nel capitolo la condizione di carestia e le scelte socio-economiche dei governanti specifiche del momento. Il capitolo offre dunque a Manzoni l’occasione per esporre le proprie convinzioni nel campo dell’economia, aspetto fondamentale del suo realismo e della sua ideologia storica, allineata sulle più moderne posizioni del liberismo cattolico. Affrontiamo e approfondiamo il tema dell’economia nei Promessi Sposi seguendo la riflessione di Enzo Noè Girardi, critico di fama internazionale, particolarmente attento al rapporto tra fede e letteratura.
Questa nota trae motivo da uno di quei giudizi che da qualche tempo vengono avanzati, talora con eccessiva disinvoltura, sul carattere più o meno socialmente «progressista» o «reazionario» del Manzoni e dell’opera sua; giudizi ispirati a interessi ideologici magari rispettabilissimi, ma che nulla hanno a che fare con lo scrupolo di contribuire ad una migliore conoscenza del grande Scrittore.
Si tratta di un commento anonimo, comparso nel primo fascicolo del 1950 della rivista Cultura e realtà, a quella prima parte del dodicesimo capitolo dei Promessi Sposi, in cui il Manzoni analizza le cause del tumulto di Milano.
Il commentatore fissa la sua attenzione sull’ironia che colpisce sia le semplicistiche idee del popolo sui motivi del rincaro del pane e sul modo di porvi rimedio, sia l’intervento di Antonio Ferrer che obbligava i fornai a vendere sottocosto; e crede di poterne dedurre che il Manzoni, seguace della dottrina liberistica, negava «l’efficacia di qualsiasi tipo di intervento sul mercato». Non solo: ma dalla supposta radicale incomprensione del Manzoni per ogni provvedimento tendente a influire sul meccanismo delle leggi economiche, il commentatore trae motivo per concludere che, secondo il Manzoni, «Iddio entra direttamente nella storia come immediato e solo responsabile», mentre l’uomo deve «limitarsi ad intendere religiosamente gli ammaestramenti dolorosi ma salutari del processo storico» senza tentare di modificarlo; talché in definitiva, anche in questa pagina del romanzo si rivelerebbe quel fondo di rassegnazione, di passività, di fatalismo, che sarebbe proprio della concezione manzoniana della vita.
A quest’ultimo proposito, mi pare evidente che la premessa, cioè il radicale liberismo del Manzoni, quand’anche fosse dimostrata, costituirebbe pur sempre un argomento troppo debole per sostenere una conclusione di carattere così generale e profondo. E del resto, chi consideri il significato complessivo del romanzo, non può non rilevare che, se gli interventi della Provvidenza vi trovano maggior rilievo e successo degli interventi umani, questo è un dato ovvio, implicito nella generale concezione religiosa, cattolica, della vita, a cui il Manzoni intimamente aderisce, in nessun modo riducibile ad una posizione fatalistica propria del pensiero manzoniano in genere o di quello che si esprime in particolare nel romanzo. Se si vuol dire che cattolicesimo implica rassegnazione, passività, fatalismo (non è accusa nuova, per chi ricordi un Machiavelli o un Carducci), lo si dica pure; ma, in tal caso, non si vede l’utilità di citare i Promessi Sposi quando il testo più attendibile per discorsi di tal genere è indubbiamente il Vangelo. Che se invece si intende proprio definire un carattere dei Promessi Sposi, allora è certo che, prima di concludere con una definizione di passività e di fatalismo, bisognerebbe rileggere attentamente molte altre pagine del romanzo che suonano, senza possibilità di equivoci, ora direttamente, ora indirettamente, a lode dell’attività umana volta a migliorare le condizioni di coloro che soffrono, sia per causa della natura, sia per causa di altri uomini; e sia dell’attività che si esplica per le vie della ragione, della scienza, della cultura (si pensi alle pagine sulla figura di Ludovico Settala e del Cardinal Federigo), sia di quella che è mossa dalla carità (si pensi allo stesso Cardinal Federigo, al P. Cristoforo ed ai Cappuccini del Lazzaretto).
A parte tutto questo, mi preme tuttavia far notare che neppure l’inizio del capitolo dodicesimo può giustificare un’interpretazione come quella data. Chi lo legga con mente sgombra da preconcetti, s’accorge che la critica e l’ironia, qui, non colpiscono la pretesa del Ferrer di intervenire, ma il carattere demagogico del suo intervento, il semplicismo, l’inadeguatezza di esso, la sua fondamentale iniquità. Questa pagina, come tante altre sulla dominazione spagnola, sulla legislazione, sulla procedura giudiziaria, sulla condotta della guerra, sull’incuria dell’autorità all’inizio della pestilenza, suona, semmai, deprecazione di una situazione storica che insipienza di governanti e ignoranza di popolo contribuivano ad aggravare, e tanto più quanto si faceva sentire il loro intervento o la loro influenza nelle deliberazioni. Ne vogliamo una riprova? Mettiamoci allora sott’occhio il corrispondente capitolo V del tomo III di Fermo e Lucia, che il critico non ha pensato di prendere in considerazione. Se nei Promessi Sposi il Manzoni non s’è preoccupato di suggerire quali rimedi l’autorità avrebbe dovuto prendere, più assennati di quello del Ferrer, qui invece ne fa oggetto di una trattazione notevolmente circostanziata:
«Quando – egli scrive – un tal male (la sproporzione tra la domanda e l’offerta della derrata) esiste, i migliori mezzi per alleggerirlo (giacché toglierlo non è in potere dell’uomo) sono tutte quelle cose che possono diffonderlo più equabilmente, farne sopportare al maggior numero, a tutti i viventi, se fosse possibile, una piccola porzione, affinché nessuno ne abbia una porzione superiore alle forze dell’uomo, fare che quel male sia un incomodo per tutti, piuttosto che l’angoscia mortale per molti, e la morte per alcuni. Quindi il primo, il più certo e il più semplice mezzo di alleggiamento comune è l’astinenza volontaria dei doviziosi, che si privino di una parte di nutrimento per lasciarne di più alla massa del consumo universale. Poi tutto quello che può aumentare nelle mani degli indigenti i mezzi di acquistarsi il vitto, in proporzione dell’aumento delle difficoltà, cioè del rincaramento. Aumento quindi delle mercedi, e nuovi guadagni offerti per mezzo di nuovi lavori ai molti a cui cessano in quelle circostanze i lavori e i guadagni usati.
«Questo mezzo però sarebbe uno scarso rimedio, sarebbe anzi un accrescimento del male, se non fosse accompagnato dalla cura attenta, assidua, di somministrare il vitto anche a quei molti che per debolezza, o per infermità non lo possono ottenere col lavoro: si avrebbero allora dei lavoratori ben nutriti, e degli impotenti morti di fame: e la beneficienza sarebbe crudele per molti. A questi ultimi non si può provvedere altrimenti che con l’elemosina tanto sapientemente comandata dalla religione: quella elemosina di cui molti scrittori hanno enumerati, e censurati amaramente gli abusi. Né a torto; poiché è utile scoprire e censurare gli abusi dovunque s’intrudano: è però cosa triste e dannosa che in un soggetto di tanta importanza non si sieno quasi considerati che gli abusi; e sarebbe da desiderare che alcuno pigliasse la bella e forse nuova impresa di ragionare del buon uso della elemosina, di mostrare com’ella sia uno dei mezzi più potenti, più semplici, e certo più irreprensibili a tutti quei fini che si propone una saggia e ragionata economia pubblica».
Ho trascritto l’intera pagina perché essa mi pare un documento notevole dell’interesse del Manzoni per questi problemi e, particolarmente, dell’atteggiamento tutt’altro che passivo che egli esprime anche di fronte al doloroso fenomeno della carestia.
Non che sia lecito mettere in dubbio le sue convinzioni liberistiche, ma è evidente che tali convinzioni non impediscono al Manzoni di ammettere la necessità di provvedimenti, sia di natura economico-sociale, sia di natura caritativa (si noti la netta distinzione che egli fa tra beneficienza ed elemosina), provvedimenti che impegnano sia l’autorità politica, sia il senso morale dei cittadini più abbienti, al fine di attenuare il più possibile lo squilibrio tra il prezzo del vitto ed il potere d’acquisto. In sostanza il Manzoni dice: si lasci al pane il suo prezzo, anche se elevato, perché il prezzo elevato, come osserva nei Promessi Sposi, ha il potere di attirare il grano dai paesi che ne fossero meglio provvisti; si aumenti invece il potere d’acquisto nelle mani della moltitudine… Non è forse anche questo un tipo di intervento sul mercato? poniamo pure indiretto, meno semplice, ma anche meno semplicistico dell’altro, discutibile quanto si voglia, ma in fondo tutt’altro che sconosciuto a noi, dopo più di cento anni di storia economica, quanti ne sono passati dal tempo del Manzoni?
A maggior ragione appare assolutamente insostenibile, letta questa pagina, ogni giudizio di aprioristica rassegnazione. Se rimanesse qualche dubbio in proposito, il passo che segue immediatamente a quello riportato varrebbe a cancellarlo del tutto: «Questi che abbiamo accennati, sono certamente i principali e più sicuri rimedi alla penuria delle sussistenze; e quando si fossero posti in opera il meglio da farsi sarebbe sopportare quella parte inevitabile di patimento con tranquillità, e con rassegnazione, giacché tutte le ire, tutte le declamazioni, tutti i falsi ragionamenti non possono far nascere una spiga di frumento, né accelerare di cinque minuti il nuovo raccolto, che deve mettere a disposizione degli uomini una nuova massa di sussistenza».
Qui si tocca il centro della posizione cattolica del Manzoni e insieme l’esatta posizione reciproca dell’umano e del divino nell’economia del romanzo, posizione che appare più scoperta ed analiticamente esposta in Fermo e Lucia, velata invece e quasi sempre trasposta nella rappresentazione poetica nei Promessi Sposi.
È infatti semplicemente e solo per una esigenza d’arte che il Manzoni ha soppresso, nelle variazioni successive, questa esposizione dei mezzi per rendere tollerabile la carestia; non perché, come potrebbe obbiettare qualcuno, egli abbia in seguito accentuato il suo liberismo o sia diminuita in lui la fiducia nella capacità dell’uomo a curare i propri mali. C’è qui una ragione di economia, sì, ma di economia artistica: quella digressione dottrinaria avrebbe appesantito inutilmente la rapida, stringata, vivace analisi delle origini del tumulto; inutilmente, dico, perché, come ho accennato in principio, il significato della critica manzoniana all’operato del Ferrer resta ugualmente chiaro nel senso che s’è detto.
E del resto, non mancano altri documenti posteriori dai quali si può trarre conferma che il liberismo nel Manzoni si accompagna pur sempre all’esigenza di provvedimenti o intesi a moderare un’assoluta libertà, come ad esempio nella questione del lusso o del mal uso del diritto di proprietà, o intesi a promuovere il benessere, come quando lo scrittore auspica una politica agraria lungimirante e non contenta al lucro immediato.
Sta di fatto che anche l’adesione al liberismo, come ad ogni altro punto di vista o movimento culturale, era in lui, ad un tempo, giustificata e regolata dalla primaria, fondamentale, esigenza di pensare e di agire cristianamente. Si veda per questo lo scritto Dell’economia politica sui rapporti con la Religione cattolica, ov’egli esprime tra l’altro il proposito di fare un saggio su alcuni punti di questa materia e si ricordi anche quel passo della lettera al D’Azeglio sul Romanticismo, ove esprime l’opinione che la scienza economica si sia evoluta, rispetto ai princìpi ch’essa predicava nel secolo diciottesimo, in un senso più consono allo spirito del Vangelo: «… per un progresso naturale delle scienze economiche, per un più attento e esteso esame dei fatti, per un ragionato cambiamento dei princìpi, altri scrittori, in questo secolo hanno scoperto la falsità e il fanatismo di quei canoni; e sul celibato, sul lusso, sulla prosperità fondata nella rovina altrui, sopra altri punti ugualmente importanti, hanno stabilito dottrine conformi ai precetti, e allo spirito, del Vangelo».
Si può naturalmente dissentire su questa concezione ottimistica del processo della storia economica in senso cristiano; ed è ovvio che noi oggi conoscendo i mali che ne sono derivati sottolineiamo gli aspetti negativi, piuttosto che quelli postivi, rispetto al Vangelo, della dottrina liberistica; ma a parte il fatto che effettivamente questa dottrina appare meno materialistica e meno grettamente utilitaristica di quella opposta, ispirata al protezionismo, è evidente che lo Scrittore, nell’interpretarla e nel prospettarsene l’applicazione, la illumina della propria sensibilità sociale profondamente cristiana. Chi voglia approfondire questo tema, valendosi più ampiamente e minutamente di quanto io non abbia inteso fare, di tutti i documenti a disposizione, non potrà non porsi in questa prospettiva, non potrà non tener conto dell’ispirazione essenzialmente religiosa che è alla base di qualsiasi interesse culturale del Manzoni. Non si tratta di discutere il pensiero economico del Manzoni in sé e per sé, bensì di coglierne il senso in relazione a quel programma di sintesi tra cristianesimo e pensiero moderno in cui rientra tutta l’opera dello Scrittore considerata nel suo profilo storico.
Enzo N. Girardi, da Manzoni «reazionario», Cappelli, Bologna 1966