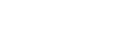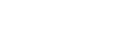Capitolo XVI
Giovanni Getto, L’osteria di Gorgonzola
Giovanni Getto (cfr. Lettura critica cap. VIII), nel commento che accompagna capitolo per capitolo la sua “storica” edizione dei Promessi Sposi (1964), legge la vivacissima scena che si svolge nell’osteria di Gorgonzola e vi individua lo strumento usato da Manzoni per completare il racconto dei tumulti milanesi e per fornirne un nuovo punto di vista, dopo quelli di Renzo, dell’autorità, della folla e dell’autore stesso. Il punto di vista del mercante è quello dei benpensanti, e su di esso Manzoni esercita la sua polemica ironia accentuata dalla presenza appartata e preoccupata di Renzo, in fuga verso l’Adda, come spettatore.
La scena dell’osteria di Gorgonzola è tra le più vive dei Promessi Sposi. Le prime battute definiscono subito un coro di persone in attesa curiosa, animate da propositi baldanzosi («Mi pento di non esser andato a Milano stamattina»; «Se vai domani, vengo anch’io»), prontamente mutati non appena uditi i ragguagli e gli apprezzamenti severi del mercante («E per questo […] io che so come vanno queste faccende, e che ne’ tumulti i galantuomini non ci stanno bene, non mi son lasciato vincere dalla curiosità, e son rimasto a casa mia»; «E io, mi son mosso?»; «Io? […] se per caso mi fossi trovato in Milano, avrei lasciato imperfetto qualunque affare, e sarei tornato subito a casa mia»). Si vede il gruppo correre all’uscio, andare incontro al mercante, stringersi intorno a lui, disporsi in ascolto. E si vede il mercante con le sue esigenze di cliente abitudinario («… il mio letto solito è in libertà? Bene: un bicchier di vino,e il mio solito boccone, subito…») e con i suoi gesti caratteristici («Empì il bicchiere, lo prese con una mano, poi con le prime due dita dell’altra sollevò i baffi, poi si lisciò la barba, bevette…»; «E qui, alzata in aria, e stesa la mano sinistra, si mise la punta del pollice alla punta del naso»). Il racconto, interrotto da brevi battute per lo più interrogative degli ascoltatori, apre uno scorcio sulla seconda giornata degli eventi milanesi (a vantaggio del lettore, per la sua compiuta informazione storica) e nello stesso tempo propone una interpretazione del tumulto fatta da un diverso punto di vista, dopo quello, via via proposto nei precedenti capitoli, dell’autore, della folla, dell’autorità e di Renzo (a vantaggio, questa volta, del personaggio principale, del tesoro di esperienze che egli va accumulando). La posizione del mercante si manifesta fin dalle prime parole, e tutto il discorso rivela chiaramente con quale delle due parti in lotta egli sia schierato. Gli insorti sono «que’ birboni che ieri avevano fatto quel chiasso orrendo»; e il loro adunarsi è paragonato a quel che capita quando si spazza la casa («il mucchio del sudiciume ingrossa quanto più va avanti»). Il vicario invece è il «signor vicario di provvisione». E il trattamento usato contro di lui è vivamente deplorato: «a un signore di quella sorte!»; e considerato ingiurioso: «Tutte invenzioni: un signor dabbene, puntuale»; invocando a sostegno di tale favorevole e circostanziato giudizio il concreto assaporato rapporto commerciale che a lui lo lega: «e io lo posso dire, che son tutto di casa, e lo servo di panno per le livree della servitù». Il punto di vista del mercante è quello del cosiddetto ben pensante, dell’amante dell’ordine, quell’ordine che è innanzitutto garanzia dei propri affari. In cima ai suoi pensieri c’è la sua bottega: «Cominciavan già a prender il vizio d’entrar nelle botteghe, e di servirsi, senza metter mano alla borsa […] E vi so dir io che, per un galantuomo che ha bottega aperta, era un pensier poco allegro». Per questo egli si trova naturalmente dalla parte della clientela signorile («Chi farebbe viver la povera gente, quando i signori fossero ammazzati?»). La sua ammirazione va tutta ai signori («c’era de’ cavalieri, e fior di cavalieri, a invigilare che tutto andasse bene…»). Agli insorti invece guarda con un orrore istintivo («… bisognava veder che canaglia, che facce […] E le cose che uscivan da quelle bocche! da turarsene gli orecchi…»). Essi sono per lui degli indemoniati («Ma vedete un poco se non era il demonio che li portava»). Perciò con soddisfazione profonda contempla quella «bella fila di micheletti, con gli archibugi spianati» pronti a ricevere i saccheggiatori «come si meritavano». E con uguale soddisfazione si sofferma a considerare il meritato castigo («gente che se l’è meritato») di quei «quattro tristi» destinati a essere «serviti con tutte le formalità, accompagnati da’ cappuccini, e da’ confratelli della buona morte». Così è lieto di poter constatare l’effetto benefico prodotto sulla folla (decisa a dar fuoco al forno sul Cordusio) da quel crocifisso, per «un’ispirazione dal cielo» attaccato «all’archetto d’una finestra», fra due candele accese poste sul davanzale: «La gente guarda in su. In un Milano, bisogna dirla, c’è ancora del timor di Dio; tutti tornarono in sé». E con l’ammirata approvazione di chi vede nella religione un’‘instrumentum regni’, una forza conservatrice, passa a descrivere quel colpo di scena dell’arrivo dei monsignori: «Indovinate ora chi arrivò all’improvviso. Tutti i monsignori del duomo, in processione, a croce alzata, in abito corale; e monsignor Mazenta, arciprete, cominciò a predicare da una parte, e monsignor Settala, penitenziere, da un’altra…»; per concludere finalmente, tutto gongolante, con quella visione in cui si riflette il suo ideale di ordine e di disciplina: «Milano, quand’io ne sono uscito, pareva un convento di frati». Alla relazione dei fatti il mercante fa seguire l’interpretazione di essi. Alle parole che riflettono semplicemente un punto di vista nel riferire quel che è realmente accaduto, tengono dietro le parole che trasmettono una realtà deformata o insussistente quale motivazione dell’accaduto. Il mercante viene dunque a dire dell’esistenza di una lega, di una cabala ordita «da quel cardinale là di Francia», dell’arresto avvenuto in un’osteria di uno dei capi, che il giorno prima «aveva fatto il diavolo; e poi, non contento di questo, s’era messo a predicare, e a proporre […] che s’ammazzassero tutti i signori», il quale portava con sé «un fascio di lettere» contenenti «tutta la cabala» e compromettenti «molta gente». Così Renzo, «il quale non perdeva un ette di quel discorso», si sente classificare fra la «gente che non ha né casa né tetto», che trova da rintanarsi dappertutto, ma solo finché il diavolo può e vuole aiutarla. E qui la parola raccoglie e riflette il mobile giuoco delle intenzioni dello scrittore: la sua ironia a carico del mercante e quella tanto diversa a carico di Renzo, la sua condanna per il poco cristiano giudicare del mercante e la sua affettuosa partecipazione per Renzo, il personaggio che sta per esserci presentato (nel prossimo capitolo) in una luce quasi evangelica, sotto l’aspetto di «povero pellegrino», e nella profondità commovente della sua redenzione spirituale.
Giovanni Getto, Letture manzoniane, Sansoni, Firenze 1965; pp. 267-270