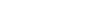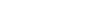I punti di imbarco e le tre vie per Gerusalemme
Viaggiare lungo la rete viaria che nel medioevo solcava tutto il continente europeo non era semplice.
Il pellegrino doveva scegliere il giusto tragitto. Il viaggio era esposto ai
cambiamenti climatici, alle
vicende politiche e alle
circostanze sociali.
Gerusalemme era una meta difficile, pericolosa, avventurosa. Per raggiungerla bisognava attraversare il mare, viaggiare in paesi sconosciuti, fra popoli ritenuti ostili a Cristo e ai suoi seguaci.
Per il tragitto esistevano diverse alternative.
Dopo aver raggiunto Roma tramite la via Francigena, si proseguiva per la via Appia sino a Benevento, dove la direttrice si divideva in tre direzioni:
- la via dell’Angelo che raggiungeva il Gargano, per poi seguire la costa fino ai porti pugliesi;
- la via Traiana che raggiungeva gli attracchi pugliesi passando per Matera e Taranto;
- una via intermedia che arrivava a Bari e Brindisi valicando l’Appennino Irpino.
Dai porti pugliesi si aveva nuovamente una doppia possibilità:
- si poteva attraccare a Corfù, di qui proseguire per Bisanzio,
- oppure continuare a navigare facendo scalo a Rodi o a Creta per arrivare alla sospirata Palestina giungendo a San Giovanni d’Acri.
Il pellegrino che non amava il mare poteva scegliere la
via di terra.
Anche questa presentava più alternative:
- la prima conduceva a Costantinopoli attraverso i Balcani lungo la cosiddetta “
via di Carlo Magno”, che l’Imperatore, pur non avendola mai percorsa, aveva fatto sistemare;
- un’altra strada da Ratisbona, attraverso l’Ungheria, giungeva a Bisanzio dove incontrava la
via Egnatia, poi attraverso il Bosforo passava in Anatolia, raggiungendo Nicea. Da qui si proseguiva verso Damasco e Gerusalemme.
Un secondo itinerario, meno frequentato, attraversava i territori slavi per raggiungere la via Egnatia presso Durazzo.
Questa era una vecchia strada romana che univa la costa dalmata a Bisanzio attraverso la Macedonia.
Nel XIII secolo, il pellegrinaggio via terra cominciò a ridursi nonostante la maggiore sicurezza del sistema viario.
Si affermò la via del mare, soprattutto lungo le rotte tirreniche. Il porto di Messina acquistò grande importanza. Ci si imbarcava anche a Napoli, Brindisi e Barletta.
A partire dalla fine del Trecento Venezia assunse il monopolio marittimo controllando tutto l’Adriatico. La flotta veneziana, attrezzata per il trasporto dei pellegrini in Palestina, diventò punto di riferimento per pellegrini toscani, lombardi e francesi.