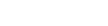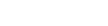Il ducato di Benevento e lo Stato pontificio
Il ruolo del
Papa nella gestione politica dei territori, cioè quello che si chiama
potere temporale (sulle cose terrene), si contrappone a quello spirituale di capo della Chiesa. Ma fra i due poteri c’è un legame particolare: il potere temporale derivò in origine dal bisogno di Roma (rimasta senza l’Imperatore, che si era trasferito a Bisanzio) di trovare una guida forte e autorevole.
Col venir meno di un potere forte in Italia, acquisì un ruolo determinante per molte comunità la capacità della Chiesa di creare strutture organizzate ( le abbazie, i monasteri) e quindi vita regolata da norme intorno a esse. Le abbazie erano luoghi di incontro, di lavoro, di scambio, di culto e di cultura. Tutto questo fu per lungo tempo l’unica forma di autorità condivisa, per molti territori. In questo contesto la Chiesa assunse un ruolo politico destinato a durare a lungo.
La progressiva dissoluzione del potere dell’Impero in Italia centrale rafforzò il ruolo del papato. Questo processo fu rafforzato dalla spinta delle
invasioni longobarde.
Nell’Italia centromeridionale i Longobardi si erano stabiliti in particolare a Benevento, sede di un ducato in origine autonomo, ma dalla fine del Seicento assoggettato al regno longobardo del nord.
Nel 728 il re Liutprando strappa ai Bizantini (Bisanzio era la nuova capitale dell’Impero Romano) il castello di Sutri. Papa Gregorio II riuscirà a farselo consegnare, segnando l’inizio della costituzione del cosiddetto
Patrimonium Sancti Petri, che diverrà nel tempo lo
Stato pontificio.
Quando anche i Longobardi minacciarono Roma, papa Stefano II chiese l’aiuto dei sovrani francesi. Pipino il Breve nel 756, e Carlo Magno nel 781, li sconfissero nuovamente, consegnando alla
Santa Sede, con la
Promissio Carisiaca, alcuni territori già appartenuti ai Bizantini e agli stessi Longobardi.
Il ducato di Benvento tuttavia non scomparve, divenne poi un principato e fra alterne fortune sopravvisse fino alla conquista normanna: Roberto d’Altavilla, nel 1053 conquistò la città e la consegnò al Papa e a un destino di località marginale dei possedimenti della Chiesa.