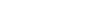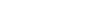La logistica del pluralismo in Gerusalemme
“
Quale gioia quando mi dissero: «andremo alla casa del Signore!». Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme! Gerusalemme è costruita come città unita e compatta…”. Così l’autore del
Salmo 122 descriveva la Città Santa d‘
Israele, come doveva averla vista arrivando al termine di uno dei pellegrinaggi che, secondo i precetti dell’ebraismo, erano obbligatori per ogni fedele.
La città di oggi, pur mantenendo intatta tutta la sua suggestione, è certamente molto diversa. Adesso Gerusalemme conta circa
750 mila abitanti. Il suo cuore è la città vecchia, racchiusa dalle mura fatte costruire da
Solimano il Magnifico tra il 1537 e il 1542. Al di fuori di questa cerchia muraria, si trova una città moderna e pulsante di vita, che non ricorda niente della Gerusalemme antica.
La Gerusalemme antica, oggetto di dispute e conflitti, è un vero concentrato di luoghi sacri per le tre religioni monoteiste:
- - il Muro occidentale, detto Muro del pianto (luogo di culto ebraico) dove durante lo Shabbath, il giorno della settimana dedicato dalla religione ebraica al riposo e alla preghiera, gli ebrei si recano a pregare;
- - l’Haram al Sharif, il recinto delle moschee (sacro ai musulmani), dove sorgono la Cupola della Roccia, che ricorda il sacrificio di Abramo, e la moschea che ricorda il miracoloso viaggio notturno di Muhammad nella città, che l’islam chiama semplicemente Al Quds, La Santa;
- - e infine il Santo Sepolcro dove i cristiani venerano i luoghi della morte e risurrezione di Gesù.
La struttura della città vecchia risente fortemente della presenza di diverse religioni: è divisa in
quattro quartieri, quello
ebraico, che si ferma al muro occidentale, quello
armeno, quello
cristiano e quello
musulmano, accanto all’
Haram al Sharif.
Quattro religioni in un’unica città che nel nome contiene un destino fino ad ora non realizzato: la radice
sh-l-m, la stessa della parola ebraica
shalom, che significa
pace e
giustizia.
Non mancano ovviamente le
complicazioni sociali: difficilmente un ebreo, che non sia un militare, andrà a passeggiare nella parte della città abitata dai
270mila palestinesi che sono abitanti di Gerusalemme, ma non cittadini israeliani. E i cristiani che ogni venerdì prendono parte alla
Via Crucis, che si conclude alla basilica del Santo Sepolcro, devono necessariamente attraversare il bazar nel quartiere arabo dove si svolgono le attività commerciali. Ed è particolare anche la convivenza tra cristiani, come dimostrano le tante questioni sorte a proposito della gestione dei luoghi santi, divisi tra
armeni,
cattolici,
ortodossi,
copti,
siri ed
etiopi, ancora oggi regolata da un trattato. Un’apposita commissione, formata da rappresentanti di tutte le Chiese cristiane – i cattolici sono rappresentati dai frati francescani della
Custodia di Terra Santa, vigila sull’osservanza di queste norme.
Dal 1192, per decreto di Saladino, la custodia della porta della basilica del Santo Sepolcro è affidata a due famiglie musulmane, a conferma di una prassi inaugurata nel 637 dal califfo Omar, che aveva conquistato Gerusalemme.