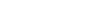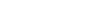La convivenza tra religioni
La prima versione della leggenda dei tre anelli, riportata da Giovanni Boccaccio nel
Decameron, risale probabilmente all’opera del medico, poeta e filosofo ebreo spagnolo
Yehudah ha-Levi.
Secondo la sua versione, il sultano Saladino aveva bisogno di un prestito dal ricco ebreo Melchisedech, ma non aveva modo di restituirlo.
Decise allora di metterlo in difficoltà interrogandolo su quale delle due fedi – l’islam o il Giudaismo – fosse la più vera. Comunque l’ebreo avesse risposto, secondo Saladino, sarebbe risultato colpevole e avrebbe quindi meritato l’estorsione di denaro come punizione.
Melchisedech rispose a Saladino raccontando di un padre che aveva tre figli e possedeva un anello con incastonata la pietra più preziosa al mondo. Ciascuno dei tre figli supplicava il padre affinché, morendo, gli lasciasse l’anello in eredità. Il padre allora commissionò a un abile orafo due anelli uguali, mettendo in ciascuno una pietra simile a quella dell’originale. Consegnò un anello a ciascuno dei tre figli, separatamente e in gran segreto, in modo tale che ognuno fosse convinto di aver ricevuto l’anello (credendo che fosse l’unico): solo il padre era al corrente di quale fosse l’originale. L’ebreo concluse il suo racconto dicendo che i tre anelli indicano le tre fedi: solo Dio conosce la migliore e ciascun credente, che è suo figlio, crede di essere nella verità. Il sultano a questo punto non trovò motivo di trattenere Melchisedech ed estorcergli il denaro.
Yehudah ha-Levi era uno degli ebrei che vivevano nella Spagna che - a partire dal 711 - aveva subito l’
invasione islamica.
Nei settecento anni a seguire, la stessa Spagna sarebbe stata teatro di una lunga guerra di riconquista da parte dei sovrani cristiani.
I confini tra la Spagna cristiana e l’
al-Andalus (il nome che l’islam dette ai territori conquistati da cui il termine
Andalusia) furono sempre molto labili. Ai cristiani, chiamati
Mozarabi, fu permesso di vivere e di professare la propria fede, anche se in condizioni precarie, così come successe alle comunità di musulmani, i cosiddetti
Moriscos, man mano che avanzava la riconquista del territorio.
Gli ebrei erano presenti sia nei territori cristiani dove, fino al
1492, riuscirono a vivere
con una certa tranquillità, sia nell’al-Andalus, dove si realizzò una delle
rinascite culturali più importanti di tutto il Medioevo.
Era stato un altro ebreo,
Hasdai ben Shaprut, medico di corte e amministratore del califfo di Cordova, ma soprattutto
linguista, a tradurre le
opere classiche dal greco e dal latino in arabo e a tessere
rapporti diplomatici tra regni cristiani e regni musulmani, fino a entrare in contatto con Bisanzio.
Naturalmente non sempre si trattava di convivenza pacifica: tra l’XI e il XIII secolo si scatenarono vere e proprie
persecuzioni di ebrei e di cristiani mozarabi, costretti a fuggire e a cercare protezione presso principi cristiani o, come fece lo studioso ebreo Moshe Maimonide, in zone più pacifiche dell’islam.
Ma fu proprio grazie a quest’opera di
mediazione che il mondo arabo e quello cristiano poterono entrare in contatto con il pensiero di Aristotele e sviluppare una riflessione ed una conoscenza
comune, che avrebbe avvicinato pensatori ebrei, arabi e cristiani, da Avicenna a Maimonide, ad Averroé a san Tommaso.