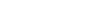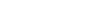Reims: il potere politico e la fede religiosa
Reims è stato per lungo tempo un luogo di incontro fra
potere politico e religione: prova ne è che nella sua Cattedrale sono stati incoronati quasi tutti i
re di Francia.
Il rapporto tra religione e potere è sempre stato estremamente articolato.
Nel
Medioevo religione e potere politico erano strettamente correlati e chi gestiva il potere cercava spesso una legittimazione religiosa. Gli stessi sovrani basavano la propria autorità sui riti solenni dell’incoronazione, come i re di Francia da
Carlo Magno a
Napoleone, che hanno voluto l’investitura dal sommo pontefice.
Per i regnanti erano essenziali anche
funerali e sepoltura presso le grandi cattedrali. I potenti si prodigavano vestendo
i panni poveri del Cristo, in occasione delle celebrazioni del giovedì santo, o compiendo
atti di umiltà nei confronti dei poveri, che contribuivano a innalzarne il prestigio e a legittimarne ancora di più la sovranità.
Sovrani e uomini di potere, oltre che calcolatori, erano profondamente
inseriti nella cultura e nelle tradizioni ed erano coscienti della responsabilità del proprio ruolo: nella legittimazione religiosa ricercavano un ulteriore elemento di
autorevolezza presso il popolo.
La Riforma protestante fu usata dai principi tedeschi anche per sottrarsi alla dipendenza politica dal Papa. Ampie porzioni di popolazione vennero sottratte alla fede cattolica (la religione del principe diveniva automaticamente quella delle popolazioni a lui soggette).
Al tempo di
Elisabetta I, regina d’Inghilterra e capo della Chiesa anglicana, la data dell’incoronazione divenne una
festa liturgica al pari delle feste di Cristo, dei santi e della Vergine Maria. Contemporaneamente la storia ha visto prima affermarsi, poi lentamente eclissarsi, il ruolo dello Stato della Chiesa, che nasce con la fine dell’Impero romano d’Occidente. Il primo pontefice a incarnare anche un ruolo politico fu
papa Leone Magno: nel V secolo, con l’Imperatore a Costantinopoli, le vecchie strutture della Roma imperiale non erano più in grado di dirigere la società; l’eredità degli imperatori venne raccolta dal pontefice della Chiesa, chiamato a ricostruire il tessuto della città dopo il sacco del 410 e le invasioni barbariche.
Proprio Leone Magno, che con i suoi interventi presso
Attila nel 452 ottenne il ritiro degli Unni e intervenendo con
Genserico nel 455 evitò un nuovo saccheggio, è il simbolo di questa nuova figura di capo della Chiesa e, allo stesso tempo, della comunità civile.
Già alla fine del VI secolo, il vescovo di Roma era considerato il più grande tra i proprietari terrieri in Italia, anche se i possedimenti, provenienti da lasciti e donazioni, facevano parte in realtà del cosiddetto
Patrimonium Petri (erano cioè della Chiesa, non del Papa).
Per parlare di vero e proprio Stato della Chiesa, bisognerà aspettare il
1213, quando l’imperatore Federico II, con la
Bolla d’Oro, riconobbe ufficialmente lo Stato della Chiesa, trasformando il Papa – allora
Innocenzo III – in principe spirituale. Lo
Stato Pontificio ebbe la sua massima estensione durante il pontificato di
Giulio II (1503-1513) e scomparve per alcuni anni in seguito alla Rivoluzione francese e alla politica napoleonica (ma anche Napoleone volle farsi incoronare Imperatore dal Papa).
Fu ricostituito in seguito al
Congresso di Vienna; i suoi confini vennero
ridotti in seguito al processo di unificazione italiana e infine
scomparve con la conquista di Roma da parte dell’esercito del nascente
Regno d’Italia, il
20 settembre 1870. La questione romana (relativa appunto alle conseguenze della breccia di Porta Pia) con lo stato italiano fu affrontata solo sessanta anni dopo, nel 1929, con i
Patti Lateranensi, che sono stati in parte modificati nel 1984.