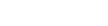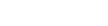Dante e Petrarca: i pellegrini a Roma
Dante (1265-1321) e
Petrarca (1304-1374) vissero nel periodo delle lotte fra i sostenitori politici del Papato e quelli dell’Imperatore, i Guelfi e i Ghibellini.
Entrambi i letterati furono strettamente legati alla fazione guelfa. Furono entrambi uomini di fede.
Sia Dante sia Petrarca ebbero modo di vedere in prima persona (nel 1300 Dante e nel 1337 Petrarca) i pellegrini a Roma.
Non sorprende quindi che quando nelle loro opere devono dare l’idea di qualcosa di altamente mistico, pieno d’amore e impressionante, ricorrano all’immagine della grande quantità di pellegrini visti o alla profonda suggestione spirituale vista e vissuta direttamente a Roma.
Le opere
Dante ricorda la vista dei pellegrini e la suggestione mistica del pellegrinaggio in due opere: la Divina Commedia e la Vita Nova.
Petrarca, invece, nel Canzoniere accosta il suo amore terreno ma sublimato per Laura all’amore mistico di un vecchio pellegrino per l’immagine del Cristo impressa nella veronica, simbolo del pellegrinaggio.
I testi e la critica
Dante
"... Nel fondo erano ignudi i peccatori;
dal mezzo in qua ci venien verso ‘l volto,
di là con noi, ma con passi maggiori,
come i Roman per l’esercito molto,
l’anno del giubileo, su per lo ponte...”
(Inferno, XVIII, 25-29)
Dante descrive i peccatori (colpevoli di frode) incanalati lungo due file che procedono l’una in senso opposto all’altra.
Sono talmente numerosi che gli ricordano la folla di pellegrini a Roma nell’anno del Giubileo (1300). Dante ricorda di aver visto i pellegrini divisi in due file lungo Ponte Milvio: una diretta a San Pietro e l’altra di ritorno al Gianicolo.
“... Qual è colui che forse di Croazia
viene a veder la veronica nostra,
che per l’antica fame non sen sazia,
ma dice nel pensier, fin che si mostra:
"Signor mio Gesù Cristo, Dio verace,
or fu sì fatta la sembianza vostra?";
tal era io mirando la vivace
carità di colui che ‘n questo mondo,
contemplando gustò di quella pace...”
(Paradiso, XXXI, 103-111)
San Bernardo si mostra a Dante. Dante paragona la tenerezza provata quando san Bernardo gli si mostra ardente di carità all’espressione estatica e piena di spiritualità dei pellegrini che contemplano il volto impresso nel sudario, detto veronica.
Petrarca
“Movesi il vecchierel canuto et biancho
del dolce loco ov’à sua età fornita
et da la famigliuola sbigottita
che vede il caro padre venir manco;
indi trahendo poi l’antiquo fianco
per l’extreme giornate di sua vita,
quanto più po’, col buon voler s’aita,
rotto dagli anni, et dal camino stanco;
et viene a Roma, seguendo ‘l desio,
per mirar la sembianza di colui
ch’ancor lassù nel ciel vedere spera:
così, lasso, talor vo cerchand’io,
donna, quanto è possibile, in altrui
la disiata vostra forma vera.”
(Il Canzoniere, sonetto XVI)
Petrarca ricorda un viaggio (da pellegrino) che lui stesso ha compiuto a Roma.
In quella occasione ha avuto modo di vedere la devozione in un uomo anziano assorto nella contemplazione della veronica "la sembianza di colui
ch’ancor lassù nel ciel vedere spera".
Questa immagine ispira a Petrarca una similitudine con la sua situazione sentimentale.
La similitudine si sviluppa in tre punti, i primi due per vera e propria somiglianza, l’ultimo per differenza: il vecchio lascia ciò che gli è caro come il poeta, che è lontano da Laura; il vecchio osserva nella veronica i segni del volto di Cristo, che spera di vedere in Paradiso, come il poeta, che cerca nei volti delle altre donne le somiglianze con il volto di Laura (che spera di rivedere presto sulla terra); il vecchio è anche profondamente diverso dal poeta perché è ispirato da amore sacro. Il poeta, invece, soffre proprio la mancanza di
Laura, un amore terreno.