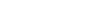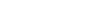Il pellegrinaggio come percorso spirituale
Nel IV secolo, al termine delle persecuzioni dell’Impero romano, iniziano i
pellegrinaggi nei luoghi in cui avevano vissuto i santi e dove erano morti i martiri.
I Pellegrini arrivavano a Roma da tutte le regioni d’Europa.
Affrontavano un cammino pieno di pericoli, tanto che al momento di partire era normale
fare testamento. Dopo un cammino che durava talvolta anche anni, giungevano a Roma, per pregare sulle tombe degli apostoli Pietro e Paolo.
Nascono come percorso dei pellegrini le Vie Romee
ad Petri sedem (dirette alla città di Pietro). È fra queste la Via Francigena, che attraversa tutta l’Europa.
Il pellegrinaggio è un cammino non solo fisico, ma anche e soprattutto
spirituale, che i pellegrini intraprendevano con la consapevolezza di dover affrontare un
percorso interiore, di poter incontrare molte avversità e dover vivere della carità altrui, con tutti i
rischi connessi, molti dei quali estremi.
A partire dalla fine del XIII secolo la pratica del pellegrinaggio cristiano si arricchisce di un evento periodico di forte richiamo: il
Giubileo, o Anno Santo.
Bonifacio VIII indice il primo Giubileo con una bolla, il 22 febbraio del 1300.
Il Giubileo crea un forte incentivo al pellegrinaggio, perché al Giubileo era collegato il processo di ottenimento dell’
indulgenza (perdono totale). I motivi per cui si andava in pellegrinaggio erano di solito tre e il più sentito era proprio la
penitenza. Ci si recava in pellegrinaggio anche per altri due motivi: rispettare un
voto (una promessa fatta durante la preghiera) o richiedere una
grazia (di solito una guarigione).
Per avere l’indulgenza giubilare era necessario fare diverse cose: oltre a confessarsi e a partecipare all’eucarestia, i fedeli dovevano compiere trenta visite alle basiliche romane, che si riducevano a quindici se erano forestieri.