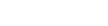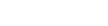Santiago, un luogo di incrocio per pellegrinaggi diversi
“La dimensione umana della società, gli ideali di libertà, giustizia e fiducia nel progresso sono i princìpi che, nel corso della storia, hanno forgiato le diverse culture, le quali ora si accingono a creare una particolare identità europea. Tale identità culturale è stata resa possibile e lo è tuttora grazie all’esistenza di uno spazio europeo che ha apportato una memoria collettiva e un intreccio attraverso vie e sentieri che oltrepassano le distanze, le frontiere e gli ostacoli della lingua. […] Forse quella fiducia che ha ispirato i pellegrini nel corso della storia, unendoli in un’aspirazione comune e trascendendo le diversità nazionali e gli interessi, è quella stessa fiducia che ispira noi oggi, in particolare i giovani, a percorrere queste antiche vie per costruire una società fondata sulla tolleranza, il rispetto degli altri, la libertà e la solidarietà”.
Così il 23 ottobre 1987 il
Consiglio d’Europa riconosceva il Cammino di Santiago come
primo itinerario culturale europeo.
Alla fine del IX secolo la maggior parte della Spagna era da tempo in mano agli
Arabi e, proprio in quegli anni, cominciava ad affermarsi il
pellegrinaggio a Santiago di Compostela.
La convivenza tra religioni non era semplice. Per i musulmani Cristianesimo e Giudaismo erano precursori della Vera Fede in Allah, per il Cristianesimo, invece, l’islam era solo
un’eresia. Malgrado le reciproche manifestazioni di
insofferenza tra le varie comunità che convivevano in quei territori vi era comunque una certa
tolleranza reciproca.
Negli anni di maggior successo del pellegrinaggio, i califfi lasciarono
liberi i cristiani che vivevano nei loro territori: spesso sorsero vere e proprie
comunità, con chiese e conventi, sotto la tutela e la vigilanza dell’autorità araba e tra i cristiani che vivevano nei territori governati dai califfi si sviluppò il cosiddetto
rito mozarabico Furono proprio i cristiani mozarabi a popolare le zone del Cammino di Santiago, costruendo
chiese e monasteri per accogliere i pellegrini, accanto agli ospizi e ai monasteri dei benedettini di Cluny. Nel 997, quando occuparono Compostela, gli arabi di Al-Mansur
risparmiarono dai saccheggi la tomba di san Giacomo, per
rispettare la pratica cristiana del pellegrinaggio.
Nel tempo il Cammino di Santiago diventò
uno dei veicoli di diffusione della cultura islamica in Europa e non solo luogo di contrapposizione ideologica e militare, come il culto di
san Giacomo matamoros potrebbe far pensare.
L’importanza culturale e spirituale che tuttora ha il Cammino è testimoniata da
libri e film. Nel 1987
Paulo Coelho, nel suo libro
Il Cammino di Santiago, descriveva un’esperienza di iniziazione spirituale e magica che si concretizzava proprio durante il suo viaggio verso Compostela.
“Quando si va verso un obiettivo - scrive Coelho -
è molto importante prestare attenzione al Cammino. È il Cammino che ci insegna sempre la maniera migliore di arrivare, e ci arricchisce mentre lo percorriamo”.
Anche il regista
Luis Buñuel, nel film
La via Lattea (1969), descriveva un percorso simbolico lungo il Cammino, evocando - con intento anticlericale - l’intera storia cristiana.
Più recentemente, nel 2008, il matematico ateo
Piergiorgio Odifreddi e il giornalista credente
Sergio Valzania hanno percorso per intero il Cammino di Santiago, discutendo sulle proprie scelte di fede. Il confronto, trasmesso quotidianamente da Radio 3, ha dato vita a un libro, intitolato anch’esso
La via Lattea.
Rito mozarabico:
è una liturgia della Chiesa cattolica nata in Spagna nel IV secolo e diffusa nella penisola iberica fino all’XI secolo. Le sue caratteristiche derivano dalla liturgia ebraica e dai culti che risalgono all’antica Roma. Alla fine del secolo scorso papa Giovanni Paolo II ha favorito la ripresa del rito mozarabico, utilizzandolo egli stesso in una messa in Vaticano nel 1992.
San Giacomo:
la raffigurazione di questo santo è molto varia. Nella cattedrale di Santiago vediamo l’apostolo trionfante, tutto vestito d’oro e gemme preziose, assiso in trono sull’Altare Maggiore. Più spesso è raffigurato come pellegrino: cappello a tesa larga, saio, mantello, borraccia, bordone e l’immancabile conchiglia. Infine è rappresentato come
Matamoros, guerriero arcigno e spavaldo in sella a un cavallo bianco, armato di stendardo e di spada, impegnato a uccidere i musulmani. Questa rappresentazione, cara alla tradizione spagnola, ha fatto dell’Apostolo l’alfiere della Reconquista dalla dominazione islamica e quindi patrono di tutta la Spagna.