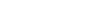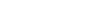Il culto delle reliquie. Storia e storie.
Il culto delle reliquie si diffuse già dal II secolo come forma di venerazione dei martiri.
Questa pratica ebbe un ruolo importante durante le
persecuzioni: a Roma si celebrava l’eucarestia sulle tombe di quelli che si erano sacrificati per non rinnegare Cristo. Questo era considerato un elemento di
vicinanza nella fede, infatti il corpo di coloro che erano rimasti fedeli a Cristo fino all’estremo sacrificio testimoniava la presenza divina e, attraverso la venerazione di ciò che era rimasto del loro passaggio sulla terra, si manifestava il legame della comunità dei cristiani con le proprie radici.
Fin dai primi secoli era diffusa l’idea che le reliquie dei santi avessero anche un proprio intrinseco
potere spirituale. Ciò che è appartenuto a un santo o lo ha toccato può mettere in relazione diretta con lui e con la sua esperienza di Dio.
Alla fine della persecuzione, nel IV secolo ebbe inizio la costruzione di monumenti commemorativi (che si definivano
memoriae o
martyria); questi luoghi erano considerati punti privilegiati di contatto fra la terra e il cielo ed erano
meta di pellegrinaggio. Alcuni giorni dedicati a determinate reliquie, o a eventi connessi a queste, come il trasferimento in un nuovo santuario e l’ostensione, divennero grandi feste popolari.
Il desiderio di vivere sotto la protezione di un santo portò anche alcuni a traslocare in luoghi santi. È questo il caso del Basso Reno, dove si registrò una migrazione popolare vicino ai luoghi di culto dei santi,
ad sanctos, da cui deriva il nome della località di
Xanten.
Le reliquie erano oggetto di tale interesse per il popolo, che non era escluso l’uso a
fini economici e le reliquie si portavano "in tournèe": nel 1194 la cattedrale di Chartres subì un incendio, da cui si salvò una camicia che si riteneva fosse quella indossata da Maria alla nascita di Gesù. Si espose in varie località il prezioso indumento per raccogliere i fondi necessari alla ricostruzione.
Quando le reliquie venivano portate in altre città, era considerato giusto offrire, per le opere di carità, la somma che si sarebbe dovuto spendere per andare in pellegrinaggio a visitare la santa reliquia nel posto da cui era giunta.
Il
Concilio di Nicea autorizzò il culto delle reliquie e ne proibì il commercio: infatti la pratica del
commercio o anche del
furto delle reliquie non erano affatto rare.
La religiosità popolare ha sempre attribuito grande valore alle reliquie, perché assieme a una iconografia facile da comprendere, gli oggetti o i resti dei santi hanno sempre suscitato un
senso di vicinanza alla fede accessibile anche per le fasce della popolazione meno colte e poco inclini per condizioni di vita a una spiritualità elevata.
Possedere reliquie era in passato anche una fonte di grande
prestigio per le comunità e non era raro che la ricerca quanto il riconoscimento di autenticità fossero gestiti con molto entusiasmo ma con scarsa cautela: furti (come nel caso di san Nicola di Bari, che non era barese) e attribuzioni superficiali erano all’ordine del giorno. Risultano riconosciuti, a esempio: dieci mani di san Procopio, quindici mandibole di san Teodoro, otto piedi di san Nestore, quattro teste di san Giorgio.
Ben diversa, naturalmente, la
dottrina in proposito:
san Girolamo mise in evidenza che il culto delle reliquie è rivolto a Dio attraverso Cristo, per la cui confessione i martiri sono morti.
Sant’Agostino, coerentemente con l’antropologia cristiana, riteneva che il culto dovesse riguardare anche i
resti dei corpi che erano stati sede dello Spirito Santo, ma specificando che ”i santi meritano l’onore del culto unicamente nella misura in cui essi sono stati servitori del Signore e da lui sono stati glorificati”.