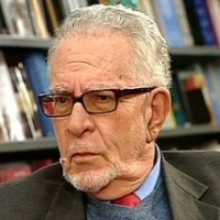Francesco D’Agostino, Testamento biologico fra astrazione e realtà
In astratto, il testamento biologico potrebbe limitarsi a contenere indicazioni, perché il medico massimizzi gli sforzi di salvaguardia della vita di chi lo ha sottoscritto; ma si tratterebbe evidentemente di indicazioni che non farebbero altro che confermare il dovere deontologico e giuridico del medico di operare sempre e comunque per la salvezza del paziente.
 Nella realtà concreta delle cose, la redazione di un testamento biologico è auspicata da e per coloro che, prefigurandosi ipotesi tragiche, ritengono che in situazione patologiche estreme sia un bene per gli uomini morire anziché continuare a vivere e preferiscono quindi essere uccisi che essere curati.
Nella realtà concreta delle cose, la redazione di un testamento biologico è auspicata da e per coloro che, prefigurandosi ipotesi tragiche, ritengono che in situazione patologiche estreme sia un bene per gli uomini morire anziché continuare a vivere e preferiscono quindi essere uccisi che essere curati.
Sul testamento biologico è in atto da anni un accanito dibattito bioetico.
I giuristi tendono, giustamente dal loro punto di vista, a ridurre questo dibattito in termini formali: che validità è possibile riconoscere a simili direttive anticipate, nel contesto di ordinamenti giuridici che non considerano la vita alla stregua di un bene disponibile?
I medici, da parte loro, si interrogano sulla compatibilità dei testamenti biologici con i loro doveri deontologici.
I bioeticisti discutono se nella sfera di insindacabile autodeterminazione del malato, quella nella quale si fa comunemente rientrare l’atto suicidario, che alcuni arrivano a qualificare come un vero e proprio diritto dell’ uomo, si possa far rientrare altresì la pratica eutanasica, concepita come forma di suicidio assistito, ove appunto non solo auspicata, ma in qualche modo prescritta da un testamento biologico.
Che la vera posta in gioco nel dibattito sul testamento biologico sia quella della legalizzazione dell’eutanasia [vedi Eutanasia] non c’è alcun dubbio. Il successo che ha avuto l’eufemismo “suicidio assistito” potrebbe far pensare ad alcuni che ciò di cui si discute è semplicemente come dar valore legale a un’estrema, doverosa forma di rispetto nei confronti della volontà di non essere curato espressa con piena consapevolezza e in forme rigorosamente garantite dal soggetto.
Ma non è così. Ne dà prova la legislazione olandese sull’eutanasia, che depenalizza questa pratica, qualificandola appunto come forma di rispetto verso la volontà del malato e poi subito la dilata, autorizzando il medico a sopprimere il paziente, anche in assenza di un esplicito testamento biologico, nel presupposto che la tutela del miglior interesse del malato (in concreto: quello di essere ucciso) possa essere affidata non solo al soggetto direttamente interessato, ma anche a chi di lui si prende cura, come appunto il medico.
Ci troviamo di fronte a un esempio emblematico di come sia facile, in “questioni di vita e di morte” inoltrarsi in quel pendio scivoloso, tante volte denunciato da alcuni bioeticisti: si parte col ritenere che bisogna legalizzare situazioni estreme, problematiche e tutto sommato rare (in concreto l’eutanasia praticata su esplicita e consapevole richiesta, pur se anticipata, del paziente), e si arriva poi subito a estendere la legalizzazione a casi simili, solo estrinsecamente in analogia ai precedenti (l’eutanasia senza esplicita e consapevole richiesta). Questo “scivolamento” da una parte è concettualmente inaccettabile, ma dall’altra è obiettivamente e paradossalmente necessario: i fautori dell’eutanasia sanno che ben difficilmente la redazione di testamenti biologici può diventare una prassi abituale e consolidata…
Giungiamo così al cuore del nostro problema. Se i fautori dell’eutanasia volessero davvero, col legittimare questa pratica, rendere omaggio alla volontà sovrana delle persone, dovrebbero radicalmente escludere dall’uccisione pietosa tutti coloro che non abbiano lasciato alcuna indicazione al riguardo, o che abbiano lasciato indicazioni ambigue o inattendibili, o che le abbiano rilasciate in condizioni psichiche e mentali tali, da far ritenere plausibile una loro incapacità di intendere e di volere.
Non ci troviamo più di fronte a un semplice dilemma bioetico, ma a una sfida radicale, che investe né più né meno che il senso stesso della presenza dell’uomo nel mondo. Gli stessi tragici temi dai quali eravamo partiti, le sofferenze dei malati terminali, i testamenti biologici, appaiono in qualche modo rimpiccoliti e banalizzati. Riflettendo sulla sua morte, l’uomo arriva ben presto a scoprire che riflette non su di un evento, su di un qualcosa che, pur se ineluttabilmente, prima o poi gli avviene; riflette piuttosto sulla sua mortalità, su ciò che egli è. Può essere, questo, un pensiero così inquietante da esigere di essere esorcizzato. Che dietro tante istanze odierne favorevoli all’eutanasia non si celi forse il più grande, il più vistoso, il più fallace esorcismo che mai l’ umanità abbia creato?
Adriano Pessina, Testamento “biologico”: una questione aperta
 In Italia, in questi ultimi mesi, si è aperta una vasta campagna a favore del cosiddetto “testamento biologico”. Come è noto, con questa brutta espressione (un testamento è pur sempre un atto personale e la vita umana, di cui si sta parlando, non è mai un mero fatto biologico) si tende a tradurre la più corretta dizione di direttive (o disposizioni) anticipate di trattamento, cioè di quelle indicazioni che un cittadino dovrebbe liberamente (o obbligatoriamente, secondo alcuni progetti di legge) redigere per indicare a quali trattamenti medici intende o no essere sottoposto nel caso non fosse più in grado di esprimere il proprio motivato consenso.
In Italia, in questi ultimi mesi, si è aperta una vasta campagna a favore del cosiddetto “testamento biologico”. Come è noto, con questa brutta espressione (un testamento è pur sempre un atto personale e la vita umana, di cui si sta parlando, non è mai un mero fatto biologico) si tende a tradurre la più corretta dizione di direttive (o disposizioni) anticipate di trattamento, cioè di quelle indicazioni che un cittadino dovrebbe liberamente (o obbligatoriamente, secondo alcuni progetti di legge) redigere per indicare a quali trattamenti medici intende o no essere sottoposto nel caso non fosse più in grado di esprimere il proprio motivato consenso.
I fautori di questa carta di autodeterminazione tendono, nella maggior parte dei casi, a negare che si tratti di uno strumento atto ad introdurre l’eutanasia [vedi Eutanasia] e il suicidio assistito. Molti, infatti, ritengono che si tratti di un mezzo per prolungare la cosiddetta e auspicata alleanza terapeutica tra medico e paziente: una specie di prolungamento del consenso informato, volto ad evitare, in primo luogo, l’accanimento terapeutico e ad evidenziare la giusta autonomia del paziente.
Posto in questi termini, analoghi a quelli auspicati dal documento del Comitato Nazionale per la Bioetica, non risulterebbe ragionevole opporsi all’introduzione e alla legalizzazione di questa nuova carta dei diritti del paziente. Ma, si è osservato, proprio l’evidente ed oggettiva bontà di questa dichiarazione fa pensare anche alla sua sostanziale ed oggettiva inutilità: che senso avrebbe chiedere ciò che sarebbe doveroso ottenere?
Forse perché si teme che, in realtà, i medici abusino della loro professione e infliggano ai pazienti trattamenti sproporzionati, inutili e persino dannosi? Oppure, più banalmente, si pensa che il rapporto tra medico e paziente debba sempre più essere improntato ad un rapporto di natura meramente contrattuale, nel quale l’ideale della cosiddetta alleanza terapeutica è solo, appunto, un ideale, visto che non ci sarebbe quella previa condivisione di valori e di beni che permettono ad una società civile di promuovere una professione medica capace di autolimitarsi nei suoi interventi senza bisogno della mediazione della magistratura? O, ancora, si ritiene che, in realtà, questa carta debba far valere prima di tutto la soggettiva concezione di qualità della vita che ogni cittadino dovrebbe evidenziare, decidendo, in anticipo rispetto alla sua concreta situazione patologica, a quali condizioni sarebbe disposto o no a continuare a vivere?
 L’unica cosa certa è che non ha senso paragonare queste direttive al consenso informato: nel primo caso, infatti, chi è chiamato a decidere è prima di tutto un cittadino che vuol far valere la propria autonomia, nel secondo caso, invece, è un cittadino malato, consapevole della propria situazione clinica, chiamato a decidere, all’interno di un sistema sanitario nazionale che per ora è gratuito per tutti, la programmazione di interventi concordati e conosciuti.
L’unica cosa certa è che non ha senso paragonare queste direttive al consenso informato: nel primo caso, infatti, chi è chiamato a decidere è prima di tutto un cittadino che vuol far valere la propria autonomia, nel secondo caso, invece, è un cittadino malato, consapevole della propria situazione clinica, chiamato a decidere, all’interno di un sistema sanitario nazionale che per ora è gratuito per tutti, la programmazione di interventi concordati e conosciuti.
Le direttive anticipate, a differenza del consenso informato, sono necessariamente generiche e riguardano tipologie di trattamenti e situazioni cliniche differenti: sono indicazioni fatte a partire da un vissuto ancora estraneo alla malattia e, quindi, condizionato da una vaga rappresentazione di come si sarebbe o no disposti a vivere.
Fino a che punto l’astratta difesa delle direttive anticipate non finisce con il favorire un vero e proprio abbandono terapeutico e una vera e propria limitazione a quella perseveranza terapeutica che è necessaria per custodire la vita di coloro che pur non essendo più in grado di decidere pienamente (come, per esempio, gli anziani affetti da demenza senile) sono pur sempre cittadini e persone degne di rispetto e di tutela? In che modo questa ondata di consenso nei confronti di una carta che sembra promuovere soprattutto l’astensione dai trattamenti di assistenza e cura non finisce con l’influenzare negativamente quelle prassi mediche di confine che aiutano oggi molte persone a convivere con la loro malattia, malgrado la limitazione delle loro facoltà?
Non è facile rispondere, ma è necessario pensarci seriamente perché sono in gioco questioni che trascendono il legittimo no all’eutanasia e all’accanimento terapeutico. Prima di cavalcare l’onda di un consenso politicamente corretto alle direttive anticipate, occorrerà prendere seriamente in considerazione le complesse problematiche, mediche, sociali, etiche, esistenziali che investono la prassi medica oggi.
C’è una responsabilità sociale, politica ed etica, che deve far riflettere sul significato di strumenti legali apparentemente neutri che modificano, di fatto e di diritto, lo stesso modo di pensare l’assistenza sanitaria, di allocare le risorse, di promuovere le ricerche nel campo della salute e della cura dei cittadini, comunque essi siano, ricchi o poveri, colti o ignoranti, consapevoli o no.
Una società civile non è mai una pura somma di autonomie atomisticamente intese e la malattia non determina una categoria sociale, ma un aspetto della condizione umana che riguarda tutti. Le carte dei diritti diventano facilmente diritti di carta laddove si frantumano i legami sociali che appartengono alla categoria dei doveri.











 Si è imposta una riflessione nuova da parte del Parlamento Nazionale, sollecitato a varare, si spera col concorso più ampio, una legge sul fine vita che – questa l’attesa − riconoscendo valore legale a dichiarazioni inequivocabili, rese in forma certa ed esplicita, dia nello stesso tempo tutte le garanzie sulla presa in carico dell’ammalato, e sul rapporto fiduciario tra lo stesso e il medico, cui è riconosciuto il compito – fuori da gabbie burocratiche − di vagliare i singoli atti concreti e decidere in scienza e coscienza. Dichiarazioni che, in tale logica, non avranno la necessità di specificare alcunché sul piano dell’alimentazione e dell’idratazione, universalmente riconosciuti ormai come trattamenti di sostegno vitale, qualitativamente diversi dalle terapie sanitarie. Una salvaguardia indispensabile, questa, se non si vuole aprire il varco a esiti agghiaccianti anche per altri gruppi di malati non in grado di esprimere deliberatamente ciò che vogliono per se stessi.
Si è imposta una riflessione nuova da parte del Parlamento Nazionale, sollecitato a varare, si spera col concorso più ampio, una legge sul fine vita che – questa l’attesa − riconoscendo valore legale a dichiarazioni inequivocabili, rese in forma certa ed esplicita, dia nello stesso tempo tutte le garanzie sulla presa in carico dell’ammalato, e sul rapporto fiduciario tra lo stesso e il medico, cui è riconosciuto il compito – fuori da gabbie burocratiche − di vagliare i singoli atti concreti e decidere in scienza e coscienza. Dichiarazioni che, in tale logica, non avranno la necessità di specificare alcunché sul piano dell’alimentazione e dell’idratazione, universalmente riconosciuti ormai come trattamenti di sostegno vitale, qualitativamente diversi dalle terapie sanitarie. Una salvaguardia indispensabile, questa, se non si vuole aprire il varco a esiti agghiaccianti anche per altri gruppi di malati non in grado di esprimere deliberatamente ciò che vogliono per se stessi.
 I medici dovrebbero immedesimarsi nel paziente e fornirgli ogni elemento necessario a formare una scelta responsabile.
I medici dovrebbero immedesimarsi nel paziente e fornirgli ogni elemento necessario a formare una scelta responsabile.
 Il testamento biologico attesta la volontà personale circa eventuali trattamenti futuri, indicando anticipatamente ai medici i limiti del loro intervento qualora il paziente non fosse più in grado di farlo, difendendo così la sua libertà personale dal potere della tecnica. La scienza e la pratica medica possono offrire un contributo fondamentale all'autodeterminazione del paziente: libertà di cura è sempre, contestualmente, libertà di rifiutare la cura, che è un diritto costituzionalmente garantito. Il testamento biologico pertanto non è uno strumento del paziente “contro” il medico, ma garantisce il rispetto dell'alleanza terapeutica curante – curato che sempre deve fare da cornice alla cura.
Il testamento biologico attesta la volontà personale circa eventuali trattamenti futuri, indicando anticipatamente ai medici i limiti del loro intervento qualora il paziente non fosse più in grado di farlo, difendendo così la sua libertà personale dal potere della tecnica. La scienza e la pratica medica possono offrire un contributo fondamentale all'autodeterminazione del paziente: libertà di cura è sempre, contestualmente, libertà di rifiutare la cura, che è un diritto costituzionalmente garantito. Il testamento biologico pertanto non è uno strumento del paziente “contro” il medico, ma garantisce il rispetto dell'alleanza terapeutica curante – curato che sempre deve fare da cornice alla cura.
 Se le volontà del paziente chiedono che sia tolta la vita, né il medico né il paziente devono decidere, perché la vita va protetta, difesa e prolungata con ogni mezzo. Sarebbe un suicidio assistito e il suicidio è inamissibile.
Se le volontà del paziente chiedono che sia tolta la vita, né il medico né il paziente devono decidere, perché la vita va protetta, difesa e prolungata con ogni mezzo. Sarebbe un suicidio assistito e il suicidio è inamissibile.
 I medici devono utilizzare tutta la loro conoscenza scientifica per curare i malati con grande compassione, mentre i pazienti devono avere il diritto di scegliere liberamente quale tipo di trattamento desiderano.
I medici devono utilizzare tutta la loro conoscenza scientifica per curare i malati con grande compassione, mentre i pazienti devono avere il diritto di scegliere liberamente quale tipo di trattamento desiderano.
 Io ho fatto il testamento biologico qualche anno fa, e per tre motivi. Per riaffermare le mie convinzioni sulla libertà di disporre della propria vita. Per l’amore profondo verso i miei familiari, che non voglio siano mai straziati dal dubbio sul che fare della mia esistenza. Per il rispetto verso i medici che si prenderanno cura di me. Ho voluto anche renderlo pubblico: «Io sottoscritto Umberto Veronesi, ..., nel pieno delle mie facoltà mentali e in totale libertà di scelta, dispongo quanto segue: in caso di malattia o lesione traumatica cerebrale irreversibile e invalidante chiedo di non essere sottoposto ad alcun trattamento terapeutico o di sostegno (nutrizione e idratazione)... Queste mie volontà dovranno essere assolutamente rispettate dai medici che si prenderanno cura di me...». Considero il testamento biologico l’atteggiamento più corretto soprattutto verso i medici curanti, cioè verso chi si troverà, concretamente, ad avere la responsabilità terapeutica di un individuo non più consapevole. Nel febbraio 2009 il giurista
Io ho fatto il testamento biologico qualche anno fa, e per tre motivi. Per riaffermare le mie convinzioni sulla libertà di disporre della propria vita. Per l’amore profondo verso i miei familiari, che non voglio siano mai straziati dal dubbio sul che fare della mia esistenza. Per il rispetto verso i medici che si prenderanno cura di me. Ho voluto anche renderlo pubblico: «Io sottoscritto Umberto Veronesi, ..., nel pieno delle mie facoltà mentali e in totale libertà di scelta, dispongo quanto segue: in caso di malattia o lesione traumatica cerebrale irreversibile e invalidante chiedo di non essere sottoposto ad alcun trattamento terapeutico o di sostegno (nutrizione e idratazione)... Queste mie volontà dovranno essere assolutamente rispettate dai medici che si prenderanno cura di me...». Considero il testamento biologico l’atteggiamento più corretto soprattutto verso i medici curanti, cioè verso chi si troverà, concretamente, ad avere la responsabilità terapeutica di un individuo non più consapevole. Nel febbraio 2009 il giurista  Nella realtà concreta delle cose, la redazione di un testamento biologico è auspicata da e per coloro che, prefigurandosi ipotesi tragiche, ritengono che in situazione patologiche estreme sia un bene per gli uomini morire anziché continuare a vivere e preferiscono quindi essere uccisi che essere curati.
Nella realtà concreta delle cose, la redazione di un testamento biologico è auspicata da e per coloro che, prefigurandosi ipotesi tragiche, ritengono che in situazione patologiche estreme sia un bene per gli uomini morire anziché continuare a vivere e preferiscono quindi essere uccisi che essere curati. In Italia, in questi ultimi mesi, si è aperta una vasta campagna a favore del cosiddetto “testamento biologico”. Come è noto, con questa brutta espressione (un testamento è pur sempre un atto personale e la vita umana, di cui si sta parlando, non è mai un mero fatto biologico) si tende a tradurre la più corretta dizione di direttive (o disposizioni) anticipate di trattamento, cioè di quelle indicazioni che un cittadino dovrebbe liberamente (o obbligatoriamente, secondo alcuni progetti di legge) redigere per indicare a quali trattamenti medici intende o no essere sottoposto nel caso non fosse più in grado di esprimere il proprio motivato consenso.
In Italia, in questi ultimi mesi, si è aperta una vasta campagna a favore del cosiddetto “testamento biologico”. Come è noto, con questa brutta espressione (un testamento è pur sempre un atto personale e la vita umana, di cui si sta parlando, non è mai un mero fatto biologico) si tende a tradurre la più corretta dizione di direttive (o disposizioni) anticipate di trattamento, cioè di quelle indicazioni che un cittadino dovrebbe liberamente (o obbligatoriamente, secondo alcuni progetti di legge) redigere per indicare a quali trattamenti medici intende o no essere sottoposto nel caso non fosse più in grado di esprimere il proprio motivato consenso. L’unica cosa certa è che non ha senso paragonare queste direttive al consenso informato: nel primo caso, infatti, chi è chiamato a decidere è prima di tutto un cittadino che vuol far valere la propria autonomia, nel secondo caso, invece, è un cittadino malato, consapevole della propria situazione clinica, chiamato a decidere, all’interno di un sistema sanitario nazionale che per ora è gratuito per tutti, la programmazione di interventi concordati e conosciuti.
L’unica cosa certa è che non ha senso paragonare queste direttive al consenso informato: nel primo caso, infatti, chi è chiamato a decidere è prima di tutto un cittadino che vuol far valere la propria autonomia, nel secondo caso, invece, è un cittadino malato, consapevole della propria situazione clinica, chiamato a decidere, all’interno di un sistema sanitario nazionale che per ora è gratuito per tutti, la programmazione di interventi concordati e conosciuti.