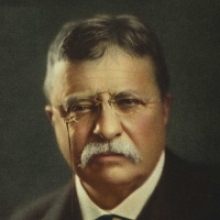Monsignor Giancarlo Perego, direttore della Fondazione Migrantes e Franco Pittau, coordinatore del Dossier statistico Immigrazione Caritas/Migrantes, sono stati intervistati da “A conti fatti”, il programma di economia sociale trasmesso dal canale italiano della Radio Vaticana.
Monsignor Perego: In questi giorni state festeggiando un compleanno importante, 25 anni dalla fondazione della Migrantes: possiamo tirare le somme, cos’è cambiato in Italia in termini di accoglienza e integrazione?
Quando nasceva la Migrantes, 25 anni fa, l’immigrazione era 10 volte inferiore rispetto ad oggi, l’Italia non raggiungeva il milione e mezzo di immigrati. In quel momento la Chiesa italiana aveva intuito l’importanza di far nascere una fondazione che potesse da subito considerare questo mondo come un mondo importante, non solo per le nostre città, per il nostro Paese, ma anche per la nostra Chiesa; in questi anni è cresciuto quest’incontro nuovo con persone di 198 nazionalità diverse e anche nelle nostre comunità è cresciuto un cammino di incontro e di accoglienza. Ci sarebbe voluto un cammino migliore anche sul piano politico sociale che invece ha visto reazioni diverse di fronte a questo fenomeno per cui l’Italia è sempre più non solo un Paese di emigranti, ma anche un Paese di immigrati.
 Dottor Pittau, è stato presentato pochi giorni fa il Dossier Statistico sull’Immigrazione a cura di Caritas e Migrantes dal titolo “Non solo numeri”: sono 5 milioni gli immigrati regolari in Italia. Tralasciando per un momento il discorso dell’integrazione, del rispetto delle altre culture ecc., vogliamo spiegare perché questo Paese ha così bisogno di cittadini immigrati, soprattutto a supporto del sistema economico-produttivo?
Dottor Pittau, è stato presentato pochi giorni fa il Dossier Statistico sull’Immigrazione a cura di Caritas e Migrantes dal titolo “Non solo numeri”: sono 5 milioni gli immigrati regolari in Italia. Tralasciando per un momento il discorso dell’integrazione, del rispetto delle altre culture ecc., vogliamo spiegare perché questo Paese ha così bisogno di cittadini immigrati, soprattutto a supporto del sistema economico-produttivo?
L’Italia ne ha bisogno per due motivi fondamentali, uno è demografico, l’altro occupazionale.
Dal punto di vista demografico il tasso di natalità in Italia è molto basso, pur aiutato dagli immigrati rimane ancora molto basso e non abbiamo un ricambio sufficiente nella popolazione. La popolazione italiana comincia a diminuire e diminuirà ancora di più, ma quello che preoccupa maggiormente è che molti diventano vecchi e bisogna mantenerli e per questo servono nuove forze lavorative. Non bisogna considerare questa difficilissima fase di crisi, che speriamo passi presto, perché quando ci sarà la ripresa ci sarà bisogno di nuovi lavoratori sia a livelli bassi che a livelli medi e in futuro anche a livelli elevati perché la competizione internazionale si giocherà sulla qualità.
Questa necessità demografica si traduce quindi in necessità occupazionale e questo bisogna spiegare alla gente; noi siamo come una sedia che prima aveva quattro gambe e ora ne ha tre con la quarta che ci viene assicurata dagli immigrati.
Sono circa 250 000 i cittadini stranieri titolari di aziende, crescono anche i conti correnti (+25% in un anno), soprattutto quelli intestati ad imprenditrici donne. Questo significa che l’inserimento economico crea o agevola l’inserimento sociale?
L’inserimento economico facilita di per sé l’inserimento sociale tanto tra gli italiani quanto tra gli immigrati come del resto l’inserimento sociale facilità l’inserimento economico perché quando queste persone si sentono accolte e assistite nelle loro iniziative allora danno seguito alla loro capacità inventiva. Il dato sull’imprenditoria è sorprendente: nonostante le difficoltà e nonostante questo periodo di crisi nell’ultimo anno abbiamo avuto 20mila imprese straniere in più mentre le nostre diminuiscono o stanno stabili. Gli immigrati si sentono incoraggiati e creano lavoro, all’inizio siamo noi a dargli lavoro poi lo creano loro e certe volte lo danno anche agli italiani. C’è un’area lavorativa stimata in più di mezzo milione di persone che è stata creata dagli immigrati; bisogna iniziare a pensare a queste cose positive e connesse all’immigrazione.
Quando si passa in rassegna la situazione dei dipendenti stranieri si nota però che questi hanno in media una retribuzione inferiore rispetto ai colleghi italiani. Come si colma questo gap? È anche questo un problema di integrazione?
È un problema di cultura, di mentalità cui è molto sensibile la Chiesa perché le questioni come questa non si risolvono solo con le leggi, noi ne abbiamo tante in Italia e molte non vengono rispettate. È la mentalità che ci porta a cambiare i comportamenti e noi dovremo abituarci a considerare gli immigrati una risorsa dell’Italia, una risorsa interna al Paese che dobbiamo trattare bene perché ne va del futuro del nostro Paese; questo non capita sempre e certe volte ci sentiamo autorizzati a pagarli di meno o a farli lavorare in nero.
È un problema di cultura; ci sono le leggi, le organizzazioni a tutela degli immigrati, l’associazionismo, ma bisognerebbe fare di più. Non bastano le cose formali ci vuole un supplemento di cuore e sensibilità come del resto dice da sempre la Chiesa.
Si è appena concluso a Roma Il Festival del Cinema che ha assegnato il Premio speciale della giuria ad “Alì ha gli occhi azzurri”, il film di Giovannesi che racconta l’Italia dei figli degli immigrati, e lancia il tema della cittadinanza e del difficile processo di integrazione culturale. Come leggete questo premio? E, vi chiederei, cosa dobbiamo aspettarci a livello normativo e pastorale in questo anno europeo della cittadinanza (2013)?
La storia di questi fidanzati è la storia di incontro, di meticciato che vede le coppie miste, i fidanzati, l’incontro nelle scuole di 800mila studenti stranieri, l’incontro che sta crescendo con il volontariato nel mondo delle nostre parrocchie e degli oratori. Tutti questi incontri chiedono un grosso impegno e un grosso sforzo sul piano dell’integrazione, soprattutto il riconoscimento di un’integrazione che sta già avvenendo dal basso e che ha bisogno di essere riconosciuta sul piano politico dando gambe a un piano integrazione che già nel 2009 Caritas e Migrantes con il Dossier sollecitavano per non fermarsi semplicemente ad un contratto che riguarda semplicemente la conoscenza della lingua.
Credo che il tema della cittadinanza oggi sia un tema di qualità della nostra democrazia e in questo senso questo film credo solleciti a continuare questo impegno che campagne come “l’Italia sono anch’io” e altre iniziative che in questi giorni stanno avvenendo sul piano della cittadinanza onoraria con l’approvazione di alcune delibere in centinaia di municipi d’Italia, stanno portando avanti. Purtroppo ci sono 26 proposte di legge profondamente contraddittorie in parlamento; mi augurerei che il 2013 sia un anno importante, un passo avanti sulla cittadinanza, ma questa divisione, questa grossa frammentazione, rende difficile arrivare il prossimo anno a una soluzione.
È bene il fatto che il 70% degli italiani, come dice l’istat, inviti i nostri politici a guardare in positivo quest’esperienza così come il tema del diritto di voto; mi auguro che il 2013 ci dia dei segnali importanti non solo dal basso, ma anche dall’alto e proprio in queste direzioni le comunità parrocchiali siano laboratori di cittadinanza e di incontro dove il rispetto diventi anche capacità di riconoscimento dell’altro, sue capacità e possibilità. Noi eravamo abituati alla dimensione solo italiana, ma se andiamo per strada può darsi che incontriamo dodici, quindici cittadini stranieri tra cento che passano. Ci dobbiamo abituare a quest’altra dimensione fatta da persone che vengono da altri Paesi e vogliono essere cittadini come noi, soprattutto chi è nato qui. E allora bisogna sperare che cambi la mentalità e, come dice Mons. Perego, sono state tante le proposte di legge e se ci fosse la buona volontà tra queste si potrebbe trovare una buona mediazione. È positivo che questo Parlamento abbia fatto un ordine del giorno che impegna il governo a risolvere i problemi della cittadinanza. Ripeto, i figli degli immigrati sono i nostri figli, sono una nostra risorsa; l’immigrazione non è un temporale che viene e passa, ma fa ormai parte del panorama italiano, l’immigrazione è Italia.
Monsignor Perego, in seno alle istituzioni scolastiche e ai consigli territoriali per l’immigrazione, cosa si fa per permettere e agevolare l’integrazione (a partire dalle agenzie educative) e cosa invece manca?
Vediamo nelle scuole un grande impegno da parte degli insegnanti e anche degli studenti per l’incontro scolastico con persone che sono di nazionalità diverse.
L’aspetto più debole riguarda certamente gli strumenti didattici nuovi che possono leggere questo incontro e aiutarlo, non riducendo le materie come la storia e la geografia a una storia o geografia italiana, ma leggendo la diversità dei Paesi, delle storie, delle lingue che oggi frequentano la nostra scuola. È stato molto bello che in alcune scuole come seconda lingua si sia scelto il cinese piuttosto che il rumeno, leggendo in prospettiva la storia di alcuni Paesi che potranno essere Paesi importanti nel contesto europeo o nel contesto economico mondiale, oltre che leggere la situazione di città che stanno cambiando alla luce di presenze significative in questo senso.
Manca anche una mediazione scolastica che è un elemento importante. Tante volte per l’inserimento scolastico di bambini che arrivano in tempi diversi dentro la scuola, purtroppo anche per i tempi lunghi del ricongiungimento familiare, manca attenzione legislativa per permettere da subito questo tipo di inserimento scolastico che invece viene reso difficile perché occorre aspettare i tempi dell’arrivo di fatto del bambino o della bambina che arriva dopo la costituzione delle classi.
Il 31 dicembre 2012, è prevista la chiusura dell’emergenza nord Africana e delle relative strutture di accoglienza. Qual è il vostro appello come Migrantes?
Accelerare assolutamente un regolare permesso di soggiorno per tutti coloro che sono in attesa, e sono oltre il 60% delle persone che hanno avuto una protezione umanitaria in questi tempi di emergenza, in modo tale da permettere da subito una circolazione non solo in Italia, ma anche in Europa così da avviare un percorso di studio o di lavoro.
Allo stesso tempo continuare nella tutela dei soggetti più deboli, penso ai minori non accompagnati, alle madri incinta, alle madri con bambini dando quindi risorse strutturali a chi sta accogliendo queste persone che sono in fuga da 22 guerre in atto e da 44 Paesi nel mondo che sono fragili, penso in alla Siria, alla situazione del centro Africa, ma penso anche alle tante situazioni che possono determinare un cammino e una fuga di tante popolazioni.
Giuliano Amato, Come e perché l'Europa deve valorizzare l'immigrazione e la sua diversità culturale
 Quando definiamo il nostro atteggiamento nei confronti delle differenze etniche, noi europei tendiamo a fare nostra una di due note tesi. Qualcuno sposa la teoria del “contatto”, la quale sostiene che la convivenza di diverse comunità porta a un vicendevole arricchimento, in quanto favorisce la comprensione reciproca che alla fine produce una maggiore armonia tra i vari gruppi. Altri si schierano a favore della teoria del “conflitto”, che afferma l’esatto contrario.
Quando definiamo il nostro atteggiamento nei confronti delle differenze etniche, noi europei tendiamo a fare nostra una di due note tesi. Qualcuno sposa la teoria del “contatto”, la quale sostiene che la convivenza di diverse comunità porta a un vicendevole arricchimento, in quanto favorisce la comprensione reciproca che alla fine produce una maggiore armonia tra i vari gruppi. Altri si schierano a favore della teoria del “conflitto”, che afferma l’esatto contrario.
È evidente che le due teorie hanno implicazioni opposte quando si discute di immigrazione. La teoria del contatto favorisce le politiche di apertura e il ricorso a tutti gli strumenti adatti a incoraggiare l’integrazione degli immigrati nelle nostre comunità, pur nel rispetto delle loro identità culturali. La teoria del conflitto è sostenuta da quanti cercano di limitare il più possibile l’immigrazione e che, pertanto, assecondano quelle norme e quelle pratiche che finiranno per produrre la massima ostilità nei confronti dei nuovi venuti. Inutile dire che l’opinione prevalente in Europa e, quindi, la correttezza politica propendono per la prima teoria, mentre la seconda rispecchia le visioni anti- antidiscriminatorie della destra estrema, ampiamente criticate.
Alcune recenti ricerche negli Stati Uniti ci dicono quanto sia scomoda la realtà e quanto sia importante per noi essere consapevoli delle sue sgradevoli verità. Tali ricerche, condotte in modo indipendente tra loro dal sociologo Robert Putnam, dal politologo Scott Page, dagli economisti Edward Glaeser e Alberto Alesina, e da un’altra coppia di esperti di economia, Matthew Kahn e Dora Costa, hanno prodotto risultati che concordano in modo sorprendente. Secondo Putnam, in realtà nessuna delle due teorie è valida.
Ciò che si verifica nelle comunità più diversificate è un “generale malessere civile”: meno persone si dedicano al volontariato, si versa in beneficenza meno denaro e il grado di fiducia è minore non solo tra i diversi gruppi etnici, ma anche all’interno dei singoli gruppi. In altri termini, meno solidarietà e identità più ristrette.
Khan e Costa confermano le conclusioni della ricerca di Putnam, aggiungendo altre prove a supporto, relative ai finanziamenti scolastici e ad altri indicatori, mentre Glaeser e Alesina affermano che all’incirca metà della differenza tra la spesa sociale dell’Europa e quella degli Stati Uniti potrebbe dipendere dalla maggiore diversificazione etnica dell’America. Forse è un’interpretazione eccessiva, ma resta il fatto che anche in Europa si tende a contenere la spesa sociale per gli immigrati finché non sono loro garantiti tutti i diritti di cittadinanza.
Qualcuno potrebbe ribattere che i riscontri di Putnam, pur non rispecchiando la teoria del conflitto, sono più vicini a questa che alla teoria del contatto.
Putnam potrebbe replicare che questa è solo una faccia della medaglia. L’altra, evidenziata dallo stesso Putnam e da Page, è di natura economica e riguarda la maggiore produttività e i più alti tassi di innovazione che si riscontrano quando c’è interazione tra gruppi di lavoratori (per lo più specializzati) di diverse culture. Si scopre che invece di provocare divisione e diffidenza, i diversi modi di pensare favoriscono una dinamica innovativa e quindi aggiungono qualcosa in più, magari poco rilevante quantitativamente, ma significativo dal punto di vista qualitativo.
Che indicazioni è possibile trarre da questi dati? Se dovessero essere considerati incontrovertibili, sarebbe semplice inspirarsene per elaborare politiche non lontane da quelle sostenute dall’estrema destra: in altre parole dovremmo aprire la porta solo agli immigrati molto qualificati e chiuderla in faccia al numero molto più grande di persone che vogliono emigrare dal proprio Paese in Europa per sfuggire alla miseria, ma la cui integrazione nelle nostre comunità è molto difficile, soprattutto se si tratta di musulmani senza istruzione e arretrati.
Ma si tratta davvero di dati incontrovertibili? Non dipendono da noi, dalla nostra cultura, dai nostri obiettivi, dalla nostra età e da altri fattori soggetti al cambiamento? Le ricerche citate forse sorprenderanno molti europei, poiché si pensa comunemente che gli americani siano più disposti degli europei ad accettare i rischi, l’incertezza e la diversità. Negli Stati Uniti la popolazione è più giovane e questo dovrebbe renderla più propensa ad affrontare mutamenti e differenze. Ma se gli americani sono così diffidenti nei confronti della diversità, che cosa possiamo aspettarci da noi stessi? La mia risposta non può che essere questa: da noi stessi possiamo aspettarci un franco riconoscimento del tipo di società che vogliamo essere e di che cosa siamo disposti a fare per realizzarla. L’invecchiamento della popolazione europea è accentuato dai bassi tassi di natalità che fanno prospettare una continua contrazione del numero di nativi europei, con una percentuale sempre più alta di ultrasessantacinquenni. Già oggi si lamentano carenze di manodopera e non sono soltanto i vuoti per mansioni molto qualificate che hanno bisogno di essere colmati a causa di risorse umane insufficienti. Il problema è destinato a peggiorare mettendo in gioco la nostra crescita economica e il futuro dell’Europa nel mondo. Per questo le alternative che ci si presentano sono chiare. Se preferiamo difendere le nostre identità europee, così come sono ora, ed evitare tensioni e conflitti nei nostri territori limitando il numero degli immigrati, dobbiamo anche accettare il nostro declino, perché l’Europa tramonterà irreversibilmente, proprio come è accaduto a molte società in passato. Ma se non vogliamo accettare questa cupa prospettiva, siamo ancora in grado di evitare che si verifichi. Dobbiamo essere consapevoli, però, che non ci basterà contare su quella che per il momento è considerata la correttezza politica prevalente. È questo che ci insegna la lezione americana di cui sopra. In Europa continueremo ad avere opinioni diverse su questo tema delicato e cruciale, ma sarebbe un grave errore avere divergenze tra noi sui fatti di fondo. È un fatto che la teoria del contatto non rispecchia necessariamente la realtà. Il contatto tra diversi gruppi etnici e religiosi può provocare conflitti (e in molti casi lo fa), può incoraggiare la diffidenza e provocare tutte quelle conseguenze negative descritte da Putnam. Il quale tuttavia scrive: «Sarebbe altrettanto grave se un conservatorismo antistorico ed etnocentrico finisse per negare che affrontare quella sfida sia fattibile e auspicabile».
Affrontare quella sfida è possibile, ma richiederà un forte impegno su vari fronti. Dobbiamo concordare le nostre azioni con i Paesi di provenienza dei futuri immigrati, dobbiamo puntare a garantire il loro afflusso in modo pianificato e a gestirlo senza intralci, in relazione alle esigenze del nostro mercato del lavoro. Avremo anche bisogno di dotarci di tutti i servizi necessari per fare fronte ai bisogni dei nuovi residenti, che contribuiranno alla nostra crescita economica con il proprio lavoro e con le imposte che verseranno. Dovremo assicurare che ai nostri concittadini non vengano a mancare questi stessi servizi e dovremo stare attenti ad adottare politiche locali che promuovano la formazione (e non solo la scolarizzazione) e la comunicazione. Dovremo agire in modo particolarmente efficace nella lotta alla criminalità, perché non c’è niente di più devastante dell’equazione “immigrato uguale delinquente”. Questo significa anche lottare contro l’immigrazione illegale, che è nello stesso tempo un’attività illecita e un incubo per gli emigranti che rischiano la propria vita, come per i nostri concittadini che la percepiscono come una marea umana inarrestabile.
Ciò che occorre, pertanto, è un progetto. Questa è una missione che va perseguita in modo convincente, portando avanti azioni diverse in modo efficace. Significa fare molto di più che predicare la correttezza politica. Tuttavia, anche se riusciremo a fare tutto questo, resterà irrisolta la questione più spinosa: come faremo a colmare la distanza che esiste tra le nostre comunità e una popolazione musulmana in continua crescita? I timori del terrorismo hanno reso più che mai ardua la questione e non è solo la destra conservatrice che ha opinioni negative a riguardo. È comunque una sfida che dipende da noi: sta a noi capire che non abbiamo davanti il problema di un’unica diversità islamica, ma che nell’Islam esistono molte diversità le quali, se ben gestite, possono favorire la crescita del pluralismo nelle nostre società, anche affrontando differenze inaccettabili, come le disparità di genere, che sono prodotte più dall’arretratezza che dalla religione. Dipenderà da noi accettare o rifiutare gli insegnamenti che ci vengono dalla nostra stessa storia, soprattutto nei Paesi del Mediterraneo, dove nei secoli passati si sviluppò un melting pot di popoli che contribuì alla loro prosperità.
Le tendenze di oggi e di domani renderanno le nostre società sempre più multietniche, multiculturali, multireligiose. Ma non basterà attribuire loro i valori che noi privilegiamo. Dobbiamo essere consapevoli che tutte possono tradursi in incubi se lasciamo che si sviluppino secondo proprie dinamiche naturali. Jacques Barzun, l’eminente studioso – naturalizzato americano – di storia moderna, ha scritto qualche anno fa che la decadenza dell’Europa è cominciata quando abbiamo lasciato spegnere quello straordinario motore che aveva forgiato la nostra identità partendo da tante società differenti. Io sono convinto che quel motore esista ancora e che la questione sia sapere come si fa a riavviarlo.
Poche questioni sono così politicamente “divísive” come l'immigrazione. Sono tante le parole che si prestano a diventare bandiere al vento: dalla A di accoglienza alla T di tradizione. «Governi, attivisti politici e critici dell'immigrazione di ogni risma non si vergognano minimamente di giustificare le barriere contro l'immigrazione col linguaggio tipico degli Stati di polizia», scrive Alvaro Vargas Llosa nelle conclusioni del suo Global Crossings: Immigration, Civilization, and America. Come sempre innanzi alle cose che spaventano, si fa in fretta a perdere di vista il dato umano (la libertà di movimento delle persone) e assieme la razionalità del fenomeno, i cui effetti restano incompresi. Per Vargas Llosa, saggista e Senior Fellow dell'Independent Institute «non c'è nulla di nuovo e nulla da temere», se non i luoghi comuni. L'area del mondo nella quale la percentuale di immigrati è più rilevante sono i Paesi arabi attorno al golfo persico, non è vero che si emigra solo dalle nazioni più povere (Paesi che si arricchiscono continuano a "esportare" individui), non è vero neppure che il più alto tasso di incarcerazione negli Usa si riscontra fra i “latinos”. Global Crossing è una risposta razionale e ponderata ai timori dei molti elettori che, nel segreto dell'urna, votano contro l'immigrazione. Aiuta anche a correggere l'impressione di una contrapposizione netta fra destra e sinistra. Negli Usa gli interessi organizzati più favorevoli ai migranti sono le lobby agricole, il conservatore “Wall Street Journal” ha una posizione tradizionalmente a favore dell'apertura delle frontiere, i più accaniti “chiusisti” sono i sindacati. Il vero nemico della libertà di movimento è il nazionalismo. La sacralizzazione dell'idea di nazione ci ha allontanati dalla saggezza di Montesquieu: «Se sapessi una cosa utile alla mia nazione ma che fosse dannosa per un'altra, non la proporrei al mio principe, poiché sono un uomo prima di essere un francese o, meglio, perché io sono necessariamente un uomo, mentre sono francese solo per combinazione». Lo Stato nazionale, ricorda Vargas Llosa, è una istituzione recente nella storia umana, e non è detto che abbia arrestato le lancette dell'innovazione politica. Un esempio. La doppia cittadinanza era “un concetto assurdo” ai tempi di Teddy Roosevelt, adesso è una realtà piuttosto comune. Le identità sono più porose di quanto si pensi. Oggi l'immigrazione internazionale pesa per il 3% della popolazione mondiale. Curiosamente, nell'Ue, che pure considera la libertà di movimento uno dei suoi pilastri, solo un europeo su dieci è nato da genitori stranieri. Quanti vorrebbero chiudere le frontiere hanno argomenti di diverso tipo. La questione islamica guarda in realtà una percentuale assai modesta dei migranti. Più che altro, i “chiusisti” giocano su un vecchio equivoco: l'idea che la ricchezza sia una torta da fare a fette, e così l'occupazione. “Il lavoro agli italiani”, perché ogni nuova bocca da sfamare sottrae pane a un lavoratore autoctono.
 Costoro non comprendono che «il mercato del lavoro è una creatura flessibile, malleabile, in continuo cambiamento, i cui limiti, rispetto al numero di posti di lavoro disponibile, nessuno può stabilire a priori». Inoltre, e forse soprattutto, non considerano un fatto ovvio: al pari di tutti gli altri, gli immigrati sono assieme produttori e consumatori e influenzano l'andamento dell'economia nell'uno e nell'altro ruolo.
Costoro non comprendono che «il mercato del lavoro è una creatura flessibile, malleabile, in continuo cambiamento, i cui limiti, rispetto al numero di posti di lavoro disponibile, nessuno può stabilire a priori». Inoltre, e forse soprattutto, non considerano un fatto ovvio: al pari di tutti gli altri, gli immigrati sono assieme produttori e consumatori e influenzano l'andamento dell'economia nell'uno e nell'altro ruolo.
Provoca Vargas Llosa: «Se ulteriori incrementi della forza lavoro avessero un effetto negativo, come mai tra il 1950 e oggi (un periodo in cui la forza lavoro negli Stati Uniti è cresciuta da 6o a 150 milioni grazie alla massiccia entrata delle donne e dei baby boomers nell'economia) non si è registrato alcun aumento di lungo periodo nel tasso di disoccupazione?».
Si dirà che gli immigrati tendono a competere per lavori a bassa specializzazione, andando pertanto a danneggiare una categoria di lavoratori fra i più deboli. Di nuovo si postula che “consumatori” e “produttori” siano figure diverse, inconciliabili, probabilmente in conflitto. Ma la realtà economica non copia un modello statico, nuove persone corrispondono a nuovi bisogni e nuovi desideri, e nuovi bisogni e nuovi desideri alla possibilità di arricchirsi provando a soddisfarli. La libertà di migrare è uno strumento con il quale si dà risposta a quegli “squilibri” che caratterizzano la vita economica, perché caratterizzano la vita umana: avvicina chi offre lavoro a chi è in condizione di acquistarlo.














 Nel vasto campo delle migrazioni la materna sollecitudine della Chiesa si esplica su varie direttrici.
Nel vasto campo delle migrazioni la materna sollecitudine della Chiesa si esplica su varie direttrici.

 Dottor Pittau, è stato presentato pochi giorni fa il Dossier Statistico sull’Immigrazione a cura di Caritas e Migrantes dal titolo “Non solo numeri”: sono 5 milioni gli immigrati regolari in Italia. Tralasciando per un momento il discorso dell’integrazione, del rispetto delle altre culture ecc., vogliamo spiegare perché questo Paese ha così bisogno di cittadini immigrati, soprattutto a supporto del sistema economico-produttivo?
Dottor Pittau, è stato presentato pochi giorni fa il Dossier Statistico sull’Immigrazione a cura di Caritas e Migrantes dal titolo “Non solo numeri”: sono 5 milioni gli immigrati regolari in Italia. Tralasciando per un momento il discorso dell’integrazione, del rispetto delle altre culture ecc., vogliamo spiegare perché questo Paese ha così bisogno di cittadini immigrati, soprattutto a supporto del sistema economico-produttivo? Quando definiamo il nostro atteggiamento nei confronti delle differenze etniche, noi europei tendiamo a fare nostra una di due note tesi. Qualcuno sposa la teoria del “contatto”, la quale sostiene che la convivenza di diverse comunità porta a un vicendevole arricchimento, in quanto favorisce la comprensione reciproca che alla fine produce una maggiore armonia tra i vari gruppi. Altri si schierano a favore della teoria del “conflitto”, che afferma l’esatto contrario.
Quando definiamo il nostro atteggiamento nei confronti delle differenze etniche, noi europei tendiamo a fare nostra una di due note tesi. Qualcuno sposa la teoria del “contatto”, la quale sostiene che la convivenza di diverse comunità porta a un vicendevole arricchimento, in quanto favorisce la comprensione reciproca che alla fine produce una maggiore armonia tra i vari gruppi. Altri si schierano a favore della teoria del “conflitto”, che afferma l’esatto contrario. Costoro non comprendono che «il mercato del lavoro è una creatura flessibile, malleabile, in continuo cambiamento, i cui limiti, rispetto al numero di posti di lavoro disponibile, nessuno può stabilire a priori». Inoltre, e forse soprattutto, non considerano un fatto ovvio: al pari di tutti gli altri, gli immigrati sono assieme produttori e consumatori e influenzano l'andamento dell'economia nell'uno e nell'altro ruolo.
Costoro non comprendono che «il mercato del lavoro è una creatura flessibile, malleabile, in continuo cambiamento, i cui limiti, rispetto al numero di posti di lavoro disponibile, nessuno può stabilire a priori». Inoltre, e forse soprattutto, non considerano un fatto ovvio: al pari di tutti gli altri, gli immigrati sono assieme produttori e consumatori e influenzano l'andamento dell'economia nell'uno e nell'altro ruolo. L’unico criterio su cui è possibile fondare una politica razionale dell’immigrazione, per quanto arido o “meschino” possa apparire a coloro che non apprezzano l’etica della responsabilità, è dunque quello della convenienza, della nostra convenienza. Una volta adottato con franchezza ci consente di porci il problema ̶ che altri Stati si sono già posti ̶ di come selezionare gli immigrati. È evidente che se usiamo il criterio dell’accoglienza non possiamo selezionare. Invece, possiamo, e dobbiamo, farlo alla luce delle convenienze. Di quali immigrati abbiamo bisogno? Con quali caratteristiche, con quali eventuali competenze? Oggi il problema forse non si pone data l’elevata disoccupazione intellettuale giovanile (che resta grave, anche facendo la tara alle statistiche ufficiali che, fraudolentemente, imbarcano fra i disoccupati anche gli studenti).
L’unico criterio su cui è possibile fondare una politica razionale dell’immigrazione, per quanto arido o “meschino” possa apparire a coloro che non apprezzano l’etica della responsabilità, è dunque quello della convenienza, della nostra convenienza. Una volta adottato con franchezza ci consente di porci il problema ̶ che altri Stati si sono già posti ̶ di come selezionare gli immigrati. È evidente che se usiamo il criterio dell’accoglienza non possiamo selezionare. Invece, possiamo, e dobbiamo, farlo alla luce delle convenienze. Di quali immigrati abbiamo bisogno? Con quali caratteristiche, con quali eventuali competenze? Oggi il problema forse non si pone data l’elevata disoccupazione intellettuale giovanile (che resta grave, anche facendo la tara alle statistiche ufficiali che, fraudolentemente, imbarcano fra i disoccupati anche gli studenti). Lo sapevamo che sarebbe successo, l’integrazione è stata una ideologia semi religiosa, ma non ha funzionato. I multiculturalisti hanno sempre negato la connotazione identitaria, perché avrebbe frammentato il multiculturalismo. Coloro che hanno difeso la prima persona plurale della nazione sono stati attaccati in quanto “fascisti”, “razzisti”, “xenofobi”, “nostalgici” o, nel migliore dei casi, “provinciali”. Lo avevamo già visto anche in Francia con il dominio delle gang nelle banlieue. Nelle nostre città i giovani crescono in ghetti isolati, in un ordine politico schizzato, vogliono affermarsi contro la società, mai per essa. In Italia non è ancora successo, ma potrebbe accadere se non avverrà una integrazione corretta. L’islamismo tende a infiammare questo scontro per costruire una retorica anti occidentale, ma in questo caso è stato soprattutto un fallimento interno alla nostra società. Provo orrore e tristezza per come abbiamo distrutto il vecchio curriculum, dicevano che era monoculturale, che perpetuava l’idea della civiltà occidentale come superiore, che era patriarcale, il prodotto del maschio bianco europeo che aveva perso autorità. Ci avevano insegnato a vivere in un ambiente amorfo, nella città postmoderna aperta a tutte le culture. Ogni cultura avrebbe dovuto crescere nel proprio spazio, per godere dei frutti della cooperazione sociale e di un sistema educativo in cui la cultura maggioritaria avrebbe dovuto essere marginalizzata. Tutto quello che invece il multiculturalismo ha sancito è stata la distruzione della cultura pubblica condivisa e il diritto al rispetto, creando un grande vuoto. Il risultato è stato il relativismo. La civiltà occidentale è sottoposta a una pressione tale per cui o ne esce vincendo, rinnovandosi, o soccombe.
Lo sapevamo che sarebbe successo, l’integrazione è stata una ideologia semi religiosa, ma non ha funzionato. I multiculturalisti hanno sempre negato la connotazione identitaria, perché avrebbe frammentato il multiculturalismo. Coloro che hanno difeso la prima persona plurale della nazione sono stati attaccati in quanto “fascisti”, “razzisti”, “xenofobi”, “nostalgici” o, nel migliore dei casi, “provinciali”. Lo avevamo già visto anche in Francia con il dominio delle gang nelle banlieue. Nelle nostre città i giovani crescono in ghetti isolati, in un ordine politico schizzato, vogliono affermarsi contro la società, mai per essa. In Italia non è ancora successo, ma potrebbe accadere se non avverrà una integrazione corretta. L’islamismo tende a infiammare questo scontro per costruire una retorica anti occidentale, ma in questo caso è stato soprattutto un fallimento interno alla nostra società. Provo orrore e tristezza per come abbiamo distrutto il vecchio curriculum, dicevano che era monoculturale, che perpetuava l’idea della civiltà occidentale come superiore, che era patriarcale, il prodotto del maschio bianco europeo che aveva perso autorità. Ci avevano insegnato a vivere in un ambiente amorfo, nella città postmoderna aperta a tutte le culture. Ogni cultura avrebbe dovuto crescere nel proprio spazio, per godere dei frutti della cooperazione sociale e di un sistema educativo in cui la cultura maggioritaria avrebbe dovuto essere marginalizzata. Tutto quello che invece il multiculturalismo ha sancito è stata la distruzione della cultura pubblica condivisa e il diritto al rispetto, creando un grande vuoto. Il risultato è stato il relativismo. La civiltà occidentale è sottoposta a una pressione tale per cui o ne esce vincendo, rinnovandosi, o soccombe. L’islamismo, per esempio, è il suo peggiore nemico attuale. Prendiamo l’immigrazione indiscriminata, che vive di molte facili retoriche e di troppe politiche dello struzzo. Ora, l’immigrazione è un dato di fatto, e come tale va accettata; ma perché non cominciamo a chiederci come mai la maggior parte degli extracomunitari sono musulmani che vengono a noi fuggendo da Paesi islamici? Sicuramente perché a casa loro si sta malissimo. E questo è un primo punto, un punto che bisogna cominciare a tenere assolutamente presente nelle relazioni internazionali. In secondo luogo, bisogna – di nuovo – fare i conti soprattutto con la realtà. L’Europa non può accogliere tutto e tutti, e questo per motivi direi fisici. Rischia di scoppiare. Occorre quindi regolare oculatamente i flussi migratori verso di noi, stabilendo criteri di accoglienza anche culturali certi. Insomma, non è possibile accogliere da noi che ci ritiene poco più che spazzatura e chi già cova in animo proprio la sedizione e la disobbedienza alle regole della nostra civiltà. Solo che tutto questo è tabù, non si può dire…
L’islamismo, per esempio, è il suo peggiore nemico attuale. Prendiamo l’immigrazione indiscriminata, che vive di molte facili retoriche e di troppe politiche dello struzzo. Ora, l’immigrazione è un dato di fatto, e come tale va accettata; ma perché non cominciamo a chiederci come mai la maggior parte degli extracomunitari sono musulmani che vengono a noi fuggendo da Paesi islamici? Sicuramente perché a casa loro si sta malissimo. E questo è un primo punto, un punto che bisogna cominciare a tenere assolutamente presente nelle relazioni internazionali. In secondo luogo, bisogna – di nuovo – fare i conti soprattutto con la realtà. L’Europa non può accogliere tutto e tutti, e questo per motivi direi fisici. Rischia di scoppiare. Occorre quindi regolare oculatamente i flussi migratori verso di noi, stabilendo criteri di accoglienza anche culturali certi. Insomma, non è possibile accogliere da noi che ci ritiene poco più che spazzatura e chi già cova in animo proprio la sedizione e la disobbedienza alle regole della nostra civiltà. Solo che tutto questo è tabù, non si può dire… «Non c’è alcuna differenza tra Islam ed Islamismo»; «l’Islam non ha alcuna possibilità di modernizzarsi»; «l’Islam è una ideologia che promuove la violenza così come in passato il Fascismo ed il Comunismo» – queste sono alcune delle espressioni di Geert Wilders, il politico che forse più di ogni altro si sta impegnando per fronteggiare ed ostacolare l’avanzamento dell’Islam in Occidente. Il leader olandese ha in mente, come ha detto a Berlino a fine settembre, un’Alleanza per la Libertà, della quale dovrebbero far parte la Germania, gli Usa, la Gran Bretagna, il Canada e la Francia e naturalmente l’Olanda. I toni usati sono forti («L’Islam è una malattia»; «L’Islam è dominato da fanatici») e le sue tesi radicali («Rifiuto dell’immigrazione dai Paesi abitati a maggioranza da musulmani»), ma Wilders si considera (forse anche sopravvalutandosi) il salvatore dell’Occidente. Ha però individuato il problema, vuole affrontarlo di petto e cerca di farsi interprete delle esigenze dei cittadini: o dobbiamo continuare a mentirci per altri decenni ed in venti o trent’anni anni affronteremo sempre lo stesso dibattito perché noi oggi abbiamo rifiutato di risolverlo?
«Non c’è alcuna differenza tra Islam ed Islamismo»; «l’Islam non ha alcuna possibilità di modernizzarsi»; «l’Islam è una ideologia che promuove la violenza così come in passato il Fascismo ed il Comunismo» – queste sono alcune delle espressioni di Geert Wilders, il politico che forse più di ogni altro si sta impegnando per fronteggiare ed ostacolare l’avanzamento dell’Islam in Occidente. Il leader olandese ha in mente, come ha detto a Berlino a fine settembre, un’Alleanza per la Libertà, della quale dovrebbero far parte la Germania, gli Usa, la Gran Bretagna, il Canada e la Francia e naturalmente l’Olanda. I toni usati sono forti («L’Islam è una malattia»; «L’Islam è dominato da fanatici») e le sue tesi radicali («Rifiuto dell’immigrazione dai Paesi abitati a maggioranza da musulmani»), ma Wilders si considera (forse anche sopravvalutandosi) il salvatore dell’Occidente. Ha però individuato il problema, vuole affrontarlo di petto e cerca di farsi interprete delle esigenze dei cittadini: o dobbiamo continuare a mentirci per altri decenni ed in venti o trent’anni anni affronteremo sempre lo stesso dibattito perché noi oggi abbiamo rifiutato di risolverlo? Ragionare e ripensare il rapporto tra identità, integrazione ed immigrazione è diventato, come è evidente, estremamente difficile. Gli attacchi terroristici, le guerre in Medio Oriente, il crescente aumento dell’influenza della religione islamica in Occidente, il nuovo equilibrio tra stati nazionali e grandi istituzioni sovranazionali, tutto questo ha reso ancor più complesso l’approccio a questo tema. Molto spesso si oscilla tra il multiculturalismo ed il nazionalismo (e/o localismo), tra l’apertura indiscriminata delle frontiere e la chiusura ad oltranza, ed inoltre le élite culturali e politiche di gran parte dei Paesi occidentali non hanno alcuna idea veramente convincente per considerare la migrazione come parte costante della società occidentale, manca una visione nella quale l’integrazione europea funzioni come riparo delle democrazie nazionali. Da una parte c’è, dunque, un’enorme richiesta di nuove misure di contrasto all’immigrazione, dall’altra, la politica ha spesso difficoltà a trattare in modo organico, senza ideologismi ed in maniera neutra un tema, che negli ultimi mesi è diventato di grande attualità in tutto il mondo Occidentale.
Ragionare e ripensare il rapporto tra identità, integrazione ed immigrazione è diventato, come è evidente, estremamente difficile. Gli attacchi terroristici, le guerre in Medio Oriente, il crescente aumento dell’influenza della religione islamica in Occidente, il nuovo equilibrio tra stati nazionali e grandi istituzioni sovranazionali, tutto questo ha reso ancor più complesso l’approccio a questo tema. Molto spesso si oscilla tra il multiculturalismo ed il nazionalismo (e/o localismo), tra l’apertura indiscriminata delle frontiere e la chiusura ad oltranza, ed inoltre le élite culturali e politiche di gran parte dei Paesi occidentali non hanno alcuna idea veramente convincente per considerare la migrazione come parte costante della società occidentale, manca una visione nella quale l’integrazione europea funzioni come riparo delle democrazie nazionali. Da una parte c’è, dunque, un’enorme richiesta di nuove misure di contrasto all’immigrazione, dall’altra, la politica ha spesso difficoltà a trattare in modo organico, senza ideologismi ed in maniera neutra un tema, che negli ultimi mesi è diventato di grande attualità in tutto il mondo Occidentale.