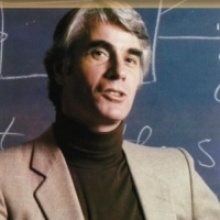Welfare State è ormai diventata un’espressione sconveniente.
Da qualche tempo impera una sorta di tirannia degli stereotipi del neoliberismo, impostasi sia sul piano teorico sia su quello empirico. Va di moda predicare la destatalizzazione, il trionfo di un ordinamento privatistico su scala globale, l’integrazione pre-politica e pre-statale della società mondiale affidata all’automatico coordinamento del mercato, l’isolamento e la spoliticizzazione dei cittadini, che renderebbero superflua la creazione della cittadinanza e dell’identità civica.
 Nonostante i ripetuti fenomeni di crisi (specie finanziaria) che attraversano le nostre economie e le nostre società, il neoliberismo non si mostra per niente in disarmo; l’ultima tendenza, che nella versione nostrana ha conosciuto recenti successi editoriali, sta nella sua aggressiva riproposizione “populista”, volta a criticare gli eccessi del “mercatismo”, e a rilanciare strategie – o tattiche? – di autodifesa protezionistica.
Nonostante i ripetuti fenomeni di crisi (specie finanziaria) che attraversano le nostre economie e le nostre società, il neoliberismo non si mostra per niente in disarmo; l’ultima tendenza, che nella versione nostrana ha conosciuto recenti successi editoriali, sta nella sua aggressiva riproposizione “populista”, volta a criticare gli eccessi del “mercatismo”, e a rilanciare strategie – o tattiche? – di autodifesa protezionistica.
È necessario affrontare in modo ragionato questi influenti luoghi comuni, troppo spesso subiti acriticamente, e discuterli con rigore e competenza, senza rinunciare a quella vis polemica che sembra ormai smarrita. Ne scaturisce la necessità di difendere con convinzione non solo l’efficacia, ma anche la moralità delle politiche di redistribuzione, cui lo Stato non può rinunciare se vuole ancora perseguire il suo conclamato presupposto di equità.
È in gioco la democrazia stessa, al cui fondamento vi è un’idea di libertà intesa non come mero attributo individuale, ma come impegno sociale e tensione egualitaria.
Laura Puppato, Rafforzare gli strumenti del welfare
Una tendenza crescente, che si autolegittima anche in nome della crisi, vede nei servizi dovuti al cittadino l’ultima frontiera da cui spremere altri soldi ai contribuenti. I servizi perdono così la connotazione di strumenti con cui attuare principi e diritti sanciti dalla Costituzione e diventano merce. La strategia volta a privatizzare il cosiddetto welfare quale strumento per “uscire dalla crisi”, va respinta in quanto destinata a creare i presupposti per una crisi ancora peggiore.
Gli strumenti del welfare vanno invece consolidati e implementati per creare condizioni di piena cittadinanza a sostegno delle famiglie e delle loro parti più deboli.
Tra i Paesi europei l’Italia è al penultimo posto quanto a spesa per la famiglia, alla quale viene devoluto solo il 4,7% della spesa sociale (circa la metà di quanto avviene nel resto d’Europa). È necessario recuperare la soluzione proposta dal “forum delle famiglie” in Italia, considerando il costo economico di ogni nuovo nato in ogni famiglia e moltiplicandolo per il numero dei familiari a carico: la cifra così determinata andrà ad essere esente da imposte fino al raggiungimento del reddito lordo del soggetto titolare di reddito. Questa misura comporterebbe da subito incrementi di reddito variabili tra i 200 e gli oltre 1000 €/mese a famiglia.
 La società di oggi è dinamica, si auto-organizza e il settore no profit risponde frequentemente alle domande che lo Stato lascia inevase, sostenendo una parte non solo sussidiaria del welfare. Questa società intelligente, che spinge le persone a mettersi insieme per dare risposte sociali, va valorizzata e queste risposte vanno verificate e sostenute. È giusto che chi opera in modo da essere utile alla società venga favorito da particolari sgravi fiscali: non solo lo Stato deve erogare e sostenere progetti, ma anche riconoscere il lavoro sociale e premiare fiscalmente quello che viene prodotto. Appare anche utile prendere in considerazione delle forme di credito scolastico che riconoscano agli studenti impegnati nel volontariato il valore formativo di queste esperienze di condivisione sociale.
La società di oggi è dinamica, si auto-organizza e il settore no profit risponde frequentemente alle domande che lo Stato lascia inevase, sostenendo una parte non solo sussidiaria del welfare. Questa società intelligente, che spinge le persone a mettersi insieme per dare risposte sociali, va valorizzata e queste risposte vanno verificate e sostenute. È giusto che chi opera in modo da essere utile alla società venga favorito da particolari sgravi fiscali: non solo lo Stato deve erogare e sostenere progetti, ma anche riconoscere il lavoro sociale e premiare fiscalmente quello che viene prodotto. Appare anche utile prendere in considerazione delle forme di credito scolastico che riconoscano agli studenti impegnati nel volontariato il valore formativo di queste esperienze di condivisione sociale.
La gente vive sempre più a lungo e la longevità implica problemi non marginali di assistenza e cura. Come i bambini sono affidati a personale appositamente preparato, altrettanto deve avvenire per gli anziani, perché non è pensabile di lasciarli alla buona volontà delle badanti, persone rispettabilissime ma il più delle volte prive dei requisiti necessari. L’assistente per l’anziano (nelle strutture pubbliche e private o a domicilio) e per il disabile di tutte le età deve avere un titolo di studio a livello universitario o una preparazione specifica e la sua professione va remunerata di conseguenza. Il bacino di domanda sarebbe sicuramente cospicuo e le opportunità di lavoro assai rilevanti e non più sottovalutate o sottopagate. L’assistenza a domicilio, che è più a misura d’uomo e meno onerosa, deve essere avvantaggiata rispetto a quella effettuata nelle strutture pubbliche.
Paul Krugman, Insegnanti e welfare contro la depressione economica
 Il messaggio che Paul Krugman sottolinea con insistenza nel suo libro Fuori da questa crisi, adesso è che il male va combattuto, oggi come allora, con un deciso intervento statale. «Abbiamo bisogno che i nostri governi spendano di più, non di meno – sintetizza il cinquantanovenne docente alla Princeton University – perché quando la domanda privata è insufficiente, questa è l'unica soluzione. Assumere insegnanti. Costruire infrastrutture. Fare quello che fu fatto con la Seconda Guerra Mondiale, possibilmente scegliendo spese utili».
Il messaggio che Paul Krugman sottolinea con insistenza nel suo libro Fuori da questa crisi, adesso è che il male va combattuto, oggi come allora, con un deciso intervento statale. «Abbiamo bisogno che i nostri governi spendano di più, non di meno – sintetizza il cinquantanovenne docente alla Princeton University – perché quando la domanda privata è insufficiente, questa è l'unica soluzione. Assumere insegnanti. Costruire infrastrutture. Fare quello che fu fatto con la Seconda Guerra Mondiale, possibilmente scegliendo spese utili».
Quell'avverbio “adesso” che tuona nel titolo del suo libro, Krugman lo esplicita senza esitazioni: se l'Occidente applicasse la ricetta giusta, potremmo essere fuori da questa crisi in 18 mesi. Un anno e mezzo! Attenzione: questa non è una promessa da comizio elettorale. Il bello di Krugman, quello che ti affascina nel personaggio, è l'impegno con cui tiene insieme il suo “ruolo pubblico”, di opinionista schierato e aggressivo, con il rigore scientifico del teorico che macina grafici e statistiche come un computer. Capace di passare dall'uno all'altro in pochi istanti, per rispondere all'obiezione politica principale: la sua ricetta oggi appare inascoltata, inapplicabile, impraticabile, perché siamo terrorizzati dal livello del debito pubblico.
Non è solo un problema europeo. Anche qui negli Stati Uniti 15 300 miliardi di dollari di debiti, quasi il 100% del Pil, sembrano un ostacolo insormontabile per la sua terapia keynesiana. «Falso, falso – risponde secco – anzitutto dal punto di vista storico. In passato gli Stati Uniti ebbero un debito ancora superiore, durante le Seconda Guerra Mondiale; la Gran Bretagna per quasi un secolo. Il Giappone ha tuttora un debito statale molto più elevato in percentuale del suo Pil eppure paga interessi dello 0,9% sui suoi buoni del Tesoro. Quindi non esistono soglie di insostenibilità come quelle che ci vengono propagandate. Inoltre è dimostrato, e lo vediamo accadere sotto i nostri occhi, che in tempi di depressione le politiche di austerity aggravano il problema: accentuano la recessione, di conseguenza cade il gettito fiscale, così in seguito ai tagli il debito aumenta anziché diminuire».
Resta però il problema politico, e non solo in Europa, dove c'è un ostacolo che si chiama Angela Merkel. Anche qui, Barack Obama non ha osato sfidare i repubblicani con una seconda manovra di spesa pubblica anti-crisi. «Anzitutto perché all'inizio Obama sottovalutò la gravità di questa crisi – risponde Krugman – mentre adesso sta cambiando posizione. Il fatto è che a lui conviene battersi fino in fondo per le sue idee, tenere duro, non cercare compromessi. Se Obama vince a novembre, io credo che governerà meglio nel suo secondo mandato».
Un'altra obiezione frequente alla sua ricetta keynesiana, riguarda la qualità, l'efficacia, la rapidità della spesa pubblica. La macchina burocratica è spesso inefficiente, non solo nell'Europa mediterranea ma anche qui negli Stati Uniti. Krugman ha una risposta anche a questo. «La prima cosa da fare – spiega – è cancellare l'effetto distruttivo dei tagli di spesa. Per esempio, qui negli Stati Uniti, bisogna cominciare col ri-assumere le migliaia di insegnanti licenziati a livello locale. Queste sono manovre di spesa dagli effetti istantanei. In Europa, la manovra equivalente è restituire le prestazioni del Welfare State che sono state ingiustamente tagliate».
Veniamo dunque al malato più grave del momento: i Paesi dell'euro. A questo paziente in coma, Krugman sta dedicando un'attenzione smisurata. Spesso i suoi editoriali sul “New York Times” sono duri attacchi all'austerity d'impronta germanica, appelli ai dirigenti europei perché rinsaviscano prima che sia troppo tardi. «Guardate cos'è accaduto all'Irlanda – dice –cioè a un Paese che si può considerare l'allievo modello, il più virtuoso nell'applicare le ricette dell'austerity volute dal governo tedesco. L'Irlanda ha avuto una finta ripresa e poi è ricaduta nella recessione. All'estremo opposto ci sono quei Paesi asiatici, dalla Cina alla Corea del Sud, che hanno manovrato con energia le leve della spesa pubblica, e così hanno evitato la crisi».
Krugman considera probabile l'uscita della Grecia dall'euro, ma lo preoccupa di più il “dopo”. Denuncia il rischio di un «effetto-domino, se la Germania non cambia strada». Avverte che le conseguenze di una disintegrazione dell'Unione «sarebbero perfino più gravi sul piano politico che su quello economico». I suoi modelli, oltre ai Paesi asiatici, sono la Svezia e perfino la piccola Islanda: «Perché dopo la bancarotta ha avuto il coraggio di cancellare tutti i propri debiti con le banche, negare i rimborsi ed è ripartita dopo una svalutazione massiccia».















 Sussidiarietà significa che «tutte le società di ordine superiore devono porsi in atteggiamento di aiuto […], quindi di sostegno, promozione e sviluppo rispetto alle minori» [Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, 186]. Sussidiarietà significa corrispondentemente che il bene comune della nostra città è raggiunto solo se sui contenuti essenziali del medesimo bene c'è l'accordo e la condivisione delle municipalità, delle imprese e della società civile organizzata nel cosiddetto
Sussidiarietà significa che «tutte le società di ordine superiore devono porsi in atteggiamento di aiuto […], quindi di sostegno, promozione e sviluppo rispetto alle minori» [Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, 186]. Sussidiarietà significa corrispondentemente che il bene comune della nostra città è raggiunto solo se sui contenuti essenziali del medesimo bene c'è l'accordo e la condivisione delle municipalità, delle imprese e della società civile organizzata nel cosiddetto 


 Le origini del servizio sociale ebraico risalgono ai primi stanziamenti degli emigranti ebrei negli Stati Uniti. A seguito di ciò, gli stessi ebrei crearono degli uffici di assistenza con il compito di accogliere i nuovi giunti e di provvedere loro le prime necessità della vita. Lentamente i servizi aumentarono sino a prevedere ampi programmi di assistenza da parte anche del governo a partire dal 1929.
Le origini del servizio sociale ebraico risalgono ai primi stanziamenti degli emigranti ebrei negli Stati Uniti. A seguito di ciò, gli stessi ebrei crearono degli uffici di assistenza con il compito di accogliere i nuovi giunti e di provvedere loro le prime necessità della vita. Lentamente i servizi aumentarono sino a prevedere ampi programmi di assistenza da parte anche del governo a partire dal 1929. Nonostante i ripetuti fenomeni di crisi (specie finanziaria) che attraversano le nostre economie e le nostre società, il neoliberismo non si mostra per niente in disarmo; l’ultima tendenza, che nella versione nostrana ha conosciuto recenti successi editoriali, sta nella sua aggressiva riproposizione “populista”, volta a criticare gli eccessi del “mercatismo”, e a rilanciare strategie – o tattiche? – di autodifesa protezionistica.
Nonostante i ripetuti fenomeni di crisi (specie finanziaria) che attraversano le nostre economie e le nostre società, il neoliberismo non si mostra per niente in disarmo; l’ultima tendenza, che nella versione nostrana ha conosciuto recenti successi editoriali, sta nella sua aggressiva riproposizione “populista”, volta a criticare gli eccessi del “mercatismo”, e a rilanciare strategie – o tattiche? – di autodifesa protezionistica. La società di oggi è dinamica, si auto-organizza e il settore no profit risponde frequentemente alle domande che lo Stato lascia inevase, sostenendo una parte non solo sussidiaria del welfare. Questa società intelligente, che spinge le persone a mettersi insieme per dare risposte sociali, va valorizzata e queste risposte vanno verificate e sostenute. È giusto che chi opera in modo da essere utile alla società venga favorito da particolari sgravi fiscali: non solo lo Stato deve erogare e sostenere progetti, ma anche riconoscere il lavoro sociale e premiare fiscalmente quello che viene prodotto. Appare anche utile prendere in considerazione delle forme di credito scolastico che riconoscano agli studenti impegnati nel volontariato il valore formativo di queste esperienze di condivisione sociale.
La società di oggi è dinamica, si auto-organizza e il settore no profit risponde frequentemente alle domande che lo Stato lascia inevase, sostenendo una parte non solo sussidiaria del welfare. Questa società intelligente, che spinge le persone a mettersi insieme per dare risposte sociali, va valorizzata e queste risposte vanno verificate e sostenute. È giusto che chi opera in modo da essere utile alla società venga favorito da particolari sgravi fiscali: non solo lo Stato deve erogare e sostenere progetti, ma anche riconoscere il lavoro sociale e premiare fiscalmente quello che viene prodotto. Appare anche utile prendere in considerazione delle forme di credito scolastico che riconoscano agli studenti impegnati nel volontariato il valore formativo di queste esperienze di condivisione sociale. Il messaggio che Paul Krugman sottolinea con insistenza nel suo libro Fuori da questa crisi, adesso è che il male va combattuto, oggi come allora, con un deciso intervento statale. «Abbiamo bisogno che i nostri governi spendano di più, non di meno – sintetizza il cinquantanovenne docente alla Princeton University – perché quando la domanda privata è insufficiente, questa è l'unica soluzione. Assumere insegnanti. Costruire infrastrutture. Fare quello che fu fatto con la Seconda Guerra Mondiale, possibilmente scegliendo spese utili».
Il messaggio che Paul Krugman sottolinea con insistenza nel suo libro Fuori da questa crisi, adesso è che il male va combattuto, oggi come allora, con un deciso intervento statale. «Abbiamo bisogno che i nostri governi spendano di più, non di meno – sintetizza il cinquantanovenne docente alla Princeton University – perché quando la domanda privata è insufficiente, questa è l'unica soluzione. Assumere insegnanti. Costruire infrastrutture. Fare quello che fu fatto con la Seconda Guerra Mondiale, possibilmente scegliendo spese utili».
 Bisognerebbe riscrivere la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del dicembre 1948: lì troviamo sanciti – accanto alla triade liberale vita-libertà-proprietà, anche i cosiddetti diritti di welfare, vale a dire a prestazioni da parte di altri uomini, garantite dallo Stato.
Bisognerebbe riscrivere la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del dicembre 1948: lì troviamo sanciti – accanto alla triade liberale vita-libertà-proprietà, anche i cosiddetti diritti di welfare, vale a dire a prestazioni da parte di altri uomini, garantite dallo Stato.