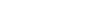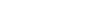Natività
Lorenzo Lotto (1480-1556)
Natività, 1523, olio su tavola
Washington, National Gallery of Art

 Federico Barocci
Federico Barocci
Il fatto
Con Natività si intende la nascita di Gesù dalla Vergine Maria assistita da san Giuseppe. Avvenne a Betlemme, un paese loco lontano da Gerusalemme, in un luogo (grotta, o capanna) presumibilmente adibito a stalla (Luca, nel suo Vangelo, cita esplicitamente «una mangiatoia»). Secondo un’antica tradizione, basata sul vangelo apocrifo detto dello pseudo-Matteo, un bue e un asinello provvidero al riscaldamento del neonato. La data della Natività è convenzionalmente fissata al 25 dicembre, esattamente nove mesi dopo che l’arcangelo Gabriele ebbe annunciato a Maria il concepimento di un bambino a opera dello Spirito Santo.
La parola
Dal Vangelo di Luca (2,1-7):
«In quei giorni uscì un editto di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirino era governatore della Siria. Tutti andavano a dare il loro nome, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì nella Giudea, alla città di Davide, che si chiamava Betlemme, perché egli era della casa e della famiglia di Davide, per dare il suo nome con Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano là, giunse per lei il tempo di partorire e diede alla luce il suo figlio primogenito. Lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto all’albergo.»
Approfondimento
Simone Martini (attribuito a),
Dittico, terzo decennio XIV secolo, tempera su tavola,
Firenze, Museo Horne.
Con la Madonna col Bambino a sinistra e Cristo come “Uomo dei dolori”, tipologia devozionale assai diffusa che raffigura Gesù morto in posizione eretta, visibile dalla vita in su fuori dal sepolcro, con gli occhi chiusi e le braccia incrociate sul ventre, il Dittico del XIV secolo sposa in un’unica immagine i due estremi dell’esistenza terrena di Gesù, proprio come la Natività di Lorenzo Lotto che abbiamo esaminato. A proposito della compresenza, sinora considerata a livello iconografico, della nascita e della morte di Gesù, ricordiamo che questa è presente anche in ambito letterario. Per esempio, esiste una versione dello Stabat Mater (letteralmente, «Stava la madre», inno sulle sofferenze di Maria durante la Passione attribuito a Jacopone da Todi, sec. XIII) che i fedeli cantavano a Natale anziché nella Settimana Santa allo scopo di esaltare la gioia per la nascita di Gesù e al tempo stesso il dolore per la sua morte. Lo Stabat Mater di Pasqua iniziava con le parole «La Madre addolorata stava / in lacrime presso la Croce / su cui pendeva il Figlio», mentre quello di Natale iniziava così: «La madre, splendida, stava / presso la paglia, piena di gioia / ove il piccolo giaceva».