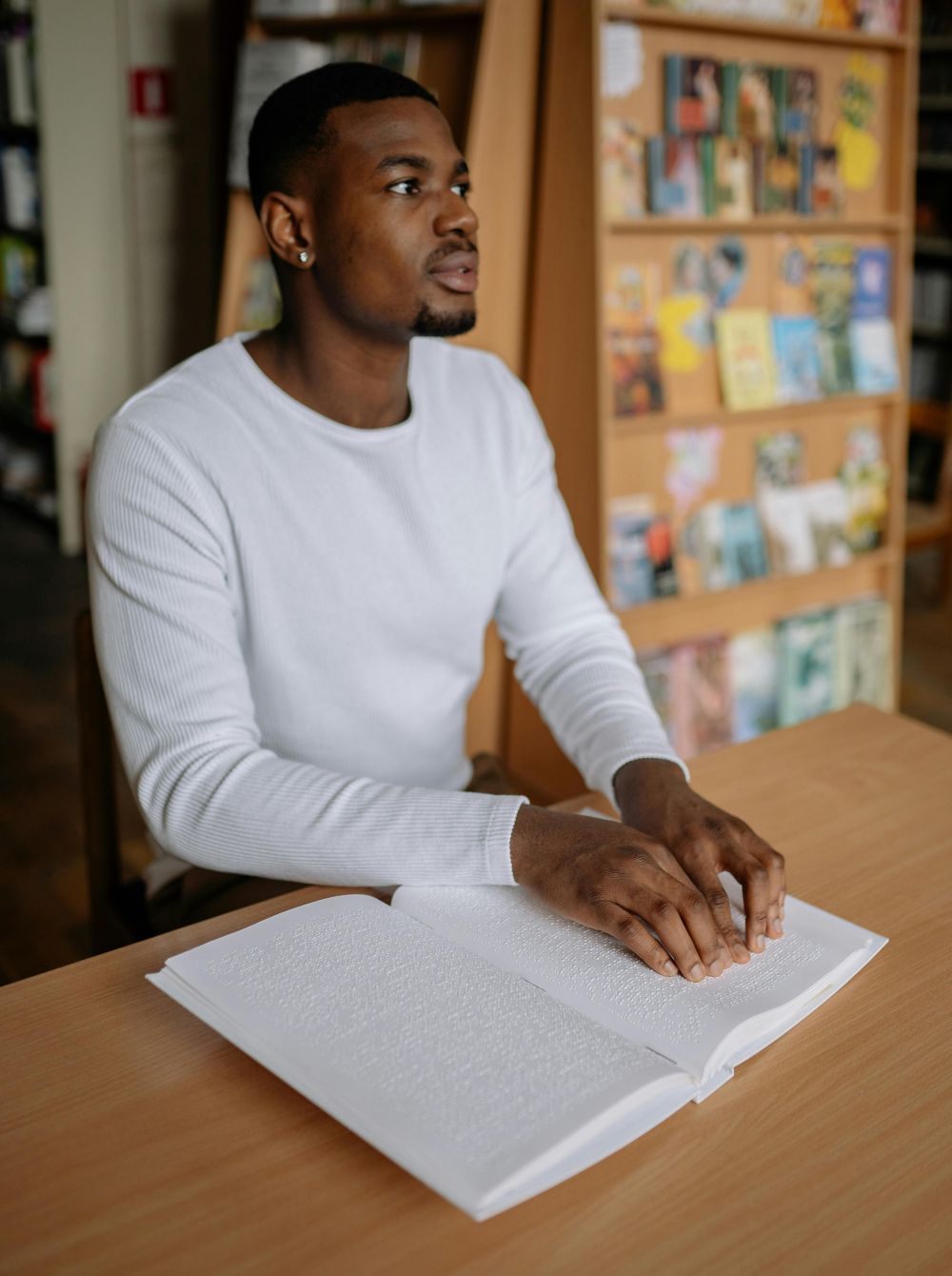
Fragile è la condizione umana, segnata dalla debolezza, dalla sofferenza, dall’esposizione alla malattia, dalla finitudine.
La nostra cultura spesso mostra scarsa tolleranza verso la sofferenza: tendiamo a minimizzare il dolore altrui, soprattutto quello di chi convive con disabilità “invisibili”
o disturbi psichici, e siamo renitenti a offrire a queste persone vicinanza e compassione, preferendo piuttosto che questa fragilità venga nascosta.
Non è facile, in un contesto sociale dominato dall’efficientismo
È l’ossessiva ricerca dell’efficienza e della produttività perseguite a qualunque costo. Il termine ha qui una connotazione critica in quanto non si riferisce
tanto al sano desiderio di svolgere con cura il proprio lavoro, quanto piuttosto a una mentalità esasperata che antepone l’efficienza a valori come il benessere
delle persone o la qualità del lavoro.
e dalla competizione esasperata, ammettere che siamo tutti deboli e vulnerabili. Secondo il razionalismo imperante,
che contiene o addirittura nega la nostra parte emotiva, è difficile accettare questo dato di fatto. Fino a quando situazioni estreme e impreviste non ci pongono di fronte agli
interrogativi di senso: “perché il dolore, la sofferenza, la morte?”, tendiamo dunque a evitarli, per paura di affrontarli.
L’essere umano si pone da sempre il problema di come agire di fronte al dolore.
Il filosofo tedesco Karl Jaspers (1883-1969) identifica due atteggiamenti che l’uomo assume di fronte alla sofferenza: combatterla (approccio tipico della medicina moderna) oppure eluderla.
Un altro filosofo tedesco, Hans-Georg Gadamer (1900-2002), suggerisce però una terza via: il risveglio dell’esistenza attraverso il dolore, forse la vera chiave della salute.
Come osserva il filosofo italiano Salvatore Natoli (1942), l’esperienza del dolore, sia esso fisico o psichico, ci offre, infatti, una conoscenza unica e irriducibile, spingendoci a
trasformare la nostra percezione del mondo e a ridefinire le nostre priorità.
La società attuale, almeno nel mondo occidentale, non è abituata all’idea della morte: il Dalai Lama Tenzin Gyatso (1935), guida spirituale dei buddhisti, ha affermato che
«gli uomini dell’Occidente vivono come se non dovessero morire mai e muoiono come se non avessero mai vissuto». Parlando di “uomini dell’Occidente”, egli intende porre l’attenzione
su uno stile di vita che, minimizzando la morte, tende a minimizzare anche la vita.
Tuttavia, l’esperienza del dolore e dell’angoscia circa l’esito di una malattia può farci acquisire una maggiore autoconsapevolezza e può indurci a percepire diversamente e in modo
più approfondito noi stessi e il mondo che ci circonda.
Accedere alla verità della condizione umana comporta riconoscersi esposti al dolore, alla fragilità determinata dalle malattie, alla morte e accettare il fatto di non essere eterni.
Si tratta di una consapevolezza difficile e comprensibilmente molto penosa, ma che ci rende pienamente umani.
Il filosofo tedesco Martin Heidegger (1889-1976) ha evidenziato come l’angoscia scaturita dalla consapevolezza della nostra finitudine possa avere un’accezione positiva, poiché rende
rilevanti le scelte che compiamo e quindi autentica l’esistenza. Riconoscere la temporalità della vita umana ci permette di attribuirle senso e valore, spingendoci a definire obiettivi
concreti da perseguire.
Evelyn De Morgan, L'angelo della morte, 1881.


La fragilità della condizione umana è un argomento centrale nelle diverse culture, per lo meno da quando l’uomo ha cominciato a lasciare traccia scritta di sé.
Persino nel testo sacro della religione ebraico-cristiana è frequente il tema dell’inconsistenza dell’essere umano, che è “polvere”
(Siracide 33, 10),
“erba del campo”
(Salmo 103, 15-16)
e “soffio” (Salmo 144, 4).
L’uomo è un nulla di fronte all’immensità e alla potenza di Dio.
Tuttavia, per i cristiani la morte non è la fine, ma una seconda nascita: secondo la loro fede, la speranza è legata al fatto
che il Cristo, risorgendo, ha sconfitto la morte. Senza questa speranza fondamentale sarebbe vana la fede cristiana
(1 Corinzi 15, 12-20).
Eppure, per Gesù stesso, il timore della sofferenza e della morte è tale da farlo sudare sangue nell’Orto degli ulivi: nella sua piena umanità,
l’esperienza del dolore e della fine è straziante.
E lo stesso capita per chi ha fede: nel libro di Isaia, per esempio, troviamo un’ampia narrazione incentrata sul re Ezechia, afflitto da una
malattia mortale e profondamente angosciato perché capisce che la fine è imminente. Tuttavia, l’intervento di Dio lo risana e, dal lamento,
le sue parole si trasformano in lode del Signore della vita, evidenziando il percorso interiore che dalla disperazione conduce alla speranza
(Isaia 38).
Maestro di San Ildefonso, La Resurrezione di Cristo, XV secolo.